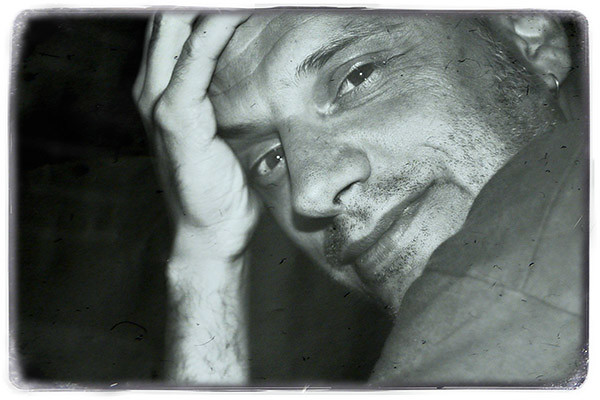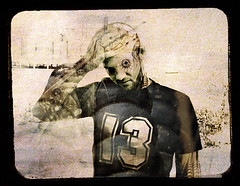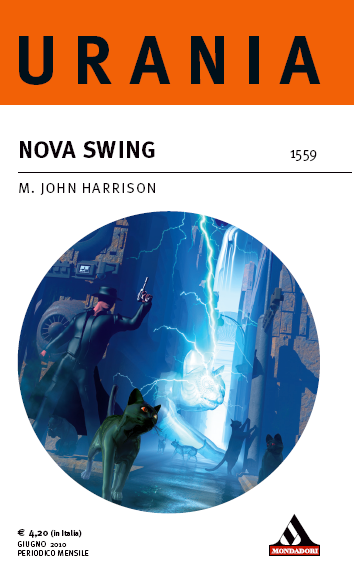Geoff Dyer - Paris Trance
Ma che libro inutile Paris Trance. Non so nemmeno più cosa mi ha attirato verso questo volume, forse un equivoco sul nome dell'autore, forse la fiducia nell'editore (finora Instar non mi aveva mai deluso). Se ho deciso di leggerlo quest'estate, dopo anni di limbo sullo scaffale dei libri in attesa di lettura, è stato per prepararmi alla nostra vacanza francese, probabilmente a causa del titolo e del bugiardino. Di sicuro mi aspettavo qualcosa di più.
In questo romanzo si raccontano le vite di quattro tizi di cui non mi sarebbe potuto importare meno, delle loro chiacchiere a proposito di cinema e altre amenità, del loro perdere tempo da stranieri a Parigi senza nulla di interessante da comunicare. Il tutto condito con qualche scena di sesso e un sacco di buchi nei momenti potenzialmente più interessanti, con immagini potenti e retoriche gettate in faccia al lettore senza alcuno sforzo di approfondimento (il cervo sanguinante, cazzo!), e un senso di progressiva noia e irritazione man mano che si procede nella lettura.
Se mai m'è capitato di leggere un romanzo fighetto, e per romanzo fighetto intendo quel genere di libro in cui l'autore fa di tutto per convincerti di essere migliore di lettore e personaggi, forte di premesse valide solo nella sua testa (che queste siano il suo presunto talento d'autore, il contenuto imprescindibile del suo testo o la qualità della sua scrittura, è un dettaglio irrilevante al fine del risultato) sbattendosene allegramente di ogni altro aspetto del suo operato, beh… Paris Trance è quel romanzo.
Jonathan Lethem - Chronic City
L'ho già detto quanto ammiro e rispetto Jonathan Lethem? Chronic City è l'ultimo tassello in un percorso che mi pare sempre più chiaro e delineato, che parte dalla fantascienza e arriva alla ridefinizione del quotidiano, passando per il recupero della memoria e il tentativo mai concluso di riconciliare gli opposti aspetti della nostra realtà condivisa.
In Chronic City si assiste al mirabile equilibrismo di Chase Insteadman, ex ragazzo d'oro della televisione americana, preso in mezzo tra tensioni controculturali e sfoggio di potere, tra la vita di strada e quella di Park Avenue, in una città, New York, presa d'assalto da forze incomprensibli e preda di se stessa.
Jonathan Lethem cerca l'ennesima sintesi tra arte e vita, tra ideale e pratica, tra conoscenza e pregiudizio, cercando di accostarsi al potere che muove le cose senza rimanerne soffocato. E lo fa con un garbo e un'umiltà inconsueta, con una compassione per il destino dei suoi personaggi che non diventa mai patetica o paternalista, che vira anzi verso un'apparente freddezza, per rendere accessibile al lettore una zona del disastro che risulterebbe altrimenti insopportabile.
In effetti nella New York messa in scena da Jonathan Lethem mi pare riecheggi molto dello spirito catastrofico ballardiano, con una differenza fondamentale: tanto le rappresentazioni dell'autore inglese erano cliniche, glaciali e distaccate, tanto quelle dell'americano risultano emozionanti e partecipate. Come se Lethem avesse deciso di esplorare la zona dall'interno, rifiutando il ruolo di semplice osservatore, cercando come Ballard di penetrare i meccanismi del spazio interno ribaltandoli nell'architettura della città e nelle relazioni tra i suoi abitanti, ma lasciando che l'umanità randagia delle sue storie sporchi (e arricchisca!) il panorama, piuttosto che offrircene uno spaccato documentaristico scevro di ogni possibilità di redenzione.
Chronic City è un racconto sul destino della nostra civiltà, sulle contraddizioni che la mantengono al limite dal suicidio, a guardare il cielo, a riconoscere uno schema, e quindi a costruirci sopra, costi quel che costi.
Chronic City è un tentativo di sopravvivenza.
…
04 ottobre 2010
27 settembre 2010
Weird Tales in italiano?

La settimana scorsa mi è arrivata la consueta newsletter dalla Wildside Press, editore americano di Weird Tales.
Tra le altre cose riportava, non troppo evidenziata, questa succosa notizia:
"An Italian-languaged edition of Weird Tales will be appearing soon, so international readers will have another option in months to come."
Ho provato a fare una rapida ricerca in rete ma tutto tace.
Voi ne sapete qualcosa di più?
…
21 settembre 2010
Giallo vs. Fantascienza
La settimana scorsa tutto il mio (poco) tempo libero dedicato alla rete se n'è andato in una lunga e accesa discussione sulla Mailing List di Fantascienza (FML) che partendo dai tagli ai romanzi pubblicati da Urania è arrivata - inevitabilmente, visto che sull'argomento non riesco a proprio a tacere - a parlare di come la rivista mondadoriano abbia contribuito a plasmare la fantascienza italiana.
Tra i vari spunti dibattuti in lista la questione "giallo vs fantascienza" merita un trattamento privilegiato, perché in effetti è l'argomento che più spesso viene evocato per respingere la mia tesi secondo cui l'ingombrante presenza di Urania in edicola ha di fatto impedito il formarsi di una nuova generazione di lettori di fantascienza frustrando ogni tentativo editoriale che si proponesse di (ri)portare il genere in libreria (per approfondire ecco i soliti link: 1, 2 e 3).
Scrive Paolo:
"Alla fantascienza manca tutto quell'hype, quella carica e massa critica che invece ha avuto il giallo. Che pure, da narrativa di genere, piena di personaggi improbabili e maggiordomi assassini, è diventato ben accetto non solo dai lettori abituali, ma pure da tutti gli editori.
Chi ha decretato il successo del /giallo/ in Italia? I lettori del giallo mondadori che chiedevano più qualità? Sandrone Dazieri, se non ricordo male un incontro da Tecla, diceva che il lettore del GM è tradizionalista come (più) di quello di Urania, e se gli proponi un qualcosa di strano, innovativo, etc, te lo tirano dietro.
Ma allora, da dove arrivano i lettori e le collane da libreria?"
Perché dunque al giallo è riuscito il salto dall'edicola alla libreria, e alla fantascienza no? Perché il genere giallo ha mantenuto, se non accresciuto, il suo parco lettori e invece noi che leggiamo fantascienza siamo una specie in via d'estinzione?
Provo si seguito ad abbozzare una risposta. Ogni ulteriore elemento è come sempre benvenuto.
Sono convinto che il successo del giallo presso il pubblico generalista dipenda da quelle caratteristiche intrinseche al genere che lo rendono lettura decisamente più accessibile di quanto succeda generalmente con qualsiasi opera fantascientifica.
Nel genere giallo il lettore ha a che fare con una realtà che non richiede nessuna particolare collaborazione da pare sua per essere compresa, un ambiente che per quanto possa essere lontano (geograficamente, socialmente, culturalmente) mantiene intatti e comprensibili la maggior parte dei riferimenti.
L'approccio del lettore ad un'opera fantascientifica è in genere decisamente più complesso. Una storia che si svolge in un'altra realtà, per quanto quest'ultima possa essere legata a quella condivisa dal lettore, lo costringendo comunque a ricalibrare i sui parametri e ad esercitare uno sforzo di comprensione maggiore del suo omologo lettore di gialli.
Altro elemento che agevola il consumo di letteratura gialla e che rende i suoi romanzi tra le letture più rilassanti e scacciapensieri - di fatto l'unica letteratura popolare sopravvissuta al nuovo millennio (insieme a quella rosa) - è l'estrema canonicità di storie, personaggi, ambienti.
Le trame caratteristiche delle storie gialle, procedendo immancabilmente verso una conclusione definitiva, che riporta ordine partendo da una situazione caotica, sono di fatto conservative e consolatorie.
Non che storie di questo tipo non siano tipiche anche di molta fantascienza. La differenza fondamentale sta però nell'impossibilità per il lettore di stabilire a priori il canone cui si rifà quella determinata storia fantascientifica.
Per aggiungere difficoltà a difficoltà si aggiunge anche il linguaggio, che per molta della fantascienza attuale è legato a doppio filo con le frange più d'avanguardia e speculative di scienza e tecnologia, che spesso necessitano di un alfabeto - o almeno di un lessico - non sempre condiviso con il lettore generalista.
Detto in altre parole, la fantascienza, al contrario del giallo, non è più letteratura popolare.
La fantascienza è diventato un genere letterario che può soddisfare solo una nicchia del pubblico dei lettori. Trattarlo, qui e ora, nel 2010, come se i suoi numi tutelari fossero ancora Asimov, per i lettori di bocca buona, e Dick, per quelli più sofisticati, significa aver perso di vista quello che il genere sta offrendo ai suoi lettori nel resto del mondo. Significa ignorare l'esistenza potenziale di un pubblico che non sa nemmeno cosa si sta perdendo. Significa soprattutto aver chiuso gli occhi al futuro, ed essere destinati per questo al suicidio editoriale.
…
Tra i vari spunti dibattuti in lista la questione "giallo vs fantascienza" merita un trattamento privilegiato, perché in effetti è l'argomento che più spesso viene evocato per respingere la mia tesi secondo cui l'ingombrante presenza di Urania in edicola ha di fatto impedito il formarsi di una nuova generazione di lettori di fantascienza frustrando ogni tentativo editoriale che si proponesse di (ri)portare il genere in libreria (per approfondire ecco i soliti link: 1, 2 e 3).
Scrive Paolo:
"Alla fantascienza manca tutto quell'hype, quella carica e massa critica che invece ha avuto il giallo. Che pure, da narrativa di genere, piena di personaggi improbabili e maggiordomi assassini, è diventato ben accetto non solo dai lettori abituali, ma pure da tutti gli editori.
Chi ha decretato il successo del /giallo/ in Italia? I lettori del giallo mondadori che chiedevano più qualità? Sandrone Dazieri, se non ricordo male un incontro da Tecla, diceva che il lettore del GM è tradizionalista come (più) di quello di Urania, e se gli proponi un qualcosa di strano, innovativo, etc, te lo tirano dietro.
Ma allora, da dove arrivano i lettori e le collane da libreria?"
Perché dunque al giallo è riuscito il salto dall'edicola alla libreria, e alla fantascienza no? Perché il genere giallo ha mantenuto, se non accresciuto, il suo parco lettori e invece noi che leggiamo fantascienza siamo una specie in via d'estinzione?
Provo si seguito ad abbozzare una risposta. Ogni ulteriore elemento è come sempre benvenuto.
Sono convinto che il successo del giallo presso il pubblico generalista dipenda da quelle caratteristiche intrinseche al genere che lo rendono lettura decisamente più accessibile di quanto succeda generalmente con qualsiasi opera fantascientifica.
Nel genere giallo il lettore ha a che fare con una realtà che non richiede nessuna particolare collaborazione da pare sua per essere compresa, un ambiente che per quanto possa essere lontano (geograficamente, socialmente, culturalmente) mantiene intatti e comprensibili la maggior parte dei riferimenti.
L'approccio del lettore ad un'opera fantascientifica è in genere decisamente più complesso. Una storia che si svolge in un'altra realtà, per quanto quest'ultima possa essere legata a quella condivisa dal lettore, lo costringendo comunque a ricalibrare i sui parametri e ad esercitare uno sforzo di comprensione maggiore del suo omologo lettore di gialli.
Altro elemento che agevola il consumo di letteratura gialla e che rende i suoi romanzi tra le letture più rilassanti e scacciapensieri - di fatto l'unica letteratura popolare sopravvissuta al nuovo millennio (insieme a quella rosa) - è l'estrema canonicità di storie, personaggi, ambienti.
Le trame caratteristiche delle storie gialle, procedendo immancabilmente verso una conclusione definitiva, che riporta ordine partendo da una situazione caotica, sono di fatto conservative e consolatorie.
Non che storie di questo tipo non siano tipiche anche di molta fantascienza. La differenza fondamentale sta però nell'impossibilità per il lettore di stabilire a priori il canone cui si rifà quella determinata storia fantascientifica.
Per aggiungere difficoltà a difficoltà si aggiunge anche il linguaggio, che per molta della fantascienza attuale è legato a doppio filo con le frange più d'avanguardia e speculative di scienza e tecnologia, che spesso necessitano di un alfabeto - o almeno di un lessico - non sempre condiviso con il lettore generalista.
Detto in altre parole, la fantascienza, al contrario del giallo, non è più letteratura popolare.
La fantascienza è diventato un genere letterario che può soddisfare solo una nicchia del pubblico dei lettori. Trattarlo, qui e ora, nel 2010, come se i suoi numi tutelari fossero ancora Asimov, per i lettori di bocca buona, e Dick, per quelli più sofisticati, significa aver perso di vista quello che il genere sta offrendo ai suoi lettori nel resto del mondo. Significa ignorare l'esistenza potenziale di un pubblico che non sa nemmeno cosa si sta perdendo. Significa soprattutto aver chiuso gli occhi al futuro, ed essere destinati per questo al suicidio editoriale.
…
14 settembre 2010
Intervallo
Avrei dovuto proseguire l'elenco delle mie letture estive. Avrei voluto parlare di qualche film visto di recente e discutere di un paio di cose che mi continuano a ritornare in mente.
Ma siamo a settembre che dal punto di vista lavorativo è il mese peggiore dell'anno. Come se non bastasse mi sono lasciato coinvolgere in una discussione su voi-sapete-cosa all'interno della Mailing List di Fantascienza.
Insomma, se capitate da queste parti alla ricerca di qualche nuovo post o per discutere di qualche lettura o semplicemente perché non avevate niente di meglio da fare, beh… portate pazienza.
Prima o poi dovrei riuscire a postare qualcosa di nuovo.
…
Ma siamo a settembre che dal punto di vista lavorativo è il mese peggiore dell'anno. Come se non bastasse mi sono lasciato coinvolgere in una discussione su voi-sapete-cosa all'interno della Mailing List di Fantascienza.
Insomma, se capitate da queste parti alla ricerca di qualche nuovo post o per discutere di qualche lettura o semplicemente perché non avevate niente di meglio da fare, beh… portate pazienza.
Prima o poi dovrei riuscire a postare qualcosa di nuovo.
…
03 settembre 2010
Letture luglio/agosto 2010 - prima parte
Terry Pratchett - Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori
Terry Pratchett è uno di quei nomi che mi perseguita da quando sono sbarcato in rete e ho potuto annusare l'aria che tira tra gli appassionati di fantasy e fantascienza britannica. Leggevo le note che seguivano l'uscita dei vari romanzi con un misto di invidia e curiosità e non vedevo l'ora di poter metter le mani su qualche romanzo dell'autore inglese.
Quando però m'è capitato di leggere qualcuna delle prime traduzioni sbarcate in Italia, l'entusiasmo è via via calato. Sarà dipeso sicuramente dalla difficoltà di rendere nella nostra lingua la ricchezza di riferimenti e giochi di parole dell'inglese di Pratchett, ma alla lunga il suo umorismo, per quanto gradevole, tendeva ad annoiarmi.
Poi ho letto Good Omens e le cose sono cambiate: quel romanzo rientra tuttora nella mia personalissima top five dei libri più divertenti io abbia mai letto. Sulla copertina di quel libro, oltre al nome di Pratchett, c'era però anche quello di un tizio che avevo iniziato ad apprezzare dalla sua lunga frequentazione col Signore dei sogni. Forse per questo motivo nel mio giudizio il merito di quel libro se l'è preso in gran parte Neil Gaiman.
Ma il dubbio di aver sottovalutato Terry Pratchett non mi ha lasciato.
Almeno fino a un paio d'anni fa, quando ho finalmente visto la luce sotto forma di agile romanzo per ragazzi. L'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi è puro genio in abiti da fanciullo. Un romanzo capace di parlare della vita, l'universo e tutto quanto con la grazia di un numero da circo eseguito per pochi intimi. Un capolavoro capace di riabilitare in un sol colpo tutta la dozzinale letteratura fantasy scritta nel mondo nei decenni precedenti.
Ed è normale che dopo un libro del genere mi sia rimasta la voglia di leggerne ancora, di leggerne di più. Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori sembrava il titolo migliore per ritrovare lo stesso spirito che tanto avevo apprezzato in quel romanzo: meta-fantasy divertente con un occhio di riguardo per i giovani lettori ma nessun compromesso rispetto alla qualità della narrazione.
Diciamolo subito, Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori non raggiunge le vette de L'intrepida TIffany. Scritta un paio d'anni prima, la storia di Maurice, del suo amico pifferaio e della compagnia di topi con cui viaggiano è servita probabilmente a Pratchett per testare nuovi ambiti d'azione, e preparare il terreno per l'arrivo della ragazzina in cerca del fratellino scomparso. Ma non di meno Il prodigioso Maurice è un ottimo romanzo, che pur giocando con i cliché della favola e del fantasy non si riduce mai a satira o parodia, ma vive di una sua qualità autonoma, non disdegnando una capatina nei dintorni della paura, dell'inquietudine e di una realistica speranza.
Hal Clement - Stella Doppia 61 Cygni
Stella Doppia 61 Cygni è hard-sf d'epca, ma con un gran bel tiro e una miscela di avventura ed estrapolazione scientifica che resiste agilmente, nonostante i suoi quasi sessant'anni, ai rigori del tempo. Non sono un particolare fan della fantascienza rigorosa e ultraortodossa (in senso puramente scientifico) come questa di Hal Clement. L'hard-sf mi interessa di più quando l'estrapolazione scientifica si coniuga alla riflessione sulle ricadute umane del'innovazione tecnologica (vedi Egan e compagnia, tanto per intendersi), ma nonostante tutto Stella Doppia 61 Cygni m'è piaciuto, forse proprio per la sua natura di meccanismo perfettamente oliato e a prova d'errore, senza nessun altro impegno se non quello della fedeltà alle leggi universali della gravitazione.
Jeffrey Ford - La forma dell'ombra
Meraviglie della rete. Questo libro mi è stato spedito da Jeffrey Ford in persona, con tanto di firma autografa, grazie alla generosa intercessione di Marco, che in questo modo mi ha obbligato a leggerlo e a parlarne.
Lo dico subito, La forma dell'ombra non mi ha convinto. Il dubbio è che più degli eventuali difetti del romanzo contino nel mio giudizio le mie idiosincrasie di lettore, che non ne può più di romanzi per adulti con protagonisti che vanno ancora alle elementari e che, per non farsi mancar nulla, hanno pure il loro bel serial killer maniaco del caso.
Andiamo con ordine. La forma dell'ombra parte alla fine di un imprecisata estate intorno alla metà degli anni sessanta e racconta il mistero di un oscura presenza che porta l'angoscia e il terrore nel paese del giovane protagonista, che con i suoi due fratelli cerca di risolvere il problema, rimanendone invece sempre più invischiato, cercando contemporaneamente di sopravvivere alla scuola e ai bulli del paese.
Tralasciando ogni commento sulla traduzione del romanzo (specialmente quella della prima parte, in cui ci sono frasi e situazioni che ho fatto davvero fatica a decifrare) a me pare che il punto di forza della storia sia la resa della famiglia del protagonista. Famiglia che nonostante i suoi evidenti limiti - per tutto il corso del romanzo sarà caratterizzata più per le sue assenze, che non per il suo ruolo di guida e protezione - assurge progressivamente a polo positivo della vicenda in contrapposizione all'ingombrante presenza dell'esterno, la cui ansia di controllo e repressione (che provenga dalla scuola, dal vicinato o dallo stesso uomo nero che perseguita il paese) è il vero ostacolo al bisogno di spazio e autonomia dei ragazzi di cui seguiamo le vicende.
Uno dei punti deboli della vicenda sta nella caratterizzazione e nella gestione del cattivo che, nonostante l'efferatezza dei suoi crimini, appare essere in definitiva assai meno pericoloso dei compagni di classe del protagonista, dimostrandosi soprattutto parecchio stupido, a giudicare almeno da quanto è dato sapere sulle sue scelte e sui suoi comportamenti.
Il difetto sostanziale del romanzo sta però nella decisione dell'autore di tirare in ballo il fantastico per risolvere e chiudere la vicenda.
Su questo punto un approfondimento mi pare obbligatorio.
Credo di essere in grado di accettare qualsiasi evento meraviglioso l'autore decida di propinarmi anzi, l'intromissione del fantastico in una storia apparentemente mainstream è una perversione narrativa che apprezzo molto! A patto però che l'aspetto soprannaturale non sia una semplice stampella messa lì a sorreggere una storia che altrimenti si affloscerebbe.
La forma dell'ombra si situa a metà del guado. Da una lato l'autore sfrutta ottimamente le capacità speciali della sorellina del protagonista per aggiungere prospettive inedite e qualche turbamento alla narrazione, dall'altro c'è la decisione di risolvere il thriller con una scorciatoia (non approfondisco per non rovinare la sorpresa ai lettori) che spegne la storia senza offrire in cambio nulla di indispensabile dal punto di vista della narrazione o di altrettanto potente dal punto di vista emotivo. In mezzo ritroviamo diversi episodi che vorrebbero incuriosire (o inquietare) ma che invece distraggono sia dal realismo esasperato dei rapporti del nucleo familiare del protagonista, sia da un possibile esito esplicitamente fantastico della vicenda.
Il risultato è che arrivato a fine lettura non riesco a giudicare se Jeffrey Ford sia stato troppo onesto, rischiando le debolezze della confezione thillerosa per racchiudere tutta la vicenda in una scatola fatta di memorie infantili (notoriamente fallaci) o troppo furbo, puntando sul facile appeal che da sempre spettri e fanciulli esercitano sul lettore sensibile.
Ma forse La forma dell'ombra è semplicemente un buon romanzo senza troppe ambizioni e sono io ad essere rimasto vittima di qualche menata e pregiudizio di troppo.
Leggetelo, e fatemi sapere la vostra opinione.
Gardner Dozois (a cura di) - Il meglio della SF/II
Seconda parte del volume che raccoglie il meglio delle raccolte annuali dedicate ai migliori racconti fantascientifici curate da Gardner Dozois dal 1985 al 2005.
Qui c'è il meglio del meglio quindi, se siete curiosi di conoscere cosa abbia prodotto la letteratura di fantascienza negli ultimi tempi, questo è il volume giusto.
Poi certo, messo di fronte al dover compilare un'antologia come questa ogni appassionato avrebbe stilato una lista diversa. Ma Gardner Dozois è un uomo di buon gusto e vaste conoscenze e le sue scelte sono degne di rispetto (forse il vincolo più stringente di questa antologia è il limite di un singolo racconto per ogni autore presente). In ogni caso se pure nel suo elenco avrei cambiato qualche titolo, non gliene faccio certo una colpa.
Ma qua si sta cercando il pelo nell'uovo, che da qualsiasi prospettiva la si guardi Il meglio della SF è davvero un'antologia superlativa.
…
Terry Pratchett è uno di quei nomi che mi perseguita da quando sono sbarcato in rete e ho potuto annusare l'aria che tira tra gli appassionati di fantasy e fantascienza britannica. Leggevo le note che seguivano l'uscita dei vari romanzi con un misto di invidia e curiosità e non vedevo l'ora di poter metter le mani su qualche romanzo dell'autore inglese.
Quando però m'è capitato di leggere qualcuna delle prime traduzioni sbarcate in Italia, l'entusiasmo è via via calato. Sarà dipeso sicuramente dalla difficoltà di rendere nella nostra lingua la ricchezza di riferimenti e giochi di parole dell'inglese di Pratchett, ma alla lunga il suo umorismo, per quanto gradevole, tendeva ad annoiarmi.
Poi ho letto Good Omens e le cose sono cambiate: quel romanzo rientra tuttora nella mia personalissima top five dei libri più divertenti io abbia mai letto. Sulla copertina di quel libro, oltre al nome di Pratchett, c'era però anche quello di un tizio che avevo iniziato ad apprezzare dalla sua lunga frequentazione col Signore dei sogni. Forse per questo motivo nel mio giudizio il merito di quel libro se l'è preso in gran parte Neil Gaiman.
Ma il dubbio di aver sottovalutato Terry Pratchett non mi ha lasciato.
Almeno fino a un paio d'anni fa, quando ho finalmente visto la luce sotto forma di agile romanzo per ragazzi. L'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi è puro genio in abiti da fanciullo. Un romanzo capace di parlare della vita, l'universo e tutto quanto con la grazia di un numero da circo eseguito per pochi intimi. Un capolavoro capace di riabilitare in un sol colpo tutta la dozzinale letteratura fantasy scritta nel mondo nei decenni precedenti.
Ed è normale che dopo un libro del genere mi sia rimasta la voglia di leggerne ancora, di leggerne di più. Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori sembrava il titolo migliore per ritrovare lo stesso spirito che tanto avevo apprezzato in quel romanzo: meta-fantasy divertente con un occhio di riguardo per i giovani lettori ma nessun compromesso rispetto alla qualità della narrazione.
Diciamolo subito, Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori non raggiunge le vette de L'intrepida TIffany. Scritta un paio d'anni prima, la storia di Maurice, del suo amico pifferaio e della compagnia di topi con cui viaggiano è servita probabilmente a Pratchett per testare nuovi ambiti d'azione, e preparare il terreno per l'arrivo della ragazzina in cerca del fratellino scomparso. Ma non di meno Il prodigioso Maurice è un ottimo romanzo, che pur giocando con i cliché della favola e del fantasy non si riduce mai a satira o parodia, ma vive di una sua qualità autonoma, non disdegnando una capatina nei dintorni della paura, dell'inquietudine e di una realistica speranza.
Hal Clement - Stella Doppia 61 Cygni
Stella Doppia 61 Cygni è hard-sf d'epca, ma con un gran bel tiro e una miscela di avventura ed estrapolazione scientifica che resiste agilmente, nonostante i suoi quasi sessant'anni, ai rigori del tempo. Non sono un particolare fan della fantascienza rigorosa e ultraortodossa (in senso puramente scientifico) come questa di Hal Clement. L'hard-sf mi interessa di più quando l'estrapolazione scientifica si coniuga alla riflessione sulle ricadute umane del'innovazione tecnologica (vedi Egan e compagnia, tanto per intendersi), ma nonostante tutto Stella Doppia 61 Cygni m'è piaciuto, forse proprio per la sua natura di meccanismo perfettamente oliato e a prova d'errore, senza nessun altro impegno se non quello della fedeltà alle leggi universali della gravitazione.
Jeffrey Ford - La forma dell'ombra
Meraviglie della rete. Questo libro mi è stato spedito da Jeffrey Ford in persona, con tanto di firma autografa, grazie alla generosa intercessione di Marco, che in questo modo mi ha obbligato a leggerlo e a parlarne.
Lo dico subito, La forma dell'ombra non mi ha convinto. Il dubbio è che più degli eventuali difetti del romanzo contino nel mio giudizio le mie idiosincrasie di lettore, che non ne può più di romanzi per adulti con protagonisti che vanno ancora alle elementari e che, per non farsi mancar nulla, hanno pure il loro bel serial killer maniaco del caso.
Andiamo con ordine. La forma dell'ombra parte alla fine di un imprecisata estate intorno alla metà degli anni sessanta e racconta il mistero di un oscura presenza che porta l'angoscia e il terrore nel paese del giovane protagonista, che con i suoi due fratelli cerca di risolvere il problema, rimanendone invece sempre più invischiato, cercando contemporaneamente di sopravvivere alla scuola e ai bulli del paese.
Tralasciando ogni commento sulla traduzione del romanzo (specialmente quella della prima parte, in cui ci sono frasi e situazioni che ho fatto davvero fatica a decifrare) a me pare che il punto di forza della storia sia la resa della famiglia del protagonista. Famiglia che nonostante i suoi evidenti limiti - per tutto il corso del romanzo sarà caratterizzata più per le sue assenze, che non per il suo ruolo di guida e protezione - assurge progressivamente a polo positivo della vicenda in contrapposizione all'ingombrante presenza dell'esterno, la cui ansia di controllo e repressione (che provenga dalla scuola, dal vicinato o dallo stesso uomo nero che perseguita il paese) è il vero ostacolo al bisogno di spazio e autonomia dei ragazzi di cui seguiamo le vicende.
Uno dei punti deboli della vicenda sta nella caratterizzazione e nella gestione del cattivo che, nonostante l'efferatezza dei suoi crimini, appare essere in definitiva assai meno pericoloso dei compagni di classe del protagonista, dimostrandosi soprattutto parecchio stupido, a giudicare almeno da quanto è dato sapere sulle sue scelte e sui suoi comportamenti.
Il difetto sostanziale del romanzo sta però nella decisione dell'autore di tirare in ballo il fantastico per risolvere e chiudere la vicenda.
Su questo punto un approfondimento mi pare obbligatorio.
Credo di essere in grado di accettare qualsiasi evento meraviglioso l'autore decida di propinarmi anzi, l'intromissione del fantastico in una storia apparentemente mainstream è una perversione narrativa che apprezzo molto! A patto però che l'aspetto soprannaturale non sia una semplice stampella messa lì a sorreggere una storia che altrimenti si affloscerebbe.
La forma dell'ombra si situa a metà del guado. Da una lato l'autore sfrutta ottimamente le capacità speciali della sorellina del protagonista per aggiungere prospettive inedite e qualche turbamento alla narrazione, dall'altro c'è la decisione di risolvere il thriller con una scorciatoia (non approfondisco per non rovinare la sorpresa ai lettori) che spegne la storia senza offrire in cambio nulla di indispensabile dal punto di vista della narrazione o di altrettanto potente dal punto di vista emotivo. In mezzo ritroviamo diversi episodi che vorrebbero incuriosire (o inquietare) ma che invece distraggono sia dal realismo esasperato dei rapporti del nucleo familiare del protagonista, sia da un possibile esito esplicitamente fantastico della vicenda.
Il risultato è che arrivato a fine lettura non riesco a giudicare se Jeffrey Ford sia stato troppo onesto, rischiando le debolezze della confezione thillerosa per racchiudere tutta la vicenda in una scatola fatta di memorie infantili (notoriamente fallaci) o troppo furbo, puntando sul facile appeal che da sempre spettri e fanciulli esercitano sul lettore sensibile.
Ma forse La forma dell'ombra è semplicemente un buon romanzo senza troppe ambizioni e sono io ad essere rimasto vittima di qualche menata e pregiudizio di troppo.
Leggetelo, e fatemi sapere la vostra opinione.
Gardner Dozois (a cura di) - Il meglio della SF/II
Seconda parte del volume che raccoglie il meglio delle raccolte annuali dedicate ai migliori racconti fantascientifici curate da Gardner Dozois dal 1985 al 2005.
Qui c'è il meglio del meglio quindi, se siete curiosi di conoscere cosa abbia prodotto la letteratura di fantascienza negli ultimi tempi, questo è il volume giusto.
Poi certo, messo di fronte al dover compilare un'antologia come questa ogni appassionato avrebbe stilato una lista diversa. Ma Gardner Dozois è un uomo di buon gusto e vaste conoscenze e le sue scelte sono degne di rispetto (forse il vincolo più stringente di questa antologia è il limite di un singolo racconto per ogni autore presente). In ogni caso se pure nel suo elenco avrei cambiato qualche titolo, non gliene faccio certo una colpa.
Ma qua si sta cercando il pelo nell'uovo, che da qualsiasi prospettiva la si guardi Il meglio della SF è davvero un'antologia superlativa.
…
25 agosto 2010
Oops, I did it again…
Urania per me doveva rimanere un capitolo chiuso. Tutto quel che avevo da dire l'ho già detto anche troppe volte.
Però i fatti di questi giorni mi obbligano a tornare ancora sull'argomento.
Il motivo? La candida ammissione da parte del curatore di Urania che i romanzi pubblicati dalla collana mondadoriana subiscono tagli che possono arrivare fino al 15% del testo originale. Il che significa che una pagina su sette di quelle scritte dall'autore non verrà pubblicata e quindi letta dal pubblico uraniano.
Il motivo? Puramente economico. Nessuna censura, nessun giudizio di merito (si fa per dire), solo l'impossibilità da parte della rivista di superare un certo numero di pagine.
La candida confessione è stata accompagnata da un profluvio di gentilezze nei confronti dei lettori che avevano osato manifestare la loro sorpresa, indignazione e sì, addirittura protesta, sul blog della testata.
Il messaggio è chiaro: o vi leggete i volumi come ve li proponiamo o vi arrangiate. Se non vi va bene non venitecelo nemmeno a dire, che tanto la vostra opinione non ci interessa, anzi, ci annoia.
Io mi chiedo, e vorrei chiedere soprattutto al mio amico Giovanni che con Urania collabora fattivamente, fino a che punto si può considerare accettabile la manomissione di un testo originale da parte di un editore, dove è finito il diritto del lettore di lamentarsi di un prodotto che non corrisponde alle sue aspettative, quali sono i principi etici che governano la gestione di Urania (se ce ne sono…).
E poi Giovanni mi piacerebbe sapere qual è stata la tua reazione alla scoperta che la tanto esecrata pratica del taglio arbitrario del testo originale è stata riesumata da Urania proprio durante la gestione Lippi, che con tanto entusiasmo hai sempre difeso e sostenuto. Nessuna amarezza? Neanche un briciolo di delusione, di rabbia? Solo rassegnazione?
Dove tracci ora il tuo personale confine tra l'importanza della scrittura e le esigenze del mercato?
Immagino quali possano essere le risposte. L'impegno di Urania a pubblicare fantascienza che nessuna altro pubblica, la possibilità di leggere testi e autori altrimenti destinati all'oblio, la costante proposta di novità e classici che solo la testa uraniana propone al pubblico italiano. Che i limiti del mercato impongono scelte difficili, che si fa il possibile per portare a casa capra e cavoli. Che alla maggioranza del pubblico va bene così (tanto mica lo sa, no?)
Etc etc etc.
Ma non si era detto che la fantascienza era qualcosa di più di un tot di parole vendute a peso?
…
Però i fatti di questi giorni mi obbligano a tornare ancora sull'argomento.
Il motivo? La candida ammissione da parte del curatore di Urania che i romanzi pubblicati dalla collana mondadoriana subiscono tagli che possono arrivare fino al 15% del testo originale. Il che significa che una pagina su sette di quelle scritte dall'autore non verrà pubblicata e quindi letta dal pubblico uraniano.
Il motivo? Puramente economico. Nessuna censura, nessun giudizio di merito (si fa per dire), solo l'impossibilità da parte della rivista di superare un certo numero di pagine.
La candida confessione è stata accompagnata da un profluvio di gentilezze nei confronti dei lettori che avevano osato manifestare la loro sorpresa, indignazione e sì, addirittura protesta, sul blog della testata.
Il messaggio è chiaro: o vi leggete i volumi come ve li proponiamo o vi arrangiate. Se non vi va bene non venitecelo nemmeno a dire, che tanto la vostra opinione non ci interessa, anzi, ci annoia.
Io mi chiedo, e vorrei chiedere soprattutto al mio amico Giovanni che con Urania collabora fattivamente, fino a che punto si può considerare accettabile la manomissione di un testo originale da parte di un editore, dove è finito il diritto del lettore di lamentarsi di un prodotto che non corrisponde alle sue aspettative, quali sono i principi etici che governano la gestione di Urania (se ce ne sono…).
E poi Giovanni mi piacerebbe sapere qual è stata la tua reazione alla scoperta che la tanto esecrata pratica del taglio arbitrario del testo originale è stata riesumata da Urania proprio durante la gestione Lippi, che con tanto entusiasmo hai sempre difeso e sostenuto. Nessuna amarezza? Neanche un briciolo di delusione, di rabbia? Solo rassegnazione?
Dove tracci ora il tuo personale confine tra l'importanza della scrittura e le esigenze del mercato?
Immagino quali possano essere le risposte. L'impegno di Urania a pubblicare fantascienza che nessuna altro pubblica, la possibilità di leggere testi e autori altrimenti destinati all'oblio, la costante proposta di novità e classici che solo la testa uraniana propone al pubblico italiano. Che i limiti del mercato impongono scelte difficili, che si fa il possibile per portare a casa capra e cavoli. Che alla maggioranza del pubblico va bene così (tanto mica lo sa, no?)
Etc etc etc.
Ma non si era detto che la fantascienza era qualcosa di più di un tot di parole vendute a peso?
…
24 agosto 2010
Ted Chiang on Writing
"…the most likely reason for us to develop conscious software would be because it's fun, rather than because it's useful."
 Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.
Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.
Per saperne di più su Ted Chiang, sul suo modo di affrontare la scrittura di un racconto o sulle sue idee riguardo scienza e magia, nonché su intelligenza artificiale e videogiochi, vi segnalo quest'intervista apparsa su boingboing un mesetto fa.
(L'intervista è in inglese, ma mi pare molto comprensibile).
(Artwork from The Lifecycle of Software Objects by Christian Pearce.)
…
 Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.
Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.Per saperne di più su Ted Chiang, sul suo modo di affrontare la scrittura di un racconto o sulle sue idee riguardo scienza e magia, nonché su intelligenza artificiale e videogiochi, vi segnalo quest'intervista apparsa su boingboing un mesetto fa.
(L'intervista è in inglese, ma mi pare molto comprensibile).
(Artwork from The Lifecycle of Software Objects by Christian Pearce.)
…
23 agosto 2010
Ricominciamo
Sono tornato dalle vacanze già da qualche giorno, ma se ritornare alla routine domestica è stato relativamente facile, non altrettanto posso dire per la mia vita on-line.
Tra il riprendere le fila dei vecchi discorsi, aggiornarsi sui vari post degli amici in rete (ma cavoli! un po' di ferie anche voi no, eh?) e il semplice sforzo di mettersi a sedere davanti a un monitor (chi me lo fa fare, dopo tanti giorni in giro per il mondo?) è andata a finire che per aggiornare il blog ho aspettato il ritorno al lavoro, che in fondo qua, davanti al monitor, sono obbligato a starci.
Nelle ultime settimane abbiamo macinato più di 3000 chilometri tra Francia e Germania, visto più bestie di quanto sia umanamente sopportabile (beh, quasi…), fatto il nostro dovere di turisti all'estero (wow! la torre Eiffel, il Louvre, Legoland!), mangiato un sacco di baguette, bistecche e crauti (e scoperto che quelli francesi, anzi, alsaziani, sono più buoni di quelli tedeschi), speso un sacco di soldi (ma quanto costa il cibo - e il vino, e la birra! - in Francia?). Ci siamo insomma stremati di vacanze, ma divertendoci un sacco nel frattempo.
Tra queste pagine girano soprattutto amanti della fantascienza e dintorni, e allora ecco un piccolo inciso dedicato a loro. Io non leggo il francese ma non potevo certo risparmiarmi un giro in libreria.
In Francia gli scaffali dedicati alla letteratura fantastica sono ben forniti. In quanto a numeri, il fantasy batte la fantascienza, ma quest'ultima si difende bene (diciamo che il rapporto dei volumi presenti è compreso tra il 2 a 1 e il 3 a 2 a favore del primo, ma se eliminassimo i metri dedicati a cicli, ciclini e cicloni fantasy il numero di titoli è quasi alla pari). Tra le note positive l'abbondanza di volumi tascabili compresi in una fascia di prezzo tra i sette e i dodici euro, tra quelle negative il costo delle prime edizioni che è addirittura superiore a quelle italiane (si parla di cifre dai venti euro in su per volumi intorno alle 500 pagine), prezzo accompagnato da una qualità di carta e confezione decisamente inferiore a quella delle corrispettive edizioni nostrane.
I nomi degli autori più importanti sono tutti ben presenti, accompagnati da una discreta pattuglia di autori locali. Roba da far scorrere più di una lacrimuccia a qualsiasi appassionato abituato al panorama italiota.
Un'ultima nota libraria sul mondo parallelo delle pagine disegnate: da parecchio tempo ho smesso di leggere fumetti, ma la quantità spropositata di proposte presenti, sia nelle librerie sia nei negozi specializzati, mi ha fatto rimpiangere un pochino la scelta. In questo caso non leggere la lingua locale è stata una fortuna, che altrimenti sarebbe stato davvero difficile resistere alla tentazione di lasciare la carta di credito al suo destino.
Ora che siam tornati a casa non so quanto sono preparato a riaffrontare i ritmi della vita normale (si fa per dire…), ma beh… ci si prova. Nell'attesa della notte dell'iguana (info a breve - si spera - su questi, e altrui, schermi), nei prossimi giorni si ritornerà a parlare di libri (e di qualche film).
Restate sintonizzati.
…
Tra il riprendere le fila dei vecchi discorsi, aggiornarsi sui vari post degli amici in rete (ma cavoli! un po' di ferie anche voi no, eh?) e il semplice sforzo di mettersi a sedere davanti a un monitor (chi me lo fa fare, dopo tanti giorni in giro per il mondo?) è andata a finire che per aggiornare il blog ho aspettato il ritorno al lavoro, che in fondo qua, davanti al monitor, sono obbligato a starci.
Nelle ultime settimane abbiamo macinato più di 3000 chilometri tra Francia e Germania, visto più bestie di quanto sia umanamente sopportabile (beh, quasi…), fatto il nostro dovere di turisti all'estero (wow! la torre Eiffel, il Louvre, Legoland!), mangiato un sacco di baguette, bistecche e crauti (e scoperto che quelli francesi, anzi, alsaziani, sono più buoni di quelli tedeschi), speso un sacco di soldi (ma quanto costa il cibo - e il vino, e la birra! - in Francia?). Ci siamo insomma stremati di vacanze, ma divertendoci un sacco nel frattempo.
Tra queste pagine girano soprattutto amanti della fantascienza e dintorni, e allora ecco un piccolo inciso dedicato a loro. Io non leggo il francese ma non potevo certo risparmiarmi un giro in libreria.
In Francia gli scaffali dedicati alla letteratura fantastica sono ben forniti. In quanto a numeri, il fantasy batte la fantascienza, ma quest'ultima si difende bene (diciamo che il rapporto dei volumi presenti è compreso tra il 2 a 1 e il 3 a 2 a favore del primo, ma se eliminassimo i metri dedicati a cicli, ciclini e cicloni fantasy il numero di titoli è quasi alla pari). Tra le note positive l'abbondanza di volumi tascabili compresi in una fascia di prezzo tra i sette e i dodici euro, tra quelle negative il costo delle prime edizioni che è addirittura superiore a quelle italiane (si parla di cifre dai venti euro in su per volumi intorno alle 500 pagine), prezzo accompagnato da una qualità di carta e confezione decisamente inferiore a quella delle corrispettive edizioni nostrane.
I nomi degli autori più importanti sono tutti ben presenti, accompagnati da una discreta pattuglia di autori locali. Roba da far scorrere più di una lacrimuccia a qualsiasi appassionato abituato al panorama italiota.
Un'ultima nota libraria sul mondo parallelo delle pagine disegnate: da parecchio tempo ho smesso di leggere fumetti, ma la quantità spropositata di proposte presenti, sia nelle librerie sia nei negozi specializzati, mi ha fatto rimpiangere un pochino la scelta. In questo caso non leggere la lingua locale è stata una fortuna, che altrimenti sarebbe stato davvero difficile resistere alla tentazione di lasciare la carta di credito al suo destino.
Ora che siam tornati a casa non so quanto sono preparato a riaffrontare i ritmi della vita normale (si fa per dire…), ma beh… ci si prova. Nell'attesa della notte dell'iguana (info a breve - si spera - su questi, e altrui, schermi), nei prossimi giorni si ritornerà a parlare di libri (e di qualche film).
Restate sintonizzati.
…
03 agosto 2010
Si parte
Sistemati i mici, preparate le valigie, scelta la musica.
Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è notte e no, non abbiamo gli occhiali da sole.
Insomma, ancora qualche ora e poi si parte.
Ci sentiamo tra un paio di settimane. Nel frattempo fate a modo e cercate di godervela come meglio potete.
A presto!
…
Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è notte e no, non abbiamo gli occhiali da sole.
Insomma, ancora qualche ora e poi si parte.
Ci sentiamo tra un paio di settimane. Nel frattempo fate a modo e cercate di godervela come meglio potete.
A presto!
…
02 agosto 2010
Seconda visione - Fantascienza dalla Francia
Tra un paio di giorni saremo in Francia, ecco perché per questo giro di seconde visioni voglio recuperare quel che scrivevo a proposito di un paio di film di fantascienza francese usciti alla fine del secolo scorso.
È curioso vedere come a distanza di tempo l'importanza delle due pellicole sia cresciuta in maniera inversamente proporzionale agli investimenti fatti al momento delle rispettive uscite. Il primo di questi film è stato infatti lanciato con lo stesso dispendio di mezzi ed energie di solito riservati ai blockbuster hollywoodiani, mentre il secondo è stato difficile anche solo riuscire a vederlo.
Ma tant'è. Ecco quel che scrivevo all'epoca della visione de Il quinto elemento e de La città perduta.
IL QUINTO ELEMENTO
 Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;
Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;
Premessa 2: i film d'azione spettacolare mi divertono molto (mi sono divertito anche a vedere ID4, il che è tutto dire...);
Premessa 3: trovo che Bruce Willis abbia del carisma, pur non essendo certo il massimo come attore.
Svolgimento: Il quinto elemento è una palla mostruosa!
Probabilmente Besson ha dovuto accontentare troppe persone, o si è trovato costretto a fare un film che piacesse a tutti, boh... Per me il suo rimane un film anonimo, senza grinta e senza spunti.
Le uniche cose che ho apprezzato (tra l'altro le uniche che sapevano di sf) sono state l'ambientazione e i costumi. Per il resto mi chiedo ancora quale fosse il senso del film. Era forse un film d'azione? ma allora molto meglio un Die Hard qualsiasi. Una commedia ironica? ma lo avete visto quel capolavoro di Fuga da Los Angeles? un film di fantascienza? stiamo scherzando? era più fantascientifico Guerre Stellari.
Ed ecco i motivi per qui il film di Besson è (quasi) del tutto inguardabile:
1 - la storia non sta in piedi;
2 - i personaggi non stanno in piedi (e quando ci provano, cadono...);
3 - il ritmo sta in piedi, ma è un po' zoppicante, e questo non fa bene alle danze;*
4 - gli attori fanno quello che sono pagati per fare, ne più ne meno;
5 - il regista ha (aveva) le idee un bel po' confuse: manie di grandezza frustrate o produttori puntati alla schiena?
6 - c'è qualcuno che ha riso alle battute sparse a piene mani nel film?
7 - in definitiva qual'era il senso del film? a chiunque riesca a raccontarmi fedelmente il film senza scadere nel ridicolo i miei complimenti;
8 - era proprio necessaria la morale, nei 10 secondi finali?
E ora Tutto-Ciò-Che-Mi-È-Piaciuto nel V Elemento e che ho trovato Originale e/o Nuovo e/o Stimolante rispetto alla Restante Produzione Cinematografica Mondiale: le scenografie, i costumi.
* ritmo non è sinonimo di velocità. Perché il problema del Quinto Elemento non è la velocità. Il ritmo di un film è dettato dalla cadenza con cui si susseguono le varie scene, da come si spartiscono gli spazi dialoghi e sequenze d'azione, dal tempo dedicato all'uso di inquadrature diverse. Nel Quinto Elemento si susseguono un'accozzaglia di scene che prese singolarmente potevano anche avere un senso, una loro necessità. Il problema è la mancanza di amalgama (leggi sceneggiatura e regia) che avrebbe dovuto legare tali scene tra loro e aiutarle a raggiungere lo status di film. Conseguenza: noia mortale.
(1998)
LA CITTÀ PERDUTA
 Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.
Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.
Sul film ci sarebbe molto da dire, ma la cosa migliore è riguardarselo. Visivamente è straordinario, meraviglioso, eccezionale. La storia è semplice e la sceneggiatura perfetta, ma quello che colpisce è lo stile della regia: melodramma, comiche anni '20, cartoon e soprattutto sf (in cui la "s" più che per science sta per steam) in un mix strepitoso.
Spero abbiate avuto la fortuna di vederlo, altrimenti mettetevi in caccia, penso ci sia bisogno di film di fantascienza come questo.
(2000)
…
È curioso vedere come a distanza di tempo l'importanza delle due pellicole sia cresciuta in maniera inversamente proporzionale agli investimenti fatti al momento delle rispettive uscite. Il primo di questi film è stato infatti lanciato con lo stesso dispendio di mezzi ed energie di solito riservati ai blockbuster hollywoodiani, mentre il secondo è stato difficile anche solo riuscire a vederlo.
Ma tant'è. Ecco quel che scrivevo all'epoca della visione de Il quinto elemento e de La città perduta.
IL QUINTO ELEMENTO
 Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;
Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;
Premessa 2: i film d'azione spettacolare mi divertono molto (mi sono divertito anche a vedere ID4, il che è tutto dire...);
Premessa 3: trovo che Bruce Willis abbia del carisma, pur non essendo certo il massimo come attore.
Svolgimento: Il quinto elemento è una palla mostruosa!
Probabilmente Besson ha dovuto accontentare troppe persone, o si è trovato costretto a fare un film che piacesse a tutti, boh... Per me il suo rimane un film anonimo, senza grinta e senza spunti.
Le uniche cose che ho apprezzato (tra l'altro le uniche che sapevano di sf) sono state l'ambientazione e i costumi. Per il resto mi chiedo ancora quale fosse il senso del film. Era forse un film d'azione? ma allora molto meglio un Die Hard qualsiasi. Una commedia ironica? ma lo avete visto quel capolavoro di Fuga da Los Angeles? un film di fantascienza? stiamo scherzando? era più fantascientifico Guerre Stellari.
Ed ecco i motivi per qui il film di Besson è (quasi) del tutto inguardabile:
1 - la storia non sta in piedi;
2 - i personaggi non stanno in piedi (e quando ci provano, cadono...);
3 - il ritmo sta in piedi, ma è un po' zoppicante, e questo non fa bene alle danze;*
4 - gli attori fanno quello che sono pagati per fare, ne più ne meno;
5 - il regista ha (aveva) le idee un bel po' confuse: manie di grandezza frustrate o produttori puntati alla schiena?
6 - c'è qualcuno che ha riso alle battute sparse a piene mani nel film?
7 - in definitiva qual'era il senso del film? a chiunque riesca a raccontarmi fedelmente il film senza scadere nel ridicolo i miei complimenti;
8 - era proprio necessaria la morale, nei 10 secondi finali?
E ora Tutto-Ciò-Che-Mi-È-Piaciuto nel V Elemento e che ho trovato Originale e/o Nuovo e/o Stimolante rispetto alla Restante Produzione Cinematografica Mondiale: le scenografie, i costumi.
* ritmo non è sinonimo di velocità. Perché il problema del Quinto Elemento non è la velocità. Il ritmo di un film è dettato dalla cadenza con cui si susseguono le varie scene, da come si spartiscono gli spazi dialoghi e sequenze d'azione, dal tempo dedicato all'uso di inquadrature diverse. Nel Quinto Elemento si susseguono un'accozzaglia di scene che prese singolarmente potevano anche avere un senso, una loro necessità. Il problema è la mancanza di amalgama (leggi sceneggiatura e regia) che avrebbe dovuto legare tali scene tra loro e aiutarle a raggiungere lo status di film. Conseguenza: noia mortale.
(1998)
LA CITTÀ PERDUTA
 Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.
Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.Sul film ci sarebbe molto da dire, ma la cosa migliore è riguardarselo. Visivamente è straordinario, meraviglioso, eccezionale. La storia è semplice e la sceneggiatura perfetta, ma quello che colpisce è lo stile della regia: melodramma, comiche anni '20, cartoon e soprattutto sf (in cui la "s" più che per science sta per steam) in un mix strepitoso.
Spero abbiate avuto la fortuna di vederlo, altrimenti mettetevi in caccia, penso ci sia bisogno di film di fantascienza come questo.
(2000)
…
30 luglio 2010
I'm a loser baby, so why don't you kill me?
Speravo di riuscire a rimandare il tutto a dopo le vacanze, ma visto l'interesse che si spande per la rete come olio nel golfo del Messico, chi sono io per privarvi della mia indispensabile opinione? Molliamo gli indugi, che qua si parla di perdenti, falliti e scarti sociali in genere.
Tutto nasce da un'uscita strana di Elvezio Sciallis (vedi post su Shaun of the Dead, qui e su Malpertuis) e dai successivi dubbi su cosa sia un perdente e se un perdente si possa considerare tale, a prescindere dalla sua consapevolezza della propria condizione di perdente. La questione è stata poi rilanciata da un post di Davide Mana che riporta il discorso su un piano decisamente terreno.
Diciamolo subito. La figura del perdente è essenzialmente una figura retorica, un artificio narrativo, un utilissimo escamotage drammatico, ma nella vita vera il perdente non esiste.
In fondo voi, quanti perdenti conoscete? Nessuno, immagino, che sono sempre gli altri quelli che perdono.
Facciamo un passo indietro. Quand'è stata la prima volta che avete sentito il termine perdente riferito non a un evento sportivo ma alla riuscita della propria esistenza? Da quand'è che la vita si considera una gara?
Elementare (si fa per dire…): da quando il modello capitalista è uscito dalle sfere dell'alta finanza e dal suo guscio nordamericano per diffondersi capillarmente in ogni aspetto della nostra esistenza. Da quando abbiamo iniziato ad annusare il benessere e la carota in fondo al bastone è diventata sempre più concreta e reale. Da quando i vincitori hanno capito che senza gli sconfitti la vittoria non conta.
Non che prima del modello americano la competizione non esistesse, solo non aveva assunto quella componente totalizzante che la contraddistingue ora.
Ma se il perdente non esiste, la nostra percezione di vittoria o sconfitta sociale è vera e reale. Modulabile e modulare. Per ognuno di noi che non si sente adeguato alla gara sociale (di qualunque gara si tratti) c'è sempre qualcuno che se la passa peggio: per quello che non si può permettere il SUV c'è quello che gira con la Dacia, per l'impiegato frustrato c'è l'operaio alla catena, per quello che va in ferie a Rimini c'è quello che rimane a casa, per noi che leggiamo i libri c'è quello al bar con la gazzetta. La figura del Perdente è lo strumento di controllo sociale per eccellenza, scarica le frustrazioni verso il basso, riduce le responsabilità personali, consolida il ruolo del vincitore.
Detto questo, torniamo alla realtà del cinema e della letteratura, dove invece la figura del perdente non hai mai perso lo smalto che l'ha sempre contraddistinta. Del resto è molto comodo caratterizzare il dato personaggio per la sfiga che lo segna, fare assurgere quest'ultima a summa della sua esistenza per poi - a seconda del caso - ribaltarne le sorti in un finale catartico o farla sprofondare in un inferno senza vie d'uscita (meritato, ci mancherebbe!).
E qui diventerebbe interessante riflettere sulla potenza del simbolo "perdente", sulla sua elasticità d'utilizzo e sulla sua diffusione.
Io non ho gli strumenti per approfondire questo discorso, ma mi piacerebbe che qualcuno più dotato di me lo proseguisse.
Per concludere questo post sgangherato e frettoloso, mi rimane giusto il tempo per un'ultima nota sul concetto di beautiful loser, tanto caro a certa letteratura, a certo cinema. (Già il fatto di dover scrivere beautiful loser in inglese è significativo, che in italiano si rischia il ridicolo.)
Per quanto io possa aver amato quel film o quel libro, il beautiful loser è un personaggio odioso. Come altro definireste una persona che si crogiola nei suoi limiti e grazie ai suoi difetti ribalta la propria condizione? Fanculo. Molto meglio un tipo come Shaun, che riposta la mazza da cricket è pronto per un altro giro sulla ps, con birra e patatine e qualche zombie di contorno.
…
Tutto nasce da un'uscita strana di Elvezio Sciallis (vedi post su Shaun of the Dead, qui e su Malpertuis) e dai successivi dubbi su cosa sia un perdente e se un perdente si possa considerare tale, a prescindere dalla sua consapevolezza della propria condizione di perdente. La questione è stata poi rilanciata da un post di Davide Mana che riporta il discorso su un piano decisamente terreno.
Diciamolo subito. La figura del perdente è essenzialmente una figura retorica, un artificio narrativo, un utilissimo escamotage drammatico, ma nella vita vera il perdente non esiste.
In fondo voi, quanti perdenti conoscete? Nessuno, immagino, che sono sempre gli altri quelli che perdono.
Facciamo un passo indietro. Quand'è stata la prima volta che avete sentito il termine perdente riferito non a un evento sportivo ma alla riuscita della propria esistenza? Da quand'è che la vita si considera una gara?
Elementare (si fa per dire…): da quando il modello capitalista è uscito dalle sfere dell'alta finanza e dal suo guscio nordamericano per diffondersi capillarmente in ogni aspetto della nostra esistenza. Da quando abbiamo iniziato ad annusare il benessere e la carota in fondo al bastone è diventata sempre più concreta e reale. Da quando i vincitori hanno capito che senza gli sconfitti la vittoria non conta.
Non che prima del modello americano la competizione non esistesse, solo non aveva assunto quella componente totalizzante che la contraddistingue ora.
Ma se il perdente non esiste, la nostra percezione di vittoria o sconfitta sociale è vera e reale. Modulabile e modulare. Per ognuno di noi che non si sente adeguato alla gara sociale (di qualunque gara si tratti) c'è sempre qualcuno che se la passa peggio: per quello che non si può permettere il SUV c'è quello che gira con la Dacia, per l'impiegato frustrato c'è l'operaio alla catena, per quello che va in ferie a Rimini c'è quello che rimane a casa, per noi che leggiamo i libri c'è quello al bar con la gazzetta. La figura del Perdente è lo strumento di controllo sociale per eccellenza, scarica le frustrazioni verso il basso, riduce le responsabilità personali, consolida il ruolo del vincitore.
Detto questo, torniamo alla realtà del cinema e della letteratura, dove invece la figura del perdente non hai mai perso lo smalto che l'ha sempre contraddistinta. Del resto è molto comodo caratterizzare il dato personaggio per la sfiga che lo segna, fare assurgere quest'ultima a summa della sua esistenza per poi - a seconda del caso - ribaltarne le sorti in un finale catartico o farla sprofondare in un inferno senza vie d'uscita (meritato, ci mancherebbe!).
E qui diventerebbe interessante riflettere sulla potenza del simbolo "perdente", sulla sua elasticità d'utilizzo e sulla sua diffusione.
Io non ho gli strumenti per approfondire questo discorso, ma mi piacerebbe che qualcuno più dotato di me lo proseguisse.
Per concludere questo post sgangherato e frettoloso, mi rimane giusto il tempo per un'ultima nota sul concetto di beautiful loser, tanto caro a certa letteratura, a certo cinema. (Già il fatto di dover scrivere beautiful loser in inglese è significativo, che in italiano si rischia il ridicolo.)
Per quanto io possa aver amato quel film o quel libro, il beautiful loser è un personaggio odioso. Come altro definireste una persona che si crogiola nei suoi limiti e grazie ai suoi difetti ribalta la propria condizione? Fanculo. Molto meglio un tipo come Shaun, che riposta la mazza da cricket è pronto per un altro giro sulla ps, con birra e patatine e qualche zombie di contorno.
…
29 luglio 2010
Seconda visione - Fantasmi da Marte
Siamo a fine luglio e ho decisamente bisogno di ferie. Mi dispiace però lasciare il blog al suo destino. Ho deciso quindi di rispolverare qualche vecchia nota cinematografica - che chiamarle recensioni mi pare eccessivo - già girata in rete prima della nascita di queste pagine.
Prendetele per quel che valgono: un tuffo nel passato per ricordare qualche visione memorabile (nel bene e nel male) o un semplice riempitivo per rimpolpare queste pagine nell'attesa del risveglio del padrone di casa.
Partiamo con un classicone (si fa per dire), direttamente dal 2001.
Fantasmi da Marte di John Carpenter
Quali sono le caratteristiche del pulp? Del pulp fantascientifico almeno?
Avventura, veri uomini, donnine, mostri, sangue, esplosioni, dialoghi da paura... Altra caratteristica fondamentale: nel pulp non si butta via niente.
Tre righe di doverosa premessa per parlare della visione di quel filmazzo di Fantasmi da Marte di John Carpenter, che mi pare tragga l'ispirazione dritta dritta dal mondo dei pulp e del cinema minore.
Tutti i classici cliché dei film di serie B, tutte le idee dei precedenti film di Carpenter vengono frullate insieme per un risultato perfettamente godibile. C'è l'alieno tipo La Cosa, l'assedio a la Distretto 13, l'eroe cinico e cattivo alla Jena Plinskeen, le sparatorie alla Vampires (beh… queste ci sono un po' ovunque).
Peccato per qualche somiglianza di troppo con Pitch Black (coincidenza?), per il resto questo Fantasmi da Marte è un film da vedere con il volume a manetta, quintali di pop corn, birra fresca e rutto libero.
Ciliegina sulla torta una colonna sonora (scritta come sempre dallo stesso Carpenter) semplicemente perfetta per il clima del film.
Fantasmi da marte è un film grezzo, sporco, povero, senza menate e con poche pretese ma semplicemente divertente. Il cinema di Carpenter ha preso una bella piega: gli ultimi tre film sono tra i più divertenti nel genere che ho visto negli ultimi anni.
Altro che Tim Burton, se c'è un regista che ama il cosiddetto cinema di serie B è proprio John Carpenter.
(2001)
…
Prendetele per quel che valgono: un tuffo nel passato per ricordare qualche visione memorabile (nel bene e nel male) o un semplice riempitivo per rimpolpare queste pagine nell'attesa del risveglio del padrone di casa.
Partiamo con un classicone (si fa per dire), direttamente dal 2001.
Fantasmi da Marte di John Carpenter
Quali sono le caratteristiche del pulp? Del pulp fantascientifico almeno?
Avventura, veri uomini, donnine, mostri, sangue, esplosioni, dialoghi da paura... Altra caratteristica fondamentale: nel pulp non si butta via niente.
Tre righe di doverosa premessa per parlare della visione di quel filmazzo di Fantasmi da Marte di John Carpenter, che mi pare tragga l'ispirazione dritta dritta dal mondo dei pulp e del cinema minore.
Tutti i classici cliché dei film di serie B, tutte le idee dei precedenti film di Carpenter vengono frullate insieme per un risultato perfettamente godibile. C'è l'alieno tipo La Cosa, l'assedio a la Distretto 13, l'eroe cinico e cattivo alla Jena Plinskeen, le sparatorie alla Vampires (beh… queste ci sono un po' ovunque).
Peccato per qualche somiglianza di troppo con Pitch Black (coincidenza?), per il resto questo Fantasmi da Marte è un film da vedere con il volume a manetta, quintali di pop corn, birra fresca e rutto libero.
Ciliegina sulla torta una colonna sonora (scritta come sempre dallo stesso Carpenter) semplicemente perfetta per il clima del film.
Fantasmi da marte è un film grezzo, sporco, povero, senza menate e con poche pretese ma semplicemente divertente. Il cinema di Carpenter ha preso una bella piega: gli ultimi tre film sono tra i più divertenti nel genere che ho visto negli ultimi anni.
Altro che Tim Burton, se c'è un regista che ama il cosiddetto cinema di serie B è proprio John Carpenter.
(2001)
…
22 luglio 2010
Shaun Rulez!
Era da tempo che mi ripromettevo di spendere due parole su Shaun of the dead. Questo post di Elvezio Sciallis su Malpertuis me ne ha dato l'occasione. Data la difficoltà che ho in questi giorni nell'accedere alle sue pagine, preferisco riportare qui quello che sarebbe stato un semplice commento sul suo blog.
Shaun of the dead (L'alba dei morti dementi in italia) è una commedia romantica con gli zombie. Il film, scritto, diretto e interpretato da Edgar Wright e Simon Pegg, è un esempio eccezionale di quel che qualche buona idea, una grande passione per il genere e una geniale incoscienza possono produrre.
Probabilmente l'aspetto più straordinario della pellicola sta nella scelta degli autori di non scendere ad alcun compromesso, sia nella rappresentazione delle situazioni comico/romantiche, che sfoderano tutti i cliché della più classica delle pellicole inglesi degli ultimi anni (penso alla massa più o meno informe dei titoli interpretati da Hugh Grant), sia nella messa in scena dell'assalto dei non-morti, che non ha assolutamente nulla di buffo (ok, non più buffo della media dei film di zombie), rimanendo anzi piuttosto fedele all'iconografia romeriana classica.
È dallo scontro di queste due archetipi narrativi apparentemente incompatibili che il film trae tutta la sua energia.
Altro aspetto di Shaun of the dead che non smette di meravigliarmi è quello di essere un film comico-con-i-mostri che non scade mai nei collaudati meccanismi della parodia o del grottesco. Non so voi, ma io non ricordo film comico-horrorifici che si salvino dalla facile scelta parodistica (da Frankenstein Junior, passando per L'armata delle tenebre, scendendo fino ai vari Scary Movie). Mantenere l'equilibrio e camminare sulla sottile linea che separa il ridicolo dal comico, il romantico dal patetico, l'orrore dal semplice spavento, è un altro dei grandissimi meriti della pellicola.
Questo è anche il fattore principale che me lo fa preferire a Hot Fuzz, l'opera successiva del duo Wright-Pegg.
Elvezio nella sua recensione si dilunga - e come daragli torto? -sulle specificità britanniche del film e sul confronto vincente rispetto a pellicole omologhe prodotte oltreoceano. C'è però un punto su cui non sono d'accordo. A un certo punto scrive:
" La natura di “perdente” di Shaun è così distante dalla nozione tipica americana o italiana da essere a tratti incomprensibile e aliena, un feroce tunnel nel quale nemmeno le più ardue prove del fato riescono a cambiare la natura di un individuo (è sufficiente guardare il finale del film…)."
Questa lettura del film mi lascia un po' perplesso. A parte la distinzione tra perdenti inglesi, americani o italiani che mi risulta incomprensibile, il punto è ancora un altro: Shaun NON è un perdente. Un perdente, per essere tale, dovrebbe riconoscere la propria situazione. Dovrebbe lottare, e caso mai fallire, per raggiungere il Successo.
A Shaun invece la sua vita va bene così. Se c'è una necessità di cambiamento è affrontata di mala voglia e solo per uniformare il proprio standard alle richieste del mondo esterno (la fidanzata, la mamma). Ci sarebbe semmai da chiedersi perché nella recensione si giudica perdente l'atteggiamento di Shaun, ma si uscirebbe forse fuori tema.
Se vogliamo proprio dare una lettura socio-politica al film (ma dobbiamo?), Shaun è l'archetipo del trentenne qualunque cresciuto nelle periferie dell'occidente post-industriale (che sia inglese è del tutto accessorio). È uno zombie sociale che messo in gara con altri zombie sfodera le sue doti umane solo per la breve durata del confronto, che poi è molto più semplice, confortevole e soddisfacente ritornare all'abulica prassi quotidiana fatta di amici e birra al pub piuttosto che cedere, capitolando, alle lusinghe di famiglia e lavoro.
Per me è cosa piuttosto rara rivedere un film a distanza ravvicinata, Shaun of the dead l'ho visto tre volte negli ultimi anni.
Dite che m'è piaciuto?
…
Shaun of the dead (L'alba dei morti dementi in italia) è una commedia romantica con gli zombie. Il film, scritto, diretto e interpretato da Edgar Wright e Simon Pegg, è un esempio eccezionale di quel che qualche buona idea, una grande passione per il genere e una geniale incoscienza possono produrre.
Probabilmente l'aspetto più straordinario della pellicola sta nella scelta degli autori di non scendere ad alcun compromesso, sia nella rappresentazione delle situazioni comico/romantiche, che sfoderano tutti i cliché della più classica delle pellicole inglesi degli ultimi anni (penso alla massa più o meno informe dei titoli interpretati da Hugh Grant), sia nella messa in scena dell'assalto dei non-morti, che non ha assolutamente nulla di buffo (ok, non più buffo della media dei film di zombie), rimanendo anzi piuttosto fedele all'iconografia romeriana classica.
È dallo scontro di queste due archetipi narrativi apparentemente incompatibili che il film trae tutta la sua energia.
Altro aspetto di Shaun of the dead che non smette di meravigliarmi è quello di essere un film comico-con-i-mostri che non scade mai nei collaudati meccanismi della parodia o del grottesco. Non so voi, ma io non ricordo film comico-horrorifici che si salvino dalla facile scelta parodistica (da Frankenstein Junior, passando per L'armata delle tenebre, scendendo fino ai vari Scary Movie). Mantenere l'equilibrio e camminare sulla sottile linea che separa il ridicolo dal comico, il romantico dal patetico, l'orrore dal semplice spavento, è un altro dei grandissimi meriti della pellicola.
Questo è anche il fattore principale che me lo fa preferire a Hot Fuzz, l'opera successiva del duo Wright-Pegg.
Elvezio nella sua recensione si dilunga - e come daragli torto? -sulle specificità britanniche del film e sul confronto vincente rispetto a pellicole omologhe prodotte oltreoceano. C'è però un punto su cui non sono d'accordo. A un certo punto scrive:
" La natura di “perdente” di Shaun è così distante dalla nozione tipica americana o italiana da essere a tratti incomprensibile e aliena, un feroce tunnel nel quale nemmeno le più ardue prove del fato riescono a cambiare la natura di un individuo (è sufficiente guardare il finale del film…)."
Questa lettura del film mi lascia un po' perplesso. A parte la distinzione tra perdenti inglesi, americani o italiani che mi risulta incomprensibile, il punto è ancora un altro: Shaun NON è un perdente. Un perdente, per essere tale, dovrebbe riconoscere la propria situazione. Dovrebbe lottare, e caso mai fallire, per raggiungere il Successo.
A Shaun invece la sua vita va bene così. Se c'è una necessità di cambiamento è affrontata di mala voglia e solo per uniformare il proprio standard alle richieste del mondo esterno (la fidanzata, la mamma). Ci sarebbe semmai da chiedersi perché nella recensione si giudica perdente l'atteggiamento di Shaun, ma si uscirebbe forse fuori tema.
Se vogliamo proprio dare una lettura socio-politica al film (ma dobbiamo?), Shaun è l'archetipo del trentenne qualunque cresciuto nelle periferie dell'occidente post-industriale (che sia inglese è del tutto accessorio). È uno zombie sociale che messo in gara con altri zombie sfodera le sue doti umane solo per la breve durata del confronto, che poi è molto più semplice, confortevole e soddisfacente ritornare all'abulica prassi quotidiana fatta di amici e birra al pub piuttosto che cedere, capitolando, alle lusinghe di famiglia e lavoro.
Per me è cosa piuttosto rara rivedere un film a distanza ravvicinata, Shaun of the dead l'ho visto tre volte negli ultimi anni.
Dite che m'è piaciuto?
…
21 luglio 2010
Emergenza felina
Nell'arco di qualche settimana, due mesi fa, le due giovani gatte che vivono con noi (giovani per non confonderle con Tre Calzini, la micia veterana che certe cose non può proprio farle) hanno partorito una decina di micini.
Degli otto cuccioli che sono sopravvissuti (Wally, la gatta numero uno, ha avuto un parto prematuro, e due piccoli non ce l'hanno fatta), sei sembrava avessero trovato tutti in breve tempo un nuovo compagno umano da adottare, mentre gli ultimi due erano ancora alla ricerca di una nuova casa.
Poi però chi mi aveva garantito l'accoglienza a un cucciolo s'è tirato indietro (bell'amico, eh!), lasciandoci quindi
tuttora con tre cuccioli in cerca di ospitalità.
 Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.
Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.
Quindi fatevi avanti!
Potete venire a trovarci quando volete, in alternativa sono più che disposto a portarvi il micio che preferite fino a casa (perlomeno se abitate in Italia nei dintorni del 45° parallelo!).
I mici disponibili li vedete qui intorno.
Non sono meravigliosi?
(dimenticavo: per contattarmi in privato potete scrivermi all'indirizzo email: iguanajo (at) gmail.com)
…
Degli otto cuccioli che sono sopravvissuti (Wally, la gatta numero uno, ha avuto un parto prematuro, e due piccoli non ce l'hanno fatta), sei sembrava avessero trovato tutti in breve tempo un nuovo compagno umano da adottare, mentre gli ultimi due erano ancora alla ricerca di una nuova casa.
Poi però chi mi aveva garantito l'accoglienza a un cucciolo s'è tirato indietro (bell'amico, eh!), lasciandoci quindi
tuttora con tre cuccioli in cerca di ospitalità.
 Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.
Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.Quindi fatevi avanti!

Potete venire a trovarci quando volete, in alternativa sono più che disposto a portarvi il micio che preferite fino a casa (perlomeno se abitate in Italia nei dintorni del 45° parallelo!).
I mici disponibili li vedete qui intorno.
Non sono meravigliosi?
(dimenticavo: per contattarmi in privato potete scrivermi all'indirizzo email: iguanajo (at) gmail.com)
…
16 luglio 2010
I migliori romanzi di fantascienza dal 1990 (fino a qualche anno fa)
Nei commenti del post precedente ci si chiedeva quali siano stati i romanzi più significativi tra quelli pubblicati nel genere fantascienza negli ultimi vent'anni.
Quella che segue è la mia personalissima top ten dei volumi editi dal 1990 in poi. Le regole sono semplici: dieci titoli, un titolo per autore, esclusivamente romanzi (e quindi niente antologie, racconti e/o romanzi brevi), solo fantascienza.
Ovviamente questa classifica risponde unicamente ai miei gusti, non ha alcuna pretesa di oggettività ed è valida qui e ora, che se me la chiedeste tra un mese sarebbe probabilmente diversa.
Stilando la classifica mi sono reso conto che per quanto io mi possa considerare un lettore forte, mi mancano un sacco di romanzi probabilmente fondamentali nella definizione della fantascienza attuale. Certo, posso sempre dare la colpa al fatto che in Italia sono dieci anni che in libreria non arriva (quasi) nulla di nuovo, e che leggere in originale mi è comunque più dispendioso (se non in termini economici, almeno dal punto di vista del tempo speso e dello sforzo fatto). Ma conta poco, i buchi rimarranno tali.
Quindi, se secondo voi nella lista che segue manca questo o quel titolo che avrebbe avuto tutti i numeri per entrare in classifica, segnalatemelo, che magari è la volta buona.
Ma bando agli indugi, ecco i titoli:
- Iain M. Banks, Use of Weapons (La guerra di Zakalwe), 1990
Che Iain M. Banks entrasse in questa classifica era scontato. Il dubbio semmai era con quale titolo. Ho scelto Use of Weapons perché è forse il meno divertente tra i suoi romanzi, ma di certo il più intenso, profondo ed emozionante.
- Greg Egan, Distress (Distress), 1995
Greg Egan avrebbe potuto da solo riempire mezza classifica. Ho scelto Distress per l'impegno civile e l'ottimismo di cui è farcito, oltre che per essere uno dei pochissimi tentativi di immaginare il prossimo futuro senza lasciarsi travolgere dalla disperazione ne tanto meno da un acritico entusiasmo.
- Neal Stephenson, The Diamond Age (L'era del diamante), 1995
Si era detto fantascienza e solo fantascienza. Quindi, anche se il Cryptonomicon rimane il romanzo più memorabile scritto da Neal Stephenson, l'era del diamante è la scelta obbligata. Questo romanzo rappresenta tuttora un'esperienza di lettura straordinaria per la complessità, la creatività e la meraviglia di cui sono fitte le sue pagine.
- Ian McDonald, Necroville (Necroville), 1994
Anche per Ian McDonald ho avuto l'imbarazzo della scelta. Probabilmente River of Gods o Brasyl sono romanzi migliori di Necroville. Ma è stata questa storia di non-morti e passione che mi ha fatto conoscere McDonald, e Necroville è tuttora il romanzo dell'era post-cyberpunk più eccitante che io ricordi.
- Mary Gentle, Ash - A Secret History (Ash - Una storia segreta 1-4), 1999
Ash è un esempio formidabile di come si possano coniugare scenari cari al fantasy più trito a contenuti meravigliosamente fantascientifici, con un approccio capace di accontentare sia chi cerca una lettura piena di sorprese, sia chi apprezza qualche riflessione non banale sulla realtà. E poi c'è Ash: come fai a dimenticarti una fanciulla come lei?
- Charles Stross, Accelerando (Accelerando), 2005
Charlie Stross è la voce più interessante della fantascienza degli ultimi anni. Forse Accelerando non è un capolavoro. Ma ci va decisamente vicino.
- Lois McMaster Bujold, A Civil Campain (Guerra di strategie), 1999
Non potevo non inserire la Bujold in questa classifica. Lo so, la sua è una fantascienza classica, scritta senza troppe concessioni allo stile o alla bellezza della lingua. Ma la saga di MIles Vorkosigan mi ha tenuto buona compagnia per molti anni e tra tutti i volumi che compongono il ciclo Lois McMaster Bujold almeno un capolavoro lo ha scritto: Guerra di strategie è la miglior commedia fantascientifica mi sia mai capitato di leggere. E se non siete d'accordo vi auguro un'invasione di scaraburre in salotto!
- Ayerdhal & Jean-Claude Dunyach, Étoiles mourantes (Stelle morenti), 1999
Stelle morenti è strepitoso per l'ambizione e la vastità dello scenario. Il romanzo del duo francese Ayerdhal & Dunyach riesce ad unire le più ardite speculazioni sociologiche con una trama densa di azione e meraviglie. Sarà anche debitore a più blasonati modelli britannici, ma Stelle Morenti è comunque space opera della miglior specie.
- Mikael Niemi, Svålhålet (Il manifesto dei cosmonisti), 2004
- Jonathan Lethem, Amnesia Moon (Amnesia Moon), 1995
Per gli ultimi due titoli di questa lista ho scelto due romanzi che con la fantascienza tradizionalmente edita nel nostro paese hanno poco a che fare. Non sono usciti per editori specializzati e godono di una qualità di scrittura superiore a quella usualmente riscontrabile all'interno del genere. Già questo mi sembra un ottimo motivo per inserirli in questa top-ten, ma qui non si tratta solo di stile e bella scrittura. Le storie di Niemi e Lethem, pur totalmente antitetiche per sensibilità e ambientazione, sono colme di quel senso di meraviglia, di scoperta e di inquietudine che da sempre associo alla miglior fantascienza.
Per concludere un cenno ai grandi assenti.
Ci sono autori che mi piacerebbe riuscire a inserire in qualunque classifica, ma per un motivo o per l'altro sono assenti. Penso a William Gibson che manca perché è difficile definire fantascienza il suo miglior romanzo post-Nuromante, o a Ted Chiang che ha scritto il più straordinario racconto degli ultimi vent'anni (mi riferisco a Storia della tua vita), ma che è, appunto, solo un racconto.
Altri autori che non sono entrati in classifica, ma che potrebbe benissimo rientrare nel novero dei migliori, sono Richard K. Morgan o Jon Courtenay Grimwood (e poi chissà quanti altri di cui non ho ancora letto niente).
Altra grande assente è la fantascienza italiana. Sono stato tentato di inserire Nessun uomo è mio fratello in classifica. Ma non ce l'ho fatta. La lettura è troppo recente e temo che l'entusiasmo appanni il mio giudizio.
Sono comunque convinto che se c'è un romanzo italiano che merita ogni possibile riconoscimento è quello.
Bene. È tutto.
Attendo i vostri dieci titoli.
…
Quella che segue è la mia personalissima top ten dei volumi editi dal 1990 in poi. Le regole sono semplici: dieci titoli, un titolo per autore, esclusivamente romanzi (e quindi niente antologie, racconti e/o romanzi brevi), solo fantascienza.
Ovviamente questa classifica risponde unicamente ai miei gusti, non ha alcuna pretesa di oggettività ed è valida qui e ora, che se me la chiedeste tra un mese sarebbe probabilmente diversa.
Stilando la classifica mi sono reso conto che per quanto io mi possa considerare un lettore forte, mi mancano un sacco di romanzi probabilmente fondamentali nella definizione della fantascienza attuale. Certo, posso sempre dare la colpa al fatto che in Italia sono dieci anni che in libreria non arriva (quasi) nulla di nuovo, e che leggere in originale mi è comunque più dispendioso (se non in termini economici, almeno dal punto di vista del tempo speso e dello sforzo fatto). Ma conta poco, i buchi rimarranno tali.
Quindi, se secondo voi nella lista che segue manca questo o quel titolo che avrebbe avuto tutti i numeri per entrare in classifica, segnalatemelo, che magari è la volta buona.
Ma bando agli indugi, ecco i titoli:
- Iain M. Banks, Use of Weapons (La guerra di Zakalwe), 1990
Che Iain M. Banks entrasse in questa classifica era scontato. Il dubbio semmai era con quale titolo. Ho scelto Use of Weapons perché è forse il meno divertente tra i suoi romanzi, ma di certo il più intenso, profondo ed emozionante.
- Greg Egan, Distress (Distress), 1995
Greg Egan avrebbe potuto da solo riempire mezza classifica. Ho scelto Distress per l'impegno civile e l'ottimismo di cui è farcito, oltre che per essere uno dei pochissimi tentativi di immaginare il prossimo futuro senza lasciarsi travolgere dalla disperazione ne tanto meno da un acritico entusiasmo.
- Neal Stephenson, The Diamond Age (L'era del diamante), 1995
Si era detto fantascienza e solo fantascienza. Quindi, anche se il Cryptonomicon rimane il romanzo più memorabile scritto da Neal Stephenson, l'era del diamante è la scelta obbligata. Questo romanzo rappresenta tuttora un'esperienza di lettura straordinaria per la complessità, la creatività e la meraviglia di cui sono fitte le sue pagine.
- Ian McDonald, Necroville (Necroville), 1994
Anche per Ian McDonald ho avuto l'imbarazzo della scelta. Probabilmente River of Gods o Brasyl sono romanzi migliori di Necroville. Ma è stata questa storia di non-morti e passione che mi ha fatto conoscere McDonald, e Necroville è tuttora il romanzo dell'era post-cyberpunk più eccitante che io ricordi.
- Mary Gentle, Ash - A Secret History (Ash - Una storia segreta 1-4), 1999
Ash è un esempio formidabile di come si possano coniugare scenari cari al fantasy più trito a contenuti meravigliosamente fantascientifici, con un approccio capace di accontentare sia chi cerca una lettura piena di sorprese, sia chi apprezza qualche riflessione non banale sulla realtà. E poi c'è Ash: come fai a dimenticarti una fanciulla come lei?
- Charles Stross, Accelerando (Accelerando), 2005
Charlie Stross è la voce più interessante della fantascienza degli ultimi anni. Forse Accelerando non è un capolavoro. Ma ci va decisamente vicino.
- Lois McMaster Bujold, A Civil Campain (Guerra di strategie), 1999
Non potevo non inserire la Bujold in questa classifica. Lo so, la sua è una fantascienza classica, scritta senza troppe concessioni allo stile o alla bellezza della lingua. Ma la saga di MIles Vorkosigan mi ha tenuto buona compagnia per molti anni e tra tutti i volumi che compongono il ciclo Lois McMaster Bujold almeno un capolavoro lo ha scritto: Guerra di strategie è la miglior commedia fantascientifica mi sia mai capitato di leggere. E se non siete d'accordo vi auguro un'invasione di scaraburre in salotto!
- Ayerdhal & Jean-Claude Dunyach, Étoiles mourantes (Stelle morenti), 1999
Stelle morenti è strepitoso per l'ambizione e la vastità dello scenario. Il romanzo del duo francese Ayerdhal & Dunyach riesce ad unire le più ardite speculazioni sociologiche con una trama densa di azione e meraviglie. Sarà anche debitore a più blasonati modelli britannici, ma Stelle Morenti è comunque space opera della miglior specie.
- Mikael Niemi, Svålhålet (Il manifesto dei cosmonisti), 2004
- Jonathan Lethem, Amnesia Moon (Amnesia Moon), 1995
Per gli ultimi due titoli di questa lista ho scelto due romanzi che con la fantascienza tradizionalmente edita nel nostro paese hanno poco a che fare. Non sono usciti per editori specializzati e godono di una qualità di scrittura superiore a quella usualmente riscontrabile all'interno del genere. Già questo mi sembra un ottimo motivo per inserirli in questa top-ten, ma qui non si tratta solo di stile e bella scrittura. Le storie di Niemi e Lethem, pur totalmente antitetiche per sensibilità e ambientazione, sono colme di quel senso di meraviglia, di scoperta e di inquietudine che da sempre associo alla miglior fantascienza.
Per concludere un cenno ai grandi assenti.
Ci sono autori che mi piacerebbe riuscire a inserire in qualunque classifica, ma per un motivo o per l'altro sono assenti. Penso a William Gibson che manca perché è difficile definire fantascienza il suo miglior romanzo post-Nuromante, o a Ted Chiang che ha scritto il più straordinario racconto degli ultimi vent'anni (mi riferisco a Storia della tua vita), ma che è, appunto, solo un racconto.
Altri autori che non sono entrati in classifica, ma che potrebbe benissimo rientrare nel novero dei migliori, sono Richard K. Morgan o Jon Courtenay Grimwood (e poi chissà quanti altri di cui non ho ancora letto niente).
Altra grande assente è la fantascienza italiana. Sono stato tentato di inserire Nessun uomo è mio fratello in classifica. Ma non ce l'ho fatta. La lettura è troppo recente e temo che l'entusiasmo appanni il mio giudizio.
Sono comunque convinto che se c'è un romanzo italiano che merita ogni possibile riconoscimento è quello.
Bene. È tutto.
Attendo i vostri dieci titoli.
…
13 luglio 2010
Letture giugno 2010
Ian McDonald - Cyberabad Days
È un crescendo continuo questo volume di racconti di Ian McDonald. Ambientate tutte nell'India prossima ventura già raccontata in River of Gods, le storie di Cyberabad Days allargano lo sguardo dalla città di Varanasi, capitale di uno degli stati nati dalla separazione dell'India all'inizio del XXI secolo, alle nazioni confinanti, alle loro città e soprattutto ai loro abitanti.
Tutti i racconti di Cyberabad Days sono ritratti intensi e meravigliosi di personaggi alle prese con il drastico cambiamento del loro mondo. Attraverso gli occhi e le vicende dei sui protagonisti McDonald tesse e dispiega un arazzo narrativo denso di sapori al contempo esotici e familiari, dominato dall'eterno conflitto tra tradizione e innovazione. Conflitto che nei racconti dell'autore nordirlandese si risolve sempre con insospettabili mediazioni, con la tecnologia che si piega al ricchissimo serbatoio di storie e contraddizioni che caratterizza il continente indiano e con i suoi abitanti che trovano sempre nuove risorse per conservare privilegi e connessioni al di là del più vertiginoso dei cambiamenti.
Un altro degli aspetti straordinari dei racconti di Cyberabad Days sta nella capacità di McDonald di esaltare la singolarità di ognuno dei suoi personaggi senza mai elevarla al di sopra della storia di cui sono protagonisti, riuscendo invece a trasmettere al lettore il loro essere parte di un universo inesorabilmente più vasto e complesso delle loro pur notevoli esistenze. Hanno tutte un sapore dolce-amaro queste storie, costrette come sono a mediare tra fragilità umane e meraviglie tecnologiche, tra sogni individuali e incubi sociali.
L'india di Ian McDonald mi ha ricordato quella, altrettanto ricca e profumata, dei romanzi di Vikram Chandra con in più un sacco di ottime idee fantascientifiche a rendere più interessante il panorama.
Non male per un pallido abitante delle isole britanniche.
Robert Silverberg - L'uomo stocastico
Io ho un grosso buco nella mia libreria fantascientifica che comprende quasi tutto quel che è uscito nel corso degli anni '70 dello scorso secolo. Urania Collezione è piuttosto parca nella proposta di romanzi che risalgono a quegli anni e la pubblicazione di un'opera piuttosto conosciuta come L'uomo stocastico rapresenta quindi un'ottima occasione per assaporare l'aria che tirava in quegli anni.
In effetti questo romanzo di Robert Silverberg sa un po' di vecchio. Le dinamiche che determinano i comportamenti dei personaggi di questo romanzo odorano di seventies lontano un miglio (la politica, le sette, il disagio urbano, il petrolio). Oltretutto il quid del romanzo (determinismo vs libero arbitrio) ha un esito terrificante (almeno dal mio punto di vista), ma nonostante tutto L'uomo stocastico si legge volentieri, che il tono pacato e tranquillo di Silverberg è tutt'altro che soporifero, e i dubbi e le suggestioni che è capace di evocare non sono - comunque la si pensi - per nulla tranquillizzanti.
Peter Hamilton - Il sogno del vuoto
Con l'enorme trilogia de L'alba della notte (qualche migliaio di pagine distribuite, nell'edizione italiana, in dieci numeri di Urania) Peter Hamilton mi aveva divertito come pochi altri autori di fantascienza: scenari cosmici, ambientazioni esotiche, personaggi affascinanti, meraviglie a gogò, un plot complicatissimo per dimensioni eppure elementare nello sviluppo. Quei tre romanzi hanno rappresentato per me quanto di meglio la fantascienza popolare possa produrre al giorno d'oggi.
Non appena si è diffusa la notizia che Urania avrebbe proposto ai lettori italiani un altro progetto monstre di Peter Hamilton, ne son rimasto piacevolmente colpito e ho atteso con impazienza lo sbarco in libreria de Il sogno del vuoto, primo volume della trilogia del Vuoto.
Purtroppo però in questo romanzo non tutto funziona come dovrebbe. Gli ingredienti che avevano reso un piacere la lettura dell'Alba della notte ci sono tutti, ma la capacità di dosare le informazioni, l'equilibrio tra le varie componenti, e l'immediatezza che contraddistingueva quell'opera si perdono in una gestione del plot piuttosto confusa, nell'eccesso di infodump che contraddistingue troppe pagine del volume e soprattutto nell'incapacità dell'autore di infondere personalità riconoscibili e singolari alla galleria di personaggi che affollano il romanzo.
Il sogno del vuoto si lascia leggere, che nonostante i difetti molti dei singoli episodi in cui è frammentata la trama rimangono spettacolari e seducenti, però ecco, mi aspettavo un romanzo più solido e consistente. Speriamo nel secondo capitolo.
Virginia Woolf - La signora Dalloway
Campo, controcampo, soggettiva, panoramica e poi improvvisi primi piani e flashback e veloci scarti laterali per poi tornare in soggettiva sul dettaglio e chiudere con una carrellata verso l'alto. Cinema insomma, di quello al contempo spettacolare e profondo. Qualcosa che nella mia ignoranza non mi sarei mai aspettato potesse uscire dalla penna di un'autrice inglese nel primo quarto del secolo scorso.
E invece La signora Dalloway è un vero incanto di romanzo, scritto in maniera sublime (e tradotto altrettanto bene da Nadia Fusini), ricchissimo di spunti interessanti, capace di offrire un ritratto della buona società inglese tra le due guerre come probabilmente nessun testo storico è capace di fare. Un romanzo da assaporare lentamente per gustare al meglio il talento di cui Virginia Woolf fa sfoggio nel piegare l'indubbio virtuosismo della sua prosa al racconto di una mondo in via d'estinzione.
…
È un crescendo continuo questo volume di racconti di Ian McDonald. Ambientate tutte nell'India prossima ventura già raccontata in River of Gods, le storie di Cyberabad Days allargano lo sguardo dalla città di Varanasi, capitale di uno degli stati nati dalla separazione dell'India all'inizio del XXI secolo, alle nazioni confinanti, alle loro città e soprattutto ai loro abitanti.
Tutti i racconti di Cyberabad Days sono ritratti intensi e meravigliosi di personaggi alle prese con il drastico cambiamento del loro mondo. Attraverso gli occhi e le vicende dei sui protagonisti McDonald tesse e dispiega un arazzo narrativo denso di sapori al contempo esotici e familiari, dominato dall'eterno conflitto tra tradizione e innovazione. Conflitto che nei racconti dell'autore nordirlandese si risolve sempre con insospettabili mediazioni, con la tecnologia che si piega al ricchissimo serbatoio di storie e contraddizioni che caratterizza il continente indiano e con i suoi abitanti che trovano sempre nuove risorse per conservare privilegi e connessioni al di là del più vertiginoso dei cambiamenti.
Un altro degli aspetti straordinari dei racconti di Cyberabad Days sta nella capacità di McDonald di esaltare la singolarità di ognuno dei suoi personaggi senza mai elevarla al di sopra della storia di cui sono protagonisti, riuscendo invece a trasmettere al lettore il loro essere parte di un universo inesorabilmente più vasto e complesso delle loro pur notevoli esistenze. Hanno tutte un sapore dolce-amaro queste storie, costrette come sono a mediare tra fragilità umane e meraviglie tecnologiche, tra sogni individuali e incubi sociali.
L'india di Ian McDonald mi ha ricordato quella, altrettanto ricca e profumata, dei romanzi di Vikram Chandra con in più un sacco di ottime idee fantascientifiche a rendere più interessante il panorama.
Non male per un pallido abitante delle isole britanniche.
Robert Silverberg - L'uomo stocastico
Io ho un grosso buco nella mia libreria fantascientifica che comprende quasi tutto quel che è uscito nel corso degli anni '70 dello scorso secolo. Urania Collezione è piuttosto parca nella proposta di romanzi che risalgono a quegli anni e la pubblicazione di un'opera piuttosto conosciuta come L'uomo stocastico rapresenta quindi un'ottima occasione per assaporare l'aria che tirava in quegli anni.
In effetti questo romanzo di Robert Silverberg sa un po' di vecchio. Le dinamiche che determinano i comportamenti dei personaggi di questo romanzo odorano di seventies lontano un miglio (la politica, le sette, il disagio urbano, il petrolio). Oltretutto il quid del romanzo (determinismo vs libero arbitrio) ha un esito terrificante (almeno dal mio punto di vista), ma nonostante tutto L'uomo stocastico si legge volentieri, che il tono pacato e tranquillo di Silverberg è tutt'altro che soporifero, e i dubbi e le suggestioni che è capace di evocare non sono - comunque la si pensi - per nulla tranquillizzanti.
Peter Hamilton - Il sogno del vuoto
Con l'enorme trilogia de L'alba della notte (qualche migliaio di pagine distribuite, nell'edizione italiana, in dieci numeri di Urania) Peter Hamilton mi aveva divertito come pochi altri autori di fantascienza: scenari cosmici, ambientazioni esotiche, personaggi affascinanti, meraviglie a gogò, un plot complicatissimo per dimensioni eppure elementare nello sviluppo. Quei tre romanzi hanno rappresentato per me quanto di meglio la fantascienza popolare possa produrre al giorno d'oggi.
Non appena si è diffusa la notizia che Urania avrebbe proposto ai lettori italiani un altro progetto monstre di Peter Hamilton, ne son rimasto piacevolmente colpito e ho atteso con impazienza lo sbarco in libreria de Il sogno del vuoto, primo volume della trilogia del Vuoto.
Purtroppo però in questo romanzo non tutto funziona come dovrebbe. Gli ingredienti che avevano reso un piacere la lettura dell'Alba della notte ci sono tutti, ma la capacità di dosare le informazioni, l'equilibrio tra le varie componenti, e l'immediatezza che contraddistingueva quell'opera si perdono in una gestione del plot piuttosto confusa, nell'eccesso di infodump che contraddistingue troppe pagine del volume e soprattutto nell'incapacità dell'autore di infondere personalità riconoscibili e singolari alla galleria di personaggi che affollano il romanzo.
Il sogno del vuoto si lascia leggere, che nonostante i difetti molti dei singoli episodi in cui è frammentata la trama rimangono spettacolari e seducenti, però ecco, mi aspettavo un romanzo più solido e consistente. Speriamo nel secondo capitolo.
Virginia Woolf - La signora Dalloway
Campo, controcampo, soggettiva, panoramica e poi improvvisi primi piani e flashback e veloci scarti laterali per poi tornare in soggettiva sul dettaglio e chiudere con una carrellata verso l'alto. Cinema insomma, di quello al contempo spettacolare e profondo. Qualcosa che nella mia ignoranza non mi sarei mai aspettato potesse uscire dalla penna di un'autrice inglese nel primo quarto del secolo scorso.
E invece La signora Dalloway è un vero incanto di romanzo, scritto in maniera sublime (e tradotto altrettanto bene da Nadia Fusini), ricchissimo di spunti interessanti, capace di offrire un ritratto della buona società inglese tra le due guerre come probabilmente nessun testo storico è capace di fare. Un romanzo da assaporare lentamente per gustare al meglio il talento di cui Virginia Woolf fa sfoggio nel piegare l'indubbio virtuosismo della sua prosa al racconto di una mondo in via d'estinzione.
…
08 luglio 2010
À la France! (sì, ma dove?)
Quest'anno per le vacanze finalmente si torna in Francia.
Non avendo molto tempo a nostra disposizione abbiamo deciso di trascorrere una settimana nei dintorni di Parigi e di utilizzare un'altra decina di giorni per fare qualche tappa lungo la strada di avvicinamento alla capitale francese.
Dato che della Francia non ne so poi molto, ci farebbe molto piacere se i visitatori di queste pagine ci dessero qualche consiglio.
C'è qualche località un cui dobbiamo assolutamente fermarci nel nostro viaggio verso Parigi? Ci sono castelli medievali, boschi incantati, meraviglie tecnologiche che valgano la sosta e che possano essere di qualche interesse per due preadolescenti irrequieti?
C'è qualche b&b / trattoria / ristorante / cantina che non ci possiamo assolutamente perdere, vuoi per le leccornie eno-gastronomiche, vuoi per il prezzo abbordabile, vuoi per la qualità della sosta?
Insomma, se un po' di Francia v'è rimasta nel cuore questo è il momento per condividerla con noi.
Grazie!
Per finire, e forse anche per capire cosa ci piace, questo è uno slideshow delle mie vecchie foto francesi:
…
Non avendo molto tempo a nostra disposizione abbiamo deciso di trascorrere una settimana nei dintorni di Parigi e di utilizzare un'altra decina di giorni per fare qualche tappa lungo la strada di avvicinamento alla capitale francese.
Dato che della Francia non ne so poi molto, ci farebbe molto piacere se i visitatori di queste pagine ci dessero qualche consiglio.
C'è qualche località un cui dobbiamo assolutamente fermarci nel nostro viaggio verso Parigi? Ci sono castelli medievali, boschi incantati, meraviglie tecnologiche che valgano la sosta e che possano essere di qualche interesse per due preadolescenti irrequieti?
C'è qualche b&b / trattoria / ristorante / cantina che non ci possiamo assolutamente perdere, vuoi per le leccornie eno-gastronomiche, vuoi per il prezzo abbordabile, vuoi per la qualità della sosta?
Insomma, se un po' di Francia v'è rimasta nel cuore questo è il momento per condividerla con noi.
Grazie!
Per finire, e forse anche per capire cosa ci piace, questo è uno slideshow delle mie vecchie foto francesi:
…
30 giugno 2010
Da dove vengo
Quello che segue è un vecchio progetto fotografico già pubblicato su flickr qualche anno fa.
Lo ripropongo qui e ora a causa di una serie di suggestioni sulla memoria, sulle differenze tra i bambini di oggi e quelli di ieri, sui luoghi dell'infanzia, nate dalla lettura di questo post. Il pezzo di Giovanni tocca questi argomenti solo parzialmente, però mi ha fatto ritornare in mente queste vecchie foto e i ricordi che evocano.
(1967-1985)

Casa mia, almeno per la maggior parte dei miei primi 19 anni di vita.
(1969-1972)

L'asilo. Sembra piuttosto tenebroso, ma l'aspetto inganna e nonostante fosse l'asilo delle suore ho degli ottimi ricordi di questo posto.
(1972-1977)

La scuola elementare. Tenuto conto che nel suo seminterrato c'era la biblioteca di quartiere ( quante ore ci ho passato? quante scoperte devo a questo posto?) era praticamente la mia seconda casa.
(1977-1980)

Le medie. Ai tempi era un prefabbricato con licenza di distruzione. Non è cambiato poi molto, anche se ora sembra un posto per bene.
(1973-1981)

Il vicolo. Quanti pomeriggi, quante estati cì abbiamo passato. Era il nostro parco giochi. La nostra palestra.
(1974-1979)
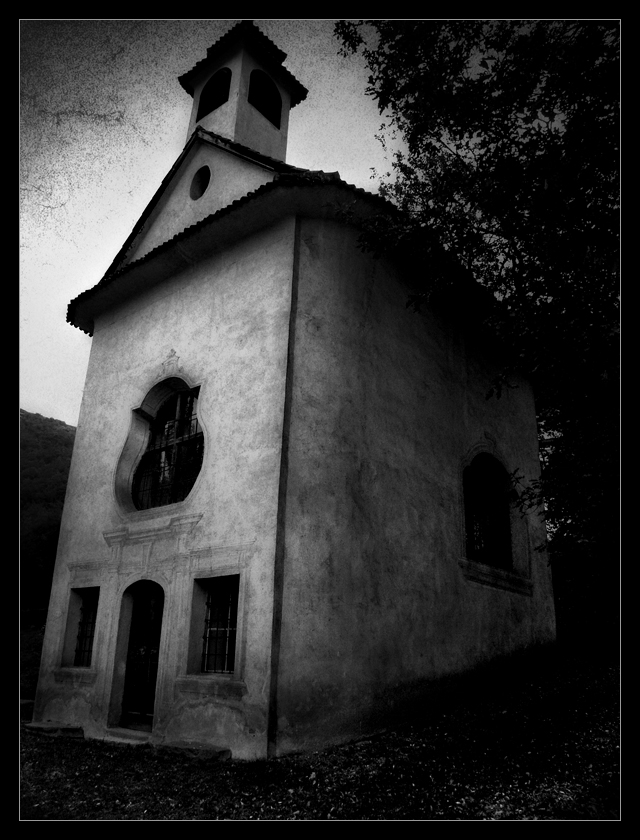
Hic sunt leones. Uno dei segni di confine che caratterizzava la mia infanzia. Oltre questa cappella iniziava il quartiere tedesco. Un altro mondo con tacito divieto d'accesso, sconosciuto e inesplorato (e lo sarebbe rimasto per parecchi anni ancora).
(1975-1986)

La parrocchia. In realtà nella foto c'è solo la scala che portava dal retro della parrocchia al campo di calcio e poi su, fino alla montagna.
Ho fatto qualche foto alla chiesa, ma nessuna mi piaceva quanto questa. Visto che in fondo in quegli anni la chiesa l'ho lasciata, preferisco lasciare la foto della scala. Dopotutto l'ho percorsa molte più volte di quanto abbia attraversato la navata della chiesa, e con molta più soddisfazione.
(1980-1986)

Il campetto della parrocchia. Dopo il vicolo, quel campo da calcio sterrato è stata la nostra naturale destinazione. Da allora questo campo è cambiato tanto da essere praticamente irriconoscibile: ha il fondo sintetico, le tribune, persino gli spogliatoi. Quando ci giocavamo (ore e ore i sabati pomeriggio, le serate d'estate, risultati incredibili: 38-27, 42-12, 35-35 e chi fa gol ha vinto) era sassi e polvere e il rubinetto per l'acqua.
(1981-1986)

La panchina. Per chiudere in bellezza ecco il posto dove cominciavano le nostre serate. Non è proprio la stessa panchina (nel frattempo hanno ristrutturato il parco, e quindi l'originale non c'è più), però è molto vicina a dov'era la nostra. Immagino che la vita di (quasi) tutti i ragazzi italiani sia passata per una panchina simile.
(Per chi volesse saperne di più: avevo già parlato di Bolzano e delle sue particolarità in questi vecchi post: piccola città, bastardo posto, Bolzano/Bozen: apartheid provinciale)
…
Lo ripropongo qui e ora a causa di una serie di suggestioni sulla memoria, sulle differenze tra i bambini di oggi e quelli di ieri, sui luoghi dell'infanzia, nate dalla lettura di questo post. Il pezzo di Giovanni tocca questi argomenti solo parzialmente, però mi ha fatto ritornare in mente queste vecchie foto e i ricordi che evocano.
(1967-1985)

Casa mia, almeno per la maggior parte dei miei primi 19 anni di vita.
(1969-1972)

L'asilo. Sembra piuttosto tenebroso, ma l'aspetto inganna e nonostante fosse l'asilo delle suore ho degli ottimi ricordi di questo posto.
(1972-1977)

La scuola elementare. Tenuto conto che nel suo seminterrato c'era la biblioteca di quartiere ( quante ore ci ho passato? quante scoperte devo a questo posto?) era praticamente la mia seconda casa.
(1977-1980)

Le medie. Ai tempi era un prefabbricato con licenza di distruzione. Non è cambiato poi molto, anche se ora sembra un posto per bene.
(1973-1981)

Il vicolo. Quanti pomeriggi, quante estati cì abbiamo passato. Era il nostro parco giochi. La nostra palestra.
(1974-1979)
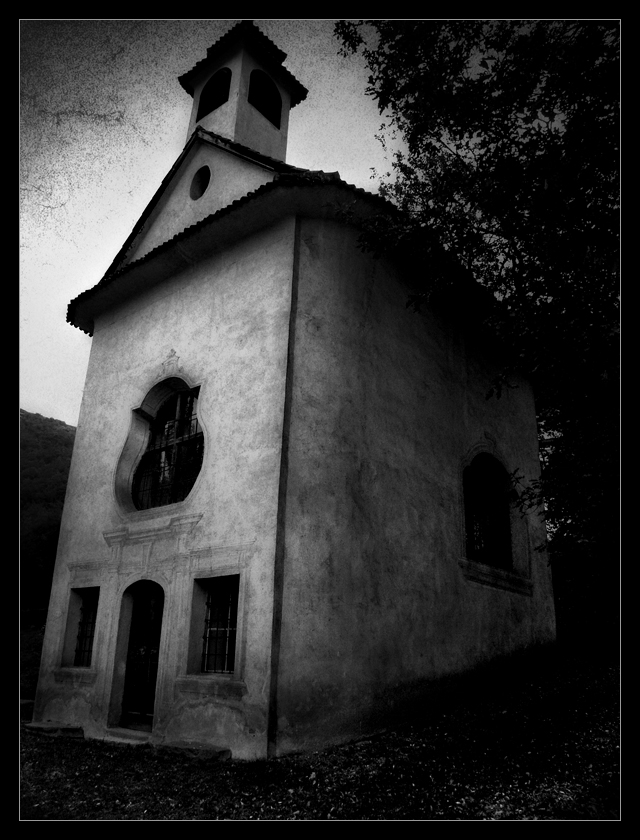
Hic sunt leones. Uno dei segni di confine che caratterizzava la mia infanzia. Oltre questa cappella iniziava il quartiere tedesco. Un altro mondo con tacito divieto d'accesso, sconosciuto e inesplorato (e lo sarebbe rimasto per parecchi anni ancora).
(1975-1986)

La parrocchia. In realtà nella foto c'è solo la scala che portava dal retro della parrocchia al campo di calcio e poi su, fino alla montagna.
Ho fatto qualche foto alla chiesa, ma nessuna mi piaceva quanto questa. Visto che in fondo in quegli anni la chiesa l'ho lasciata, preferisco lasciare la foto della scala. Dopotutto l'ho percorsa molte più volte di quanto abbia attraversato la navata della chiesa, e con molta più soddisfazione.
(1980-1986)

Il campetto della parrocchia. Dopo il vicolo, quel campo da calcio sterrato è stata la nostra naturale destinazione. Da allora questo campo è cambiato tanto da essere praticamente irriconoscibile: ha il fondo sintetico, le tribune, persino gli spogliatoi. Quando ci giocavamo (ore e ore i sabati pomeriggio, le serate d'estate, risultati incredibili: 38-27, 42-12, 35-35 e chi fa gol ha vinto) era sassi e polvere e il rubinetto per l'acqua.
(1981-1986)

La panchina. Per chiudere in bellezza ecco il posto dove cominciavano le nostre serate. Non è proprio la stessa panchina (nel frattempo hanno ristrutturato il parco, e quindi l'originale non c'è più), però è molto vicina a dov'era la nostra. Immagino che la vita di (quasi) tutti i ragazzi italiani sia passata per una panchina simile.
(Per chi volesse saperne di più: avevo già parlato di Bolzano e delle sue particolarità in questi vecchi post: piccola città, bastardo posto, Bolzano/Bozen: apartheid provinciale)
…
25 giugno 2010
Try rugby!
Lo so. Questo video risulterà facile e scontato. Per non dire vagamente sessista.
Però ho visto qualche partita di questo mondiale, e quando ci vuole ci vuole.
Enjoy!
…
Però ho visto qualche partita di questo mondiale, e quando ci vuole ci vuole.
Enjoy!
…
22 giugno 2010
On-Off (Line)
Nel caso foste preoccupati, non sono scomparso, non sono scappato, sto bene. Se sono meno on-line del solito è per una serie di fortunati eventi, che comprendono tra le altre cose un sacco di cene in compagnia (alcune da fotografo, altre per celebrare la fine stagione rugbystica, senza contare gli anniversari di matrimonio, i soliti amici, etc etc) e l'allestimento di un set fotografico in azienda, che mi ha costretto ad alzare il culo dalla scrivania e abbandonare quindi il mio fido Mac e ogni possibilità di connessione nelle ore di lavoro. Ah… ho pure ricominciato coi giochi di ruolo (gran bella cosa, btw)!
Le cose vanno splendidamente quindi, ma visto che il tempo libero a disposizione è sempre lo stesso, da qualche parte bisognava tagliare. Ma state tranquilli (o forse no), che prima o poi le cose torneranno normali.
Oggi però ho un po' di tempo e ne approfitto quindi per sistemare un paio di cose che ho lasciato in sospeso.
- Per prima cosa volevo segnalarvi questo post da qualcun altro che non sono io. Si parla di lettura in lingua originale e le considerazioni di Gianluca al riguardo sono totalmente condivisibili.
Sono pochi anni che leggo in inglese pur non avendo una gran padronanza della lingua parlata. All'inizio ero scettico riguarda la mia capacità di comprensione del testo, ma ora l'unico handicap che mi frena dall'affrontare un romanzo in lingua straniera è il tempo di lettura, che è quasi il doppio di quello necessario per leggere in italiano.
- Nello spazio commenti dell'ultimo post si discuteva di Vance, Hamilton e recensioni lette in giro per la rete. In particolare si tirava in ballo il commento di Giovanni Dell'Orto a Pianeta d'acqua.
Non condividendo l'approccio di Giovanni sono andato a pescarlo su Anobii dove ci siamo scambiati qualche mail nel tentativo di chiarire le rispettive opinione sulla fantascienza, la vita e tutto quanto.
Una cosa scritta da Giovanni mi ha colpito e un pochino turbato (per i controllori della netiquette: ho chiesto il permesso all'autore per pubblicare qui le sue parole):
"Se recensisco un libro di storia, teologia, filosofia, politica, teoria dell'informazione, ci tengo ad essere preso sul serio. […]
Ma se scrivo di fantascienza (o di fumetti, o di musica rock, o di romanzi porno, o...), non stiamo parlando delle stesse cose.
Se parlo di politica parlo di cose reali ed importanti. Se parlo di marzianini verdi che comunicano telepaticamente, parlo di cose non esistenti, quindi di uno svago intellettuale.""Se recensisco un libro di storia, teologia, filosofia, politica, teoria dell'informazione, ci tengo ad essere preso sul serio. […]
Ma se scrivo di fantascienza (o di fumetti, o di musica rock, o di romanzi porno, o...), non stiamo parlando delle stesse cose.
Se parlo di politica parlo di cose reali ed importanti. Se parlo di marzianini verdi che comunicano telepaticamente, parlo di cose non esistenti, quindi di uno svago intellettuale."
Al che io replicavo che per me la letteratura ha la stessa importanza della storia o della filosofia, molto più della teologia e forse un po' meno della politica, e quindi faccio fatica a condividere una linea di pensiero come questa. Oltretutto pensando alla fantascienza non sono certo i marzianini verdi la prima cosa che mi viene in mente. Per me la fantascienza è legata a filo doppio col reale, più di qualsiasi altro genere letterario (potenzialmente molto di più).
Voi che dite? Forse sarebbe davvero il caso di considerare fantascienza e simili come letteratura d'evasione e stop? O non ci priveremmo in questo modo di un'opportunità unica di riflettere sul reale, magari in maniera obliqua o laterale, ma divertendoci comunque un sacco lungo la strada?
O magari dovremmo iniziare a prendere meno sul serio politica e filosofia, che è un'altra di quelle cose che pare tabù anche solo a pensarle…
(NB non ho intenzione di polemizzare con Giovanni Dell'Orto: riguardo a quanto scrive ci siamo già abbondantemente chiariti. Usavo le sue parole come spunto per riflettere sulla percezione che si ha della fantascienza al di fuori dei confini del piccolo quartiere in cui prosperiamo (si fa per dire). Questa cosa della percezione di un ambito particolare (può essere la fantascienza, ma anche l'universo gay, o la vita quotidiana in Ucraina) da parte di chi quel determinato mondo conosce solo di sfuggita è davvero affascinante e porta a riflessioni interessanti sul nostro concetto di realtà.)
- In questi giorni sto leggendo molta fantascienza (sai che novità!).
Sono quasi alla fine del Millemondi Hamiltoniano: per quanto Il sogno del vuoto sia divertente mi son piaciuti molto molto di più i volumazzi dell'Alba della notte. Se Hamilton m'è parso in calo, Ian MacDonald si conferma invece ai massimi livelli anche con i racconti di Cyberabad Days, uno di quei casi in cui la fantascienza non si limita a dar forma e colore a un intero mondo, ma ne rende l'invenzione indistinguibile da una potenziale realtà appena dietro l'angolo.
Ma di entrambi i volumi ne riparliamo tra qualche giorno.
Vi volevo chiedere piuttosto se avete notizie fresche sul destino di Epix. Ve lo chiedo molto egoisticamente perché a Luglio era prevista (finalmente!) la pubblicazione di Cuore d'Acciaio di Michael Swanwick, che per me è uno di quei romanzo capaci da soli di dar senso a un'intera collana. Visto il preoccupante silenzio sui blog mondadori, non so se iniziare a preoccuparmi.
- Volevo segnalarvi anche il blog di una vecchia conoscenza internettara. Erano anni che non ci si sentiva (sapete come vanno le cose in rete, in questo caso poi la distanza fisica non aiuta di certo), e mi fa molto piacere vederlo ancora vivo e vegeto e pensante.
Bene, per ora è tutto. Vado a rispondere a un paio di commenti. Voi fate a modo, che il tempo per leggervi lo trovo sempre. È scrivere, che siano riposte - si spera sensate - o nuovi post, che mi costa tempo e fatica. A presto!
…
Le cose vanno splendidamente quindi, ma visto che il tempo libero a disposizione è sempre lo stesso, da qualche parte bisognava tagliare. Ma state tranquilli (o forse no), che prima o poi le cose torneranno normali.
Oggi però ho un po' di tempo e ne approfitto quindi per sistemare un paio di cose che ho lasciato in sospeso.
- Per prima cosa volevo segnalarvi questo post da qualcun altro che non sono io. Si parla di lettura in lingua originale e le considerazioni di Gianluca al riguardo sono totalmente condivisibili.
Sono pochi anni che leggo in inglese pur non avendo una gran padronanza della lingua parlata. All'inizio ero scettico riguarda la mia capacità di comprensione del testo, ma ora l'unico handicap che mi frena dall'affrontare un romanzo in lingua straniera è il tempo di lettura, che è quasi il doppio di quello necessario per leggere in italiano.
- Nello spazio commenti dell'ultimo post si discuteva di Vance, Hamilton e recensioni lette in giro per la rete. In particolare si tirava in ballo il commento di Giovanni Dell'Orto a Pianeta d'acqua.
Non condividendo l'approccio di Giovanni sono andato a pescarlo su Anobii dove ci siamo scambiati qualche mail nel tentativo di chiarire le rispettive opinione sulla fantascienza, la vita e tutto quanto.
Una cosa scritta da Giovanni mi ha colpito e un pochino turbato (per i controllori della netiquette: ho chiesto il permesso all'autore per pubblicare qui le sue parole):
"Se recensisco un libro di storia, teologia, filosofia, politica, teoria dell'informazione, ci tengo ad essere preso sul serio. […]
Ma se scrivo di fantascienza (o di fumetti, o di musica rock, o di romanzi porno, o...), non stiamo parlando delle stesse cose.
Se parlo di politica parlo di cose reali ed importanti. Se parlo di marzianini verdi che comunicano telepaticamente, parlo di cose non esistenti, quindi di uno svago intellettuale.""Se recensisco un libro di storia, teologia, filosofia, politica, teoria dell'informazione, ci tengo ad essere preso sul serio. […]
Ma se scrivo di fantascienza (o di fumetti, o di musica rock, o di romanzi porno, o...), non stiamo parlando delle stesse cose.
Se parlo di politica parlo di cose reali ed importanti. Se parlo di marzianini verdi che comunicano telepaticamente, parlo di cose non esistenti, quindi di uno svago intellettuale."
Al che io replicavo che per me la letteratura ha la stessa importanza della storia o della filosofia, molto più della teologia e forse un po' meno della politica, e quindi faccio fatica a condividere una linea di pensiero come questa. Oltretutto pensando alla fantascienza non sono certo i marzianini verdi la prima cosa che mi viene in mente. Per me la fantascienza è legata a filo doppio col reale, più di qualsiasi altro genere letterario (potenzialmente molto di più).
Voi che dite? Forse sarebbe davvero il caso di considerare fantascienza e simili come letteratura d'evasione e stop? O non ci priveremmo in questo modo di un'opportunità unica di riflettere sul reale, magari in maniera obliqua o laterale, ma divertendoci comunque un sacco lungo la strada?
O magari dovremmo iniziare a prendere meno sul serio politica e filosofia, che è un'altra di quelle cose che pare tabù anche solo a pensarle…
(NB non ho intenzione di polemizzare con Giovanni Dell'Orto: riguardo a quanto scrive ci siamo già abbondantemente chiariti. Usavo le sue parole come spunto per riflettere sulla percezione che si ha della fantascienza al di fuori dei confini del piccolo quartiere in cui prosperiamo (si fa per dire). Questa cosa della percezione di un ambito particolare (può essere la fantascienza, ma anche l'universo gay, o la vita quotidiana in Ucraina) da parte di chi quel determinato mondo conosce solo di sfuggita è davvero affascinante e porta a riflessioni interessanti sul nostro concetto di realtà.)
- In questi giorni sto leggendo molta fantascienza (sai che novità!).
Sono quasi alla fine del Millemondi Hamiltoniano: per quanto Il sogno del vuoto sia divertente mi son piaciuti molto molto di più i volumazzi dell'Alba della notte. Se Hamilton m'è parso in calo, Ian MacDonald si conferma invece ai massimi livelli anche con i racconti di Cyberabad Days, uno di quei casi in cui la fantascienza non si limita a dar forma e colore a un intero mondo, ma ne rende l'invenzione indistinguibile da una potenziale realtà appena dietro l'angolo.
Ma di entrambi i volumi ne riparliamo tra qualche giorno.
Vi volevo chiedere piuttosto se avete notizie fresche sul destino di Epix. Ve lo chiedo molto egoisticamente perché a Luglio era prevista (finalmente!) la pubblicazione di Cuore d'Acciaio di Michael Swanwick, che per me è uno di quei romanzo capaci da soli di dar senso a un'intera collana. Visto il preoccupante silenzio sui blog mondadori, non so se iniziare a preoccuparmi.
- Volevo segnalarvi anche il blog di una vecchia conoscenza internettara. Erano anni che non ci si sentiva (sapete come vanno le cose in rete, in questo caso poi la distanza fisica non aiuta di certo), e mi fa molto piacere vederlo ancora vivo e vegeto e pensante.
Bene, per ora è tutto. Vado a rispondere a un paio di commenti. Voi fate a modo, che il tempo per leggervi lo trovo sempre. È scrivere, che siano riposte - si spera sensate - o nuovi post, che mi costa tempo e fatica. A presto!
…
09 giugno 2010
Letture aprile-maggio 2010 - terza parte
AA.VV. - Robot 55
Sono rimasto un po' indietro con la lettura di Robot. Il numero 55 risale ormai a un paio d'anni fa (nel frattempo siamo arrivati al 59, se non sbaglio) ma pian pianino conto di rimettermi in pari (datemi delle giornate di 36 ore, per favore!).
La gemma di questo numero è (ovviamente!) il racconto di Ted Chiang: Il mercante e il portale dell’alchimista è un brillante esempio di come i più classici temi della fantascienza possono ancora offrire ottime opportunità per storie straordinarie. In questo caso si parla di viaggi nel tempo all'epoca dell'Arabia affascinante delle Mille e un notte, per un racconto che si distingue per la meravigliosa cura dei dettagli e un meccanismo narrativo a orologeria.
Dopo un simile esempio è difficile proporre altra fantascienza allo stesso livello. In effetti nessuno degli altri racconti che arricchiscono questo Robot è all'altezza di quello di Chiang. Tra quelli da ricordare vanno citati almeno L'ospite di Giampietro Stocco, che nonostante qualche furbizia di troppo è un pregevole racconto ambientato in una Terra futura in bilico tra tribalismi e post-umanesimo, e Chi ha paura di Wolf 359? di Ken MacLeod, che si muove agile e veloce sui terreni classici dell'avventura spaziale, tra colonie perdute e minacce cosmiche.
Jostein Gaarder - C'è nessuno?
C'è nessuno? è una piccola storia per fanciulli che ho letto dietro richiesta di mio figlio. Nonostante il sapore fantascientifico - c'è un bimbo alieno che piomba inaspettato sulla Terra - questa storia vira troppo sul pedagogico andante per essere davvero divertente. Certo, si pone l'attenzione sulla curiosità e sulla capacità di porre le giuste domande, ma con un sapore da predicozzo che non mi è mica piaciuto tanto. Jacopo comunque lo ha apprezzato, anche se non ha saputo spiegarmi bene perché.
Stephen King - La sfera del buio
Quarto capitolo della storia di Roland e compagni alla ricerca della Torre Nera. Senza dubbio la cosa migliore del romanzo è l'ambientazione western condita di soprannaturale, insieme alla consueta ottima gestione di personaggi e avvenimenti da parte di Stephen King. La fine dell'infanzia di Roland, la sua tormentata storia d'amore, il rapporto con gli amici e il peso della responsabilità sono resi ottimamente, e il romanzo si rivela appassionante fino alla sua conclusione.
L'unico aspetto che continua a non convincermi mano a mano che proseguo nella lettura della saga è l'inconsueta trasparenza dei meccanismi narrativi che fanno procedere la storia. Come se dietro le gesta dei protagonisti e la messe di avvenimenti che si susseguono ne La sfera del buio, come del resto nel precedente Terre desolate, si avvertissero la meccanicità di certe azioni/reazioni e lo schema e il progetto della saga. Tanto che, nonostante il tiro e le indubbie emozioni, mi è rimasta la fastidiosa sensazione che il laboratorio creativo dell'autore non fosse sufficientemente mimetizzato tra le pagine del romanzo.
Andrea Camilleri - Le ali della sfinge
Ah, Montalbano… Non l'ho mai letto con dedizione e costanza, tanto meno badando alla sequenza dei romanzi o ai cambiamenti delle vite dei vari personaggi. Però ogni volta che mi capita di leggere uno di questi romanzi di Camilleri è come ritrovare un vecchio amico e, soprattutto, la stessa Sicilia che ricordo da un paio di viaggi da quelle parti (quanto tempo è passato…).
Sulla storia c'è poco da dire, la trama gialla m'è parsa più forte e vera dell'ultima che ho letto, ma altrettanto spalmata su un romanzo che vorrebbe dire altro e di più di quello che appare a prima vista. La Sicilia appunto, e la durezza e la meraviglia del vivere da quelle parti.
Primo Levi - Il sistema periodico
"… "Il sistema periodico" vuole essere in primo luogo polemico verso una cultura accademica e umanistica che esclude la possibilità di interpretare la scienza, la materia, l'esperienza concreta in termini poetici." (Primo Levi, estratto da un 'intervista su Rosalucsemblog)
Mi ero ripromesso già da tempo di leggere di racconti di Primo Levi. Me ne avevano parlato bene in tanti, ma per un motivo o per l'altro continuavo a rimandare. Il problema probabilmente stava nell'identificare Primo Levi con l'esperienza del Lager, nel non riuscire a vederlo come persona piena, completa, con una vita che andasse oltre quell'anno trascorso ad Auschwitz. In breve, nel non voler trasformare il simbolo in persona, il testimone in semplice scrittore.
Ora che ho letto Il sistema periodico posso dire che Primo Levi era un ottimo autore, capace di coniugare mirabilmente l'esperienza con la scrittura, la biografia con l'invenzione, mantenendo ben salda la barra della concretezza, legandosi ben saldo alla terra (che vuol dire chimica e lavoro e chiarezza d'espressione e d'intenti) piuttosto che agli spazi eterei dell'arte e dello spirito tanto cari alla massa imbelle degli scrittori nostrani. Doveva essere una persona interessante Primo Levi, ed è una fortuna poterlo ri-conoscere attraverso i suoi libri.
…
Sono rimasto un po' indietro con la lettura di Robot. Il numero 55 risale ormai a un paio d'anni fa (nel frattempo siamo arrivati al 59, se non sbaglio) ma pian pianino conto di rimettermi in pari (datemi delle giornate di 36 ore, per favore!).
La gemma di questo numero è (ovviamente!) il racconto di Ted Chiang: Il mercante e il portale dell’alchimista è un brillante esempio di come i più classici temi della fantascienza possono ancora offrire ottime opportunità per storie straordinarie. In questo caso si parla di viaggi nel tempo all'epoca dell'Arabia affascinante delle Mille e un notte, per un racconto che si distingue per la meravigliosa cura dei dettagli e un meccanismo narrativo a orologeria.
Dopo un simile esempio è difficile proporre altra fantascienza allo stesso livello. In effetti nessuno degli altri racconti che arricchiscono questo Robot è all'altezza di quello di Chiang. Tra quelli da ricordare vanno citati almeno L'ospite di Giampietro Stocco, che nonostante qualche furbizia di troppo è un pregevole racconto ambientato in una Terra futura in bilico tra tribalismi e post-umanesimo, e Chi ha paura di Wolf 359? di Ken MacLeod, che si muove agile e veloce sui terreni classici dell'avventura spaziale, tra colonie perdute e minacce cosmiche.
Jostein Gaarder - C'è nessuno?
C'è nessuno? è una piccola storia per fanciulli che ho letto dietro richiesta di mio figlio. Nonostante il sapore fantascientifico - c'è un bimbo alieno che piomba inaspettato sulla Terra - questa storia vira troppo sul pedagogico andante per essere davvero divertente. Certo, si pone l'attenzione sulla curiosità e sulla capacità di porre le giuste domande, ma con un sapore da predicozzo che non mi è mica piaciuto tanto. Jacopo comunque lo ha apprezzato, anche se non ha saputo spiegarmi bene perché.
Stephen King - La sfera del buio
Quarto capitolo della storia di Roland e compagni alla ricerca della Torre Nera. Senza dubbio la cosa migliore del romanzo è l'ambientazione western condita di soprannaturale, insieme alla consueta ottima gestione di personaggi e avvenimenti da parte di Stephen King. La fine dell'infanzia di Roland, la sua tormentata storia d'amore, il rapporto con gli amici e il peso della responsabilità sono resi ottimamente, e il romanzo si rivela appassionante fino alla sua conclusione.
L'unico aspetto che continua a non convincermi mano a mano che proseguo nella lettura della saga è l'inconsueta trasparenza dei meccanismi narrativi che fanno procedere la storia. Come se dietro le gesta dei protagonisti e la messe di avvenimenti che si susseguono ne La sfera del buio, come del resto nel precedente Terre desolate, si avvertissero la meccanicità di certe azioni/reazioni e lo schema e il progetto della saga. Tanto che, nonostante il tiro e le indubbie emozioni, mi è rimasta la fastidiosa sensazione che il laboratorio creativo dell'autore non fosse sufficientemente mimetizzato tra le pagine del romanzo.
Andrea Camilleri - Le ali della sfinge
Ah, Montalbano… Non l'ho mai letto con dedizione e costanza, tanto meno badando alla sequenza dei romanzi o ai cambiamenti delle vite dei vari personaggi. Però ogni volta che mi capita di leggere uno di questi romanzi di Camilleri è come ritrovare un vecchio amico e, soprattutto, la stessa Sicilia che ricordo da un paio di viaggi da quelle parti (quanto tempo è passato…).
Sulla storia c'è poco da dire, la trama gialla m'è parsa più forte e vera dell'ultima che ho letto, ma altrettanto spalmata su un romanzo che vorrebbe dire altro e di più di quello che appare a prima vista. La Sicilia appunto, e la durezza e la meraviglia del vivere da quelle parti.
Primo Levi - Il sistema periodico
"… "Il sistema periodico" vuole essere in primo luogo polemico verso una cultura accademica e umanistica che esclude la possibilità di interpretare la scienza, la materia, l'esperienza concreta in termini poetici." (Primo Levi, estratto da un 'intervista su Rosalucsemblog)
Mi ero ripromesso già da tempo di leggere di racconti di Primo Levi. Me ne avevano parlato bene in tanti, ma per un motivo o per l'altro continuavo a rimandare. Il problema probabilmente stava nell'identificare Primo Levi con l'esperienza del Lager, nel non riuscire a vederlo come persona piena, completa, con una vita che andasse oltre quell'anno trascorso ad Auschwitz. In breve, nel non voler trasformare il simbolo in persona, il testimone in semplice scrittore.
Ora che ho letto Il sistema periodico posso dire che Primo Levi era un ottimo autore, capace di coniugare mirabilmente l'esperienza con la scrittura, la biografia con l'invenzione, mantenendo ben salda la barra della concretezza, legandosi ben saldo alla terra (che vuol dire chimica e lavoro e chiarezza d'espressione e d'intenti) piuttosto che agli spazi eterei dell'arte e dello spirito tanto cari alla massa imbelle degli scrittori nostrani. Doveva essere una persona interessante Primo Levi, ed è una fortuna poterlo ri-conoscere attraverso i suoi libri.
…
01 giugno 2010
Nova Swing
Qualche giorno fa si discuteva della fantascienza di Michael John Harrison.
Ora che Nova Swing sta per arrivare in edicola non posso esimermi dal segnalarlo a tutti i lettori del blog.
Non so se la mia reazione a questo romanzo sarà migliore di quella, negativa, che è seguita alla lettura di Luce dell'universo. Di sicuro la fantascienza di Harrison è decisamente diversa da quella che i lettori di Urania sono abituati a leggere.
Voi dategli una possibilità, che poi magari se ne riparla.
Trattandosi di Urania un'avvertimento è obbligatorio: se volete leggere questo romanzo procuratevelo in fretta, che tra un mese sparisce.
…
Ora che Nova Swing sta per arrivare in edicola non posso esimermi dal segnalarlo a tutti i lettori del blog.
Non so se la mia reazione a questo romanzo sarà migliore di quella, negativa, che è seguita alla lettura di Luce dell'universo. Di sicuro la fantascienza di Harrison è decisamente diversa da quella che i lettori di Urania sono abituati a leggere.
Voi dategli una possibilità, che poi magari se ne riparla.
Trattandosi di Urania un'avvertimento è obbligatorio: se volete leggere questo romanzo procuratevelo in fretta, che tra un mese sparisce.
…
31 maggio 2010
Letture aprile-maggio 2010 - seconda parte
Charles Stross - Halting State
Decidere di scrivere un romanzo di fantascienza ambientato pochi anni nel futuro e non virarlo in catastrofe o rivoluzione è sempre un grosso rischio. Ma a Charlie Stross piace rischiare, e con Halting State ottiene un grande risultato, riuscendo a coniugare un ottimo giallo fantascientifico con una credibile estrapolazione delle tendenze tecnologico-sociali di questi anni.
Come sempre nelle opere di Stross le idee si sprecano. In Halting State si passa con nonchalance dalle rapine a mano armata ai danni di banche virtuali alle meraviglie della realtà aumentata, dalla Scozia nazione indipendente ai conflitti di competenze tra forze di polizia diverse, alla dura vita di freelancer e dipendenti alle prese con superiori più o meno competenti, il tutto insaporito da una spruzzata di spionaggio internazionale e qualche omicidio assortito. Ma Stross non si accontenta di sfornare trovate e speculazioni a go go, lo fa pure in maniera divertente (e divertita), con più di una strizzatina d'occhio a tutti i nerd qua fuori.
La fantascienza di Charlie Stross sta diventando un riferimento sempre più importante nel panorama internazionale e un romanzo come questo è decisamente inconsueto. Certo, ci sono altri autori che esplorano la normalità del prossimo futuro, ma scelgono solitamente panorami più esotici (penso a Ian McDonald) o abbandonano le caratteristiche più salienti del genere (penso a William Gibson). L'unico altro autore di peso che si muove in ambiti paralleli a quelli strossiani credo sia Greg Egan , almeno prima di darsi alla space opera più spinta (ma che già col prossimo romanzo dovrebbe tornare a frequentare tempi a noi più vicini).
(Sui rischi connessi alla scrittura di fantascienza ambientata nel futuro prossimo potete dare un'occhiata a questo post, che riguarda i problemi che sta incontrando Stross nella stesura del seguito di Halting State.)
Margaret Killjoy - Guida steampunk all'apocalisse
Non so quanti di voi ricordano il leggendario e famigerato Manuale delle Giovani Marmotte. Beh, questa Guida steampunk all'apocalisse ne è la versione riveduta e corretta - decisamente più cool - per questi tempi confusi.
Più che il contenuto manualistico, in realtà piuttosto scarsino, il volumetto è interessante per il tentativo di stabilire qualche punto fermo in materia di Steampunk, intendendo il termine sia nel senso di stile di vita (!!!) che in quello, più limitato, ma certo più conosciuto, di corrente letteraria, prendendo come riferimento il movimento artigianale/artistico riconducibile alla passione per la macchina a vapore (o per meglio dire: alla tecnologia fai da te) e per i formalismi estetici pseudo-proto-tardo-vittoriani.
A parte tutte le belle chiacchiere, a me pare che tolto l'indubbio fascino visivo (dovuto, credo, a un mix di nostalgia analogica e semplicità d'approccio) lo Steampunk sia per questo secolo quello che il medioevo fantastico di derivazione Howard/Tolkeniana è stato per la seconda metà del novecento. Roba che nonostante tutte le buone intenzioni dei suoi sostenitori tenderà a precipitare in un substrato conservativo senza speranza d'innovazione e soprattutto senza alcun futuro frequentabile. Io comunque rimango alla finestra, che (speriamo!) magari mi sbaglio.
Elmore Leonard - Il grande salto
Dopo la scorpacciata western di qualche mese fa ecco il primo romanzo contemporaneo di Elmore Leonard.
Il grande salto è un thriller piuttosto confuso nelle sue premesse e disordinato nella strada che percorre per arrivare alla conclusione, però è graziato da un'ottima scrittura, dalla perfetta padronanza dell'umanità dei vari personaggi e dal taglio unico dei dialoghi. Del resto potete chiederlo a chiunque: Leonard è famoso proprio per questo.
Però il taglio secco ed essenziale dei racconti western era davvero un'altra cosa.
…
Decidere di scrivere un romanzo di fantascienza ambientato pochi anni nel futuro e non virarlo in catastrofe o rivoluzione è sempre un grosso rischio. Ma a Charlie Stross piace rischiare, e con Halting State ottiene un grande risultato, riuscendo a coniugare un ottimo giallo fantascientifico con una credibile estrapolazione delle tendenze tecnologico-sociali di questi anni.
Come sempre nelle opere di Stross le idee si sprecano. In Halting State si passa con nonchalance dalle rapine a mano armata ai danni di banche virtuali alle meraviglie della realtà aumentata, dalla Scozia nazione indipendente ai conflitti di competenze tra forze di polizia diverse, alla dura vita di freelancer e dipendenti alle prese con superiori più o meno competenti, il tutto insaporito da una spruzzata di spionaggio internazionale e qualche omicidio assortito. Ma Stross non si accontenta di sfornare trovate e speculazioni a go go, lo fa pure in maniera divertente (e divertita), con più di una strizzatina d'occhio a tutti i nerd qua fuori.
La fantascienza di Charlie Stross sta diventando un riferimento sempre più importante nel panorama internazionale e un romanzo come questo è decisamente inconsueto. Certo, ci sono altri autori che esplorano la normalità del prossimo futuro, ma scelgono solitamente panorami più esotici (penso a Ian McDonald) o abbandonano le caratteristiche più salienti del genere (penso a William Gibson). L'unico altro autore di peso che si muove in ambiti paralleli a quelli strossiani credo sia Greg Egan , almeno prima di darsi alla space opera più spinta (ma che già col prossimo romanzo dovrebbe tornare a frequentare tempi a noi più vicini).
(Sui rischi connessi alla scrittura di fantascienza ambientata nel futuro prossimo potete dare un'occhiata a questo post, che riguarda i problemi che sta incontrando Stross nella stesura del seguito di Halting State.)
Margaret Killjoy - Guida steampunk all'apocalisse
Non so quanti di voi ricordano il leggendario e famigerato Manuale delle Giovani Marmotte. Beh, questa Guida steampunk all'apocalisse ne è la versione riveduta e corretta - decisamente più cool - per questi tempi confusi.
Più che il contenuto manualistico, in realtà piuttosto scarsino, il volumetto è interessante per il tentativo di stabilire qualche punto fermo in materia di Steampunk, intendendo il termine sia nel senso di stile di vita (!!!) che in quello, più limitato, ma certo più conosciuto, di corrente letteraria, prendendo come riferimento il movimento artigianale/artistico riconducibile alla passione per la macchina a vapore (o per meglio dire: alla tecnologia fai da te) e per i formalismi estetici pseudo-proto-tardo-vittoriani.
A parte tutte le belle chiacchiere, a me pare che tolto l'indubbio fascino visivo (dovuto, credo, a un mix di nostalgia analogica e semplicità d'approccio) lo Steampunk sia per questo secolo quello che il medioevo fantastico di derivazione Howard/Tolkeniana è stato per la seconda metà del novecento. Roba che nonostante tutte le buone intenzioni dei suoi sostenitori tenderà a precipitare in un substrato conservativo senza speranza d'innovazione e soprattutto senza alcun futuro frequentabile. Io comunque rimango alla finestra, che (speriamo!) magari mi sbaglio.
Elmore Leonard - Il grande salto
Dopo la scorpacciata western di qualche mese fa ecco il primo romanzo contemporaneo di Elmore Leonard.
Il grande salto è un thriller piuttosto confuso nelle sue premesse e disordinato nella strada che percorre per arrivare alla conclusione, però è graziato da un'ottima scrittura, dalla perfetta padronanza dell'umanità dei vari personaggi e dal taglio unico dei dialoghi. Del resto potete chiederlo a chiunque: Leonard è famoso proprio per questo.
Però il taglio secco ed essenziale dei racconti western era davvero un'altra cosa.
…
26 maggio 2010
England Tour 2010
Approfittando di qualche giorno a casa ho dato una sistemata alle foto scattate nel fine settimana britannico.
Ecco la cronaca fotografica della tre giorni rugbistica in terra d'albione.
Buona visione:
Da Modena a Bristol
A Bath
Millennium Stadium
Lydney, le nostre partite
Lydney, gli altri e il terzo tempo
Verso casa
(purtroppo youtube non ha accettato alcune delle scelte musicali che corredavano gli slideshow. Dato che non ho ne la voglia ne il tempo di rifare tutto, sperando poi che la musica scelta non infranga di nuovo qualche regola di copyright, mi sono accontentato di qualche soluzione di ripiego. Spero che i video siano comunque godibili.)
…
Ecco la cronaca fotografica della tre giorni rugbistica in terra d'albione.
Buona visione:
Da Modena a Bristol
A Bath
Millennium Stadium
Lydney, le nostre partite
Lydney, gli altri e il terzo tempo
Verso casa
(purtroppo youtube non ha accettato alcune delle scelte musicali che corredavano gli slideshow. Dato che non ho ne la voglia ne il tempo di rifare tutto, sperando poi che la musica scelta non infranga di nuovo qualche regola di copyright, mi sono accontentato di qualche soluzione di ripiego. Spero che i video siano comunque godibili.)
…
Iscriviti a:
Post (Atom)