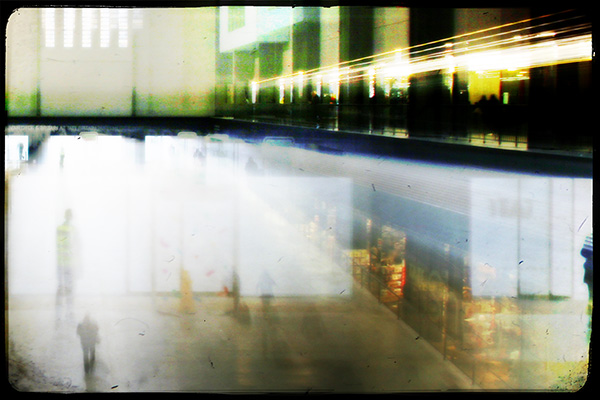Greg Egan - La scala di Schild
La scala di Schild è l'ultimo romanzo di Greg Egan pubblicato in Italia, su Urania, ormai quattro anni fa. Lo conservavo intonso in libreria non essendoci grosse prospettive di nuove opere dell'autore australiano. Però ora è ragionevolmente certa la prossima traduzione di Incandescence. Quindi, perché rimandare ulteriormente?
La scala di Schild si muove nei territori prossimi alla space opera sui generis di Diaspora, privilegiando lo scenario cosmico piuttosto che le speculazioni sul prossimo futuro. Il nucleo della vicenda vede un'umanità sparpagliata per tutta la galassia alle prese con un problema di dimensioni eccezionali: una nuova conformazione fisica della realtà che divora progressivamente lo spazio occupato dai discendenti dell'uomo.
In questo scenario. in cui abbondano miracoli (scientifici!) e meraviglie. si dipana la solita trama eganiana, con un protagonista emotivamente incerto, decisamente più a suo agio nello studio scientifico degli eventi piuttosto che nel rapporto con altri esseri umani.
Per quanto io adori Egan questo romanzo non mi ha entusiasmato quanto i suoi precedenti. L'andamento della vicenda è piuttosto schematico e nonostante le estrapolazioni scientifiche diano il consueto capogiro, questa volta mi sono sembrate meno conturbanti, ricche e stupefacenti di quanto solitamente accade con le vertiginose speculazioni di questo autore. Forse il salto dall'immensamente grande all'incredibilmente piccolo che avviene più volte nel corso del romanzo produce un eccessivo disorientamento e un senso d'irrealtà cui si fa fatica ad adeguarsi, o forse sono le dinamiche umane sottese alla trama che risultano troppo didascaliche e in definitiva non risolte, fatto sta che La scala di Schild, per quanto piacevole, è ben distante dal livello di meraviglia di Diaspora o dalla capacità di riflettere sul presente di opere come Teranesia o Distress.
Greg Egan si conferma ai vertici nel ristretto ambito della produzione fantascientifica più rigorosa e scientificamente attendibile, però ecco, io da lui mi aspetto sempre qualcosa di più.
David Mitchell - Sogno Numero 9
Vatti a fidare dei consigli dei vicini di blog! Questo romanzo mi era stato spacciato per quanto di meglio la fantasy attuale possa offrire al lettore e beh… non è mica vero.
Sogno Numero 9 è un gran bel romanzo, una lettura avvincente e stimolante, ma di fantastico non ha praticamente nulla. Detto questo devo comunque ringraziare Davide Mana per aver citato questo romanzo in un suo vecchio post, perché fantasy o non fantasy il romanzo di David Mitchell s'è rivelato un'ottima lettura.
In Sogno Numero 9 riecheggia tutto il Giappone che ho conosciuto nei romanzi di Murakami o nei film di Kitano, incrociato con una concretezza che m'è parsa decisamente occidentale e un gusto per il pastiche fantastico e per il pulp (da intendersi in senso lato, con la narrazione che non procede mai per la via più spedita ma che si diverte tra deviazioni e sorpassi e sogni e risvegli e improvvise svolte narrative) la cui provenienza non saprei bene dove collocare sull'atlante ma che rende la lettura di questo romanzo un'esperienza a tratti entusiasmante.
David Mitchell è più giapponese di quanto credevo possibile per un occidentale la qual cosa pone alcuni interessanti interrogativi: quanto della mia idea del Giappone corrisponde alla realtà di quel paese? come è stato recepito questo romanzo in terra nipponica? quanto conta l'esperienza di David Mitchell nel contesto in cui s'è trovato a vivere - lui è un inglese trasferitosi per otto anni a Hiroshima a insegnare materie tecniche - per raccontare una storia come questa e non risultare in nessun momento artificiale o forzato?
Quali che siano le risposte a queste domande rimane il fatto che Sogno Numero 9 è uno di quei romanzi che ti colpiscono ben oltre l'ultima pagina. Consigliato.
Nicoletta Vallorani - Il cuore finto di DR
Parte bene Il cuore finto di DR, con quel passo pesante e disincantato del cyberpunk degli inizi. Nessuna ironia, molto noir e una pioggia perenne per calcare la mano sull'atmosfera desolata di una Milano ancor più grigia sporca e disperata di quella che riempie il nostro immaginario. Ben presto però la tenuta del plot deraglia sui dettagli della costruzione di un mondo futuro, che per quanto si sforzi non riesce mai a diventare vero e credibile agli occhi del lettore.
Non so se l'errore di Nicoletta Vallorani sia stato quello di voler mettere troppa carne al fuoco dimenticandosi di mescolare a dovere gli ingredienti, o se l'eccessiva vicinanza a storia e personaggi le ha fatto perdere di vista la prospettiva globale del racconto. Il risultato comunque è un romanzo che soffre di troppe ingenuità per risultare interessante, con una trama che perde nell'incredibilità dei particolari quello che ha faticosamente messo insieme sul piano della complessità delle relazioni tra personaggi.
Questo romanzo ha ormai un paio di decadi sulle spalle, ma non fa che confermare tutti i miei pregiudizi nei confronti della produzione di genere nostrana.
…
21 maggio 2010
13 maggio 2010
Aye, Old England!
 |
| Picture by Iguana Jo. |
Ci si sente la prossima settimana.
Nel frattempo fate a modo!
…
12 maggio 2010
Nicto Mirabilis
Le esperienze degli anni scorsi non sono servite a niente.
Imperterriti e privi di ogni vergogna abbiamo partecipato anche quest'anno a Quattro Giorni Corti, il concorso per cortometraggi organizzato dal Nonantola Film Festival.
Per chi ne fosse all'oscuro Quattro Giorni Corti è un concorso cinematografico che prevede la realizzazione di un cortometraggio di quattro minuti da realizzarsi totalmente nei quattro giorni che vanno dalla sera del mercoledì, giorno in cui vengono sorteggiati i generi ai quali le varie troupe dovranno attenersi, e in cui vengono rivelati gli elementi obbligatori che dovranno comparire nei cortometraggi, fino alla sera della domenica, termine ultimo per la consegna del proprio lavoro.
Quest'anno il genere che ci è capitato in sorte era "documentario", gli elementi obbligatori una cuffia, un compasso e la frase "dobbiamo resistere a tutti i costi".
La troupe quest'anno era decisamente ridotta (e anche un po' malandata) ma non ci siamo persi d'animo e siamo riusciti a completare il nostro documentario nei tempi richiesti.
Qui sotto potete ammirare Nicto Mirabilis. A seguire qualche considerazione sulla realizzazione del corto.
Tenuto conto dei nostri limiti quest'anno siamo abbastanza soddisfatti del nostro cortometraggio. Tanto che per una volta speravamo davvero di riuscire a raggiungere la finale, che consisteva nella proiezione pubblica dei venti migliori cortometraggi pervenuti alla giuria.
Non ci siamo riusciti e la cosa è comprensibile. Non siamo ciechi ai difetti della nostra creatura (i più evidenti sono l'intermezzo fotografico che non siamo riusciti a realizzare come avremmo voluto a causa dei nostri limiti tecnici, e soprattutto il finale, che è frutto di un compromesso dell'ultima ora e che non ha soddisfatto nessuno) ma secondo noi l'idea di base risultava comunque sufficientemente complessa e valida da meritare una maggiore considerazione. Soprattutto dopo aver visto alcuni dei film arrivati alla finale.
Ma vabbé, noi non ci scoraggiamo, che non abbiamo alcuna intenzione di privare il mondo del nostro talento!
…
Imperterriti e privi di ogni vergogna abbiamo partecipato anche quest'anno a Quattro Giorni Corti, il concorso per cortometraggi organizzato dal Nonantola Film Festival.
Per chi ne fosse all'oscuro Quattro Giorni Corti è un concorso cinematografico che prevede la realizzazione di un cortometraggio di quattro minuti da realizzarsi totalmente nei quattro giorni che vanno dalla sera del mercoledì, giorno in cui vengono sorteggiati i generi ai quali le varie troupe dovranno attenersi, e in cui vengono rivelati gli elementi obbligatori che dovranno comparire nei cortometraggi, fino alla sera della domenica, termine ultimo per la consegna del proprio lavoro.
Quest'anno il genere che ci è capitato in sorte era "documentario", gli elementi obbligatori una cuffia, un compasso e la frase "dobbiamo resistere a tutti i costi".
La troupe quest'anno era decisamente ridotta (e anche un po' malandata) ma non ci siamo persi d'animo e siamo riusciti a completare il nostro documentario nei tempi richiesti.
Qui sotto potete ammirare Nicto Mirabilis. A seguire qualche considerazione sulla realizzazione del corto.
Tenuto conto dei nostri limiti quest'anno siamo abbastanza soddisfatti del nostro cortometraggio. Tanto che per una volta speravamo davvero di riuscire a raggiungere la finale, che consisteva nella proiezione pubblica dei venti migliori cortometraggi pervenuti alla giuria.
Non ci siamo riusciti e la cosa è comprensibile. Non siamo ciechi ai difetti della nostra creatura (i più evidenti sono l'intermezzo fotografico che non siamo riusciti a realizzare come avremmo voluto a causa dei nostri limiti tecnici, e soprattutto il finale, che è frutto di un compromesso dell'ultima ora e che non ha soddisfatto nessuno) ma secondo noi l'idea di base risultava comunque sufficientemente complessa e valida da meritare una maggiore considerazione. Soprattutto dopo aver visto alcuni dei film arrivati alla finale.
Ma vabbé, noi non ci scoraggiamo, che non abbiamo alcuna intenzione di privare il mondo del nostro talento!
…
06 maggio 2010
"A IGUANA JO PIACCIONO GLI U2!!! (pensare che pareva uno in gamba...)"
Visto che mi si dileggia per i miei gusti musicali, provare a elencare i motivi per cui un certo gruppo irlandese m'è rimasto nel cuore mi sembra il minimo che possa fare (per compromettere definitivamente la mia credibilità).
- Nel 1983 avevo 16 anni quando uscì un album che, per me che vivevo ai confini del mondo, è sembrato qualcosa di sconvolgente rispetto alla plastica che risuonava dalle radio dell'epoca. Dovevo ancora scoprire i Clash veri, ma quel disco risuonava nella mia testa come più tardi avrebbe fatto London Calling. Ero ignorante, certo, ma War ha davvero cambiato la rotta dei miei gusti musicali.
- Primi anni '80: di concerti dalle mie parti nemmeno a parlarne (oh sì, ogni tanto capitava Vasco o Baglioni, o cantanti simili, ma concerti rock? Figurarsi…). Immaginatevi l'impatto di Under a Blood Red Sky e del video di un concerto tra le rosse rocce del Colorado.
- Per tutti noi c'è quella canzone che ti rimane dentro per sempre. legata com'è a un determinato periodo, a certe sensazioni, a una precisa esperienza. Nel giro dei tre anni che hanno preceduto la mia partenza da quella piccola città questi ragazzotti me ne hanno regalate una mezza dozzina. E voi dite che me ne dovrei dimenticare?
- Arriviamo al 1987. Nel frattempo sono cresciuto, ho scoperto un sacco di altra bella musica. Ma nel mese di maggio di quell'anno si terranno a Modena due concerti che rimangono ad oggi - specialmente il primo - uno degli spettacoli più emozionanti cui abbia mai assistito. E dopo certe emozioni un minimo di gratitudine bisogna averla.
- Nel 1988 io e il mio amico Paolo andiamo in autostop negli States. In giro per le strade d'America la cosa più simile a ricordarci contemporaneamente da dove arrivavamo e dove stavamo andando erano le note degli U2 che risuonavano spesso e volentieri dalle radio che accompagnavano il nostro viaggio. Era l'anno di Rattle and Hum ed eravamo nel posto giusto al momento giusto.
- Negli anni '90 l'adolescenza era un lontano ricordo. Ma certi legami non si spezzano facilmente ed era confortante sentire che se tu cambiavi, anche il gruppo musicale cui eri più affezionato non si riduceva a ripetersi, ma esplorava nuove possibilità.
Si spostava verso pop ed elettronica, ok. Ma se questo è il prezzo per canzoni come One allora beh… io sono più che disposto a pagarlo e pagarlo e pagarlo.
- Ora che gli U2 sono diventati un classico per vecchie cariatidi è facile sputargli addosso.
Mi dicono che è il loro atteggiamento a risultare insopportabile, che i soldi, il successo, le tasse e le prediche, e cambiamo il mondo e siamo tutti più buoni…
Per me sono stronzate.
Come se essere famosi costringesse a diventar santi, a non sbagliare più, a muoversi su un livello diverso da quello di noi comuni mortali. Come se fare i musicisti non fosse un mestiere come un altro, fatto da persone uguali a noi, solo con un talento diverso.
Non so perché guardando in giro tra le mie conoscenze in rete gli U2 raccolgano tanta antipatia. Io comunque a Bono & Co. rimango affezionato.
Mi hanno regalato bei momenti, ed è più di quel che posso dire della maggior parte delle persone che ne parlano male.
"I must be an acrobat
To talk like this
And act like that
And you can dream
So dream out loud
And don't let the bastards grind you down"
…
- Nel 1983 avevo 16 anni quando uscì un album che, per me che vivevo ai confini del mondo, è sembrato qualcosa di sconvolgente rispetto alla plastica che risuonava dalle radio dell'epoca. Dovevo ancora scoprire i Clash veri, ma quel disco risuonava nella mia testa come più tardi avrebbe fatto London Calling. Ero ignorante, certo, ma War ha davvero cambiato la rotta dei miei gusti musicali.
- Primi anni '80: di concerti dalle mie parti nemmeno a parlarne (oh sì, ogni tanto capitava Vasco o Baglioni, o cantanti simili, ma concerti rock? Figurarsi…). Immaginatevi l'impatto di Under a Blood Red Sky e del video di un concerto tra le rosse rocce del Colorado.
- Per tutti noi c'è quella canzone che ti rimane dentro per sempre. legata com'è a un determinato periodo, a certe sensazioni, a una precisa esperienza. Nel giro dei tre anni che hanno preceduto la mia partenza da quella piccola città questi ragazzotti me ne hanno regalate una mezza dozzina. E voi dite che me ne dovrei dimenticare?
- Arriviamo al 1987. Nel frattempo sono cresciuto, ho scoperto un sacco di altra bella musica. Ma nel mese di maggio di quell'anno si terranno a Modena due concerti che rimangono ad oggi - specialmente il primo - uno degli spettacoli più emozionanti cui abbia mai assistito. E dopo certe emozioni un minimo di gratitudine bisogna averla.
- Nel 1988 io e il mio amico Paolo andiamo in autostop negli States. In giro per le strade d'America la cosa più simile a ricordarci contemporaneamente da dove arrivavamo e dove stavamo andando erano le note degli U2 che risuonavano spesso e volentieri dalle radio che accompagnavano il nostro viaggio. Era l'anno di Rattle and Hum ed eravamo nel posto giusto al momento giusto.
- Negli anni '90 l'adolescenza era un lontano ricordo. Ma certi legami non si spezzano facilmente ed era confortante sentire che se tu cambiavi, anche il gruppo musicale cui eri più affezionato non si riduceva a ripetersi, ma esplorava nuove possibilità.
Si spostava verso pop ed elettronica, ok. Ma se questo è il prezzo per canzoni come One allora beh… io sono più che disposto a pagarlo e pagarlo e pagarlo.
- Ora che gli U2 sono diventati un classico per vecchie cariatidi è facile sputargli addosso.
Mi dicono che è il loro atteggiamento a risultare insopportabile, che i soldi, il successo, le tasse e le prediche, e cambiamo il mondo e siamo tutti più buoni…
Per me sono stronzate.
Come se essere famosi costringesse a diventar santi, a non sbagliare più, a muoversi su un livello diverso da quello di noi comuni mortali. Come se fare i musicisti non fosse un mestiere come un altro, fatto da persone uguali a noi, solo con un talento diverso.
Non so perché guardando in giro tra le mie conoscenze in rete gli U2 raccolgano tanta antipatia. Io comunque a Bono & Co. rimango affezionato.
Mi hanno regalato bei momenti, ed è più di quel che posso dire della maggior parte delle persone che ne parlano male.
"I must be an acrobat
To talk like this
And act like that
And you can dream
So dream out loud
And don't let the bastards grind you down"
…
28 aprile 2010
Take the Ball and Run!
Non sono un giocatore di rugby.
Per quanto abbia sempre apprezzato questo sport e nonostante vent'anni fa alcuni dei miei migliori compagni d'avventura fossero rugbisti doc, quando avrei avuto l'età giusta non avevo né il fisico né la forma mentale più adatta per dedicarmi seriamente allo sport. Di giocare a rugby poi, nemmeno a parlarne…
Più o meno un anno e mezzo fa sono cambiate un po' di cose. Non che nel frattempo io abbia messo su il fisico o chissaché. Anzi.
Diciamo che, accompagnando i figli agli allenamenti (di rugby, ovviamente!), la voglia di farsi qualche sgroppata sul campo è cresciuta progressivamente. A questo aggiungeteci un paio di genitori (ovviamente tutti ex-rugbisti che da poco avevano ripreso l'attività sportiva) con i loro "solo per tenersi in forma chetticredi?" oppure "giusto per farti una corsetta, mica devi giocare…" ed ecco che mi si sono spalancate le porte del rugby.
Per farla breve, che tra le altre cose grazie al rugby ora c'ho pure un braccio steccato (e quando ti chiedono"ma cosa ti sei fatto?" e tu "ho preso una botta giocando a rugby" gli sguardi passano nel giro di qualche secondo dal compatimento, all'incredulità al "…pensa te, chi l'avrebbe mai detto…" e ritorno), da un po' di tempo faccio allenamento e gioco con gli ex-giocatori del Modena Rugby.
OK. Non è che giocando con gente che da venti/trent'anni fa viaggiare la palla ovale, gente che è arrivata fino in serie A, nel giro di pochi mesi io abbia imparato cosa vuol dire giocare a rugby.
Diciamocela tutta, come rugbista sono decisamente scarso. Però non me ne frega un granché dal momento che, capace o meno, mi diverto un bel po'. E male che vada posso sempre fare qualche foto.
Dieci giorni fa, al mio secondo torneo, ho anche partecipato al glorioso tuffeta dei Modena Veterans.
Cosa chiedere di più? Un tour nella terra del rugby? Fatto!
A metà maggio andrò in trasferta con i miei compagni di squadra dalle parti di Bristol per un triangolare con una squadra francese e una rappresentativa inglese.
Poi certo, avere più di quarant'anni e godersela come ragazzini a scontrarsi con altri vecchietti in giro per il mondo forse non la racconta molto giusta sulle mie capacità intellettive.
Però oh… tuffeta-tah…!
…
Per quanto abbia sempre apprezzato questo sport e nonostante vent'anni fa alcuni dei miei migliori compagni d'avventura fossero rugbisti doc, quando avrei avuto l'età giusta non avevo né il fisico né la forma mentale più adatta per dedicarmi seriamente allo sport. Di giocare a rugby poi, nemmeno a parlarne…
Più o meno un anno e mezzo fa sono cambiate un po' di cose. Non che nel frattempo io abbia messo su il fisico o chissaché. Anzi.
Diciamo che, accompagnando i figli agli allenamenti (di rugby, ovviamente!), la voglia di farsi qualche sgroppata sul campo è cresciuta progressivamente. A questo aggiungeteci un paio di genitori (ovviamente tutti ex-rugbisti che da poco avevano ripreso l'attività sportiva) con i loro "solo per tenersi in forma chetticredi?" oppure "giusto per farti una corsetta, mica devi giocare…" ed ecco che mi si sono spalancate le porte del rugby.
Per farla breve, che tra le altre cose grazie al rugby ora c'ho pure un braccio steccato (e quando ti chiedono"ma cosa ti sei fatto?" e tu "ho preso una botta giocando a rugby" gli sguardi passano nel giro di qualche secondo dal compatimento, all'incredulità al "…pensa te, chi l'avrebbe mai detto…" e ritorno), da un po' di tempo faccio allenamento e gioco con gli ex-giocatori del Modena Rugby.
OK. Non è che giocando con gente che da venti/trent'anni fa viaggiare la palla ovale, gente che è arrivata fino in serie A, nel giro di pochi mesi io abbia imparato cosa vuol dire giocare a rugby.
Diciamocela tutta, come rugbista sono decisamente scarso. Però non me ne frega un granché dal momento che, capace o meno, mi diverto un bel po'. E male che vada posso sempre fare qualche foto.
Dieci giorni fa, al mio secondo torneo, ho anche partecipato al glorioso tuffeta dei Modena Veterans.
Cosa chiedere di più? Un tour nella terra del rugby? Fatto!
A metà maggio andrò in trasferta con i miei compagni di squadra dalle parti di Bristol per un triangolare con una squadra francese e una rappresentativa inglese.
Poi certo, avere più di quarant'anni e godersela come ragazzini a scontrarsi con altri vecchietti in giro per il mondo forse non la racconta molto giusta sulle mie capacità intellettive.
Però oh… tuffeta-tah…!
…
22 aprile 2010
Ancora sulla fantascienza italiana (poi per un po' basta, promesso)
Nonostante mi fossi ripromesso di astenermi - non per chissà quale nobile o imprescindibile motivo, semplicemente per non annoiare quei tre amici lettori che mi ritrovo - mi è toccato scrivere l'ennesimo post sullo stato della fantascienza italiana. Lo so, ho rotto le palle, ma ve lo dico da subito; se non siete tra quelle quattro persone a cui interessa il dibattito saltate tranquillamente il post. Prometto solennemente che nel prossimo NON si parlerà di fantascienza.
Questo post nasce da una costola del post del 15 aprile. Nello spazio commenti di quel post è intervenuto Carmine Treanni, curatore dello speciale di Delos sulla fantascienza italiana, che ha replicato con spirito costruttivo e dovizia di argomenti agli appunti che facevo al contenuto di quello speciale.
Qui tento di chiarire ulteriormente la mia opinione in merito.
La critica sostanziale che facevo allo speciale di Delos era l'approccio in qualche modo accondiscendente nell'affrontare la questione della qualità della fantascienza prodotta in Italia.
Proprio perché il genere sta godendo di una certa fioritura - almeno a livello produttivo - (e guardate che ne sono ben felice; checché ne dicano in giro, io sono decisamente a favore della buona fantascienza ovunque venga prodotta!) sono convinto che sia necessario raddoppiare gli sforzi critici per esaltarne gli aspetti migliori e censurare senza mezzi termini i tentativi velleitari e/o pretenziosi che rischiano di riportarci alla triste situazione in cui ci si trovava fino a una decina d'anni fa. Certo, fare i dovuti distinguo tra prodotti buoni e meno buoni è attività difficile e rischiosa, legata com'è alla soggettività, all'esperienza e alla reputazione del dato recensore, ma credo che sia su questo terreno che si giochi una partita fondamentale per il futuro della fantascienza. Per questo motivo mi sarei aspettato anche da Fantascienza.com, che rimane lo spazio più autorevole a trattare il genere in italia, un approccio più critico nei confronti di quanto disponibile sul mercato.
A margine di questa constatazione mi chiedevo se, stante la qualità media delle proposte fantascientifiche italiane, fosse giusto privilegiare la pubblicazione di autori nostrani piuttosto che privare il pubblico italiano di opere e scrittori che stanno facendo la storia del nostro genere preferito.
Qui credo ci siano le divergenze più profonde tra la mia opinione e quella di Carmine Treanni.
Carmine scrive che preferisce parlare di fantascienza scritta in italia piuttosto che di fantascienza italiana. Non potrei essere più d'accordo. Per questo motivo mi chiedo: se l'origine geografica del prodotto è indifferente, e quel che conta è unicamente la qualità, perché dovrebbe essere preferibile privilegiare la produzione nazionale piuttosto che quella straniera?
A me non interessa tenere la contabilità geografica degli autori. Mi interessa leggere storie capaci di meravigliarmi, sorprendermi, turbarmi. La mia posizione da lettore e appassionato è: benvenga la fantascienza nostrana, ma che la si pubblichi applicando gli stessi standard che si adottano per il resto della produzione mondiale. Vi pare un approccio così assurdo?
La fantascienza italiana vive, viene pubblicata e viene consumata in una costante tensione tra due forze opposte e ugualmente deleterie: c'è chi la detesta per partito preso, chi non crede nemmeno possa esistere, chi non perde occasione per dare addosso a chiunque osi solo accennarne (ma questo partito mi pare in leggero calo nell'ultimo periodo) e chi invece al contrario la esalta aprioristicamente, chi la sostiene senza neppure leggerla (conosco scrittori che han sempre comperato ogni volume di fantascienza italiana pubblicato, pur di contribuire in qualche modo alla causa), chi si entusiasma al minimo accenno di italianità comparso in un testo. E poi ovviamente ci sono i tifosi: i parenti e gli amici dell'ultimo autore appena pubblicato, gli ultras dello sberleffo e della critica oggettiva del testo e compagnia cantante…
Da quando frequento il fandom - e sono ormai una buona dozzina d'anni - ho sempre visto la fantascienza italiana vivere in un regime di trattamento speciale. Ma quali sono le ragioni profonde che inducono chiunque se ne occupi a considerare la fantascienza scritta in Italia come un mostro alieno?
Perché solo a nominare le parole fantascienza italiana si devono suscitare sempre tali vespai?
Perché qua in giro siamo tutti così suscettibili? È una caratteristica genetica del lettore fantascientifico o è una tara ambientale?
Prendendo spunto da quel che scriveva Carmine provo a elencare qualche risposta, se volete contribuire fatevi sotto…
- è una questione culturale.
Nell'intervento di Carmine Treanni questa "questione culturale" assume un aspetto ben più positivo di quel che usava essere (si deve pubblicare la sf italiana perché siamo in Italia, perdio!). Nelle sue parole si presume un'apertura dell'industria editoriale al prodotto fantascientifico italiano. Fosse vero sarebbe meraviglioso, perché significherebbe prima di tutto uno sdoganamento della sf tout court.
Invece, se di apertura si tratta, questa riguarda due/tre editori: Mondadori, (o meglio la sua divisione editoriale per le edicole), DelosBooks che però una certa attenzione alla produzione nostrana l'ha dimostrata sin dalle sue origini (vedi i volumi di Zunic e Cola editi dalla sua incarnazione editoriale primordiale) e poi chi altri? A beh… Elara, che però se non la cerchi difficilmente la incontri sul tuo cammino. Insomma a me pare che tolta la corazzata Urania, ci siano da festeggiare ben poche aperture culturali che dir si voglia.
- se non li pubblichi non crescono.
Quest'affermazione ha certamente un fondo di verità. Senza una scena viva e pulsante difficilmente si creano le premesse perché nuovi scrittori possano nascere e sviluppare le loro doti. Ora mi chiedo, quale scena fantascientifica potrà mai nascere in Italia, se andando in libreria non si trova praticamente nulla di quel che di buono viene pubblicato nel resto del mondo?
Insomma prima di coltivare un vivaio di scrittori sarebbe il caso di darsi da fare a crescere una generazione di lettori. E secondo me più roba buona si rende disponibile più è probabile che Tizio o Caio si mettano a scrivere opere ispirate. Si torna quindi al discorso iniziale: pasturateci a libri ottimi e vedrete che i frutti non mancheranno. Dateci la solita fuffa e altra fuffa leggerete (vedi ben la scena fantasy, per un esempio non troppo campato in aria).
- e il lettore dov'é?
a me pare che molti dei problemi della scrittura di genere in italia siano dovuti a una sorta di autorcentrismo dell'ambiente. La maggior parte dei personaggi attivi nel fandom è formata da scrittori wannabe (oltre che da qualche scrittore vero, prontamente invidiato / esaltato / deriso / acclamato dalla claque del caso). Il 90% delle figure che ruotano intorno alla catena produttiva sono anch'essi autori part-time. Per quella che è la mia esperienza la cosa più importante per molte di queste persone è arrivare alla pubblicazione (l'editore è indifferente, l'edizione pure, la distribuzione un dettaglio, etc etc). Dal loro punto di vista, assolutamente legittimo, essere pubblicati corrisponde ad una sorta di consacrazione. Ora Sono Uno Scrittore.
I motivi di questo stato di cose sono da attribuire ai più diversi motivi: il fatto che l'industria culturale italiana ha sempre disprezzato il genere, costringendo chiunque avesse qualche velleità autoriale ad arrangiarsi; il conseguente dilettantismo nei suoi aspetti migliori (l'entusiasmo) e peggiori (la scarsa professionalità); quella strana cosa che è l'orgoglio del ghetto; il nascere di dinamiche amicali perverse (se hai una persona piazzata al posto giusto si aprono le porte al clan).
Nessuno di questi fattori è il male incarnato, ma tutti contribuiscono ad un circolo vizioso la cui unica vittima è la qualità della narrativa e l'unico a rimetterci è il lettore. Sì, proprio quel lettore che tutti cercano, ma che nessuno sembra mai voler porre al centro del suo lavoro.
- che abbiano ragione gli uffici marketing?
gli uffici marketing dominano i colossi editoriali e odiano la fantascienza e quel che è peggio odiano i lettori di fantascienza. Il loro piano è eliminarci tutti uno a uno eliminando la letteratura che ci sostiene e che potrebbe portarci alla moltiplicazione incontrollata.
Ci odiano, non c'è dubbio. Altrimenti come spiegare l'assenza ormai decennale di una qualsiasi collana libraria dedicata alla fantascienza? (no, voi di Delos non fate eccezione, voi non avete un ufficio marketing!)
Se c'è una cosa che odiano di più della fantascienza è senza ombra di dubbio la fantascienza italiana.
Qualcuno ha mai preso in considerazione l'idea che forse, magari, abbiano ragione?
Come si fa a vendere un libro di fantascienza in Italia? Tutte i tentativi degli ultimi vent'anni han dato esito disastroso, dall'Einaudi Vertigo a Fanucci, dai Cosmo Oro della Nord all'ultimo apprezzabile tentativo di Armenia. Al momento l'unica collana di inediti che sopravvive in libreria è Odissea (un nome un programma!) che grazie alla prudenza e all'accortezza dei suoi curatori sembra ritagliarsi uno spazio sempre più visibile in libreria.
A voi lettori lì fuori va bene così?
A me no, ma a parte dibattere sui motivi per cui le cose sono arrivate a 'sto punto , avete un'idea su come risollevare le sorti del panorama fantascientifico nazionale? Io non ne ho, ma non mi rassegno. Per esempio, sono sicuro che la qualità alla lunga premia, che pubblicare solo per riempire gli scaffali non ha senso, che senza un continuo confronto tra lettori e scrittori ed editori non si va da nessuna parte.
Come sono altrettanto sicuro che senza un'apertura al grande mondo la fuori non ci sia alcuna speranza per il piccolo universo fantascientifico nostrano.
A voi la palla…
…
Questo post nasce da una costola del post del 15 aprile. Nello spazio commenti di quel post è intervenuto Carmine Treanni, curatore dello speciale di Delos sulla fantascienza italiana, che ha replicato con spirito costruttivo e dovizia di argomenti agli appunti che facevo al contenuto di quello speciale.
Qui tento di chiarire ulteriormente la mia opinione in merito.
La critica sostanziale che facevo allo speciale di Delos era l'approccio in qualche modo accondiscendente nell'affrontare la questione della qualità della fantascienza prodotta in Italia.
Proprio perché il genere sta godendo di una certa fioritura - almeno a livello produttivo - (e guardate che ne sono ben felice; checché ne dicano in giro, io sono decisamente a favore della buona fantascienza ovunque venga prodotta!) sono convinto che sia necessario raddoppiare gli sforzi critici per esaltarne gli aspetti migliori e censurare senza mezzi termini i tentativi velleitari e/o pretenziosi che rischiano di riportarci alla triste situazione in cui ci si trovava fino a una decina d'anni fa. Certo, fare i dovuti distinguo tra prodotti buoni e meno buoni è attività difficile e rischiosa, legata com'è alla soggettività, all'esperienza e alla reputazione del dato recensore, ma credo che sia su questo terreno che si giochi una partita fondamentale per il futuro della fantascienza. Per questo motivo mi sarei aspettato anche da Fantascienza.com, che rimane lo spazio più autorevole a trattare il genere in italia, un approccio più critico nei confronti di quanto disponibile sul mercato.
A margine di questa constatazione mi chiedevo se, stante la qualità media delle proposte fantascientifiche italiane, fosse giusto privilegiare la pubblicazione di autori nostrani piuttosto che privare il pubblico italiano di opere e scrittori che stanno facendo la storia del nostro genere preferito.
Qui credo ci siano le divergenze più profonde tra la mia opinione e quella di Carmine Treanni.
Carmine scrive che preferisce parlare di fantascienza scritta in italia piuttosto che di fantascienza italiana. Non potrei essere più d'accordo. Per questo motivo mi chiedo: se l'origine geografica del prodotto è indifferente, e quel che conta è unicamente la qualità, perché dovrebbe essere preferibile privilegiare la produzione nazionale piuttosto che quella straniera?
A me non interessa tenere la contabilità geografica degli autori. Mi interessa leggere storie capaci di meravigliarmi, sorprendermi, turbarmi. La mia posizione da lettore e appassionato è: benvenga la fantascienza nostrana, ma che la si pubblichi applicando gli stessi standard che si adottano per il resto della produzione mondiale. Vi pare un approccio così assurdo?
La fantascienza italiana vive, viene pubblicata e viene consumata in una costante tensione tra due forze opposte e ugualmente deleterie: c'è chi la detesta per partito preso, chi non crede nemmeno possa esistere, chi non perde occasione per dare addosso a chiunque osi solo accennarne (ma questo partito mi pare in leggero calo nell'ultimo periodo) e chi invece al contrario la esalta aprioristicamente, chi la sostiene senza neppure leggerla (conosco scrittori che han sempre comperato ogni volume di fantascienza italiana pubblicato, pur di contribuire in qualche modo alla causa), chi si entusiasma al minimo accenno di italianità comparso in un testo. E poi ovviamente ci sono i tifosi: i parenti e gli amici dell'ultimo autore appena pubblicato, gli ultras dello sberleffo e della critica oggettiva del testo e compagnia cantante…
Da quando frequento il fandom - e sono ormai una buona dozzina d'anni - ho sempre visto la fantascienza italiana vivere in un regime di trattamento speciale. Ma quali sono le ragioni profonde che inducono chiunque se ne occupi a considerare la fantascienza scritta in Italia come un mostro alieno?
Perché solo a nominare le parole fantascienza italiana si devono suscitare sempre tali vespai?
Perché qua in giro siamo tutti così suscettibili? È una caratteristica genetica del lettore fantascientifico o è una tara ambientale?
Prendendo spunto da quel che scriveva Carmine provo a elencare qualche risposta, se volete contribuire fatevi sotto…
- è una questione culturale.
Nell'intervento di Carmine Treanni questa "questione culturale" assume un aspetto ben più positivo di quel che usava essere (si deve pubblicare la sf italiana perché siamo in Italia, perdio!). Nelle sue parole si presume un'apertura dell'industria editoriale al prodotto fantascientifico italiano. Fosse vero sarebbe meraviglioso, perché significherebbe prima di tutto uno sdoganamento della sf tout court.
Invece, se di apertura si tratta, questa riguarda due/tre editori: Mondadori, (o meglio la sua divisione editoriale per le edicole), DelosBooks che però una certa attenzione alla produzione nostrana l'ha dimostrata sin dalle sue origini (vedi i volumi di Zunic e Cola editi dalla sua incarnazione editoriale primordiale) e poi chi altri? A beh… Elara, che però se non la cerchi difficilmente la incontri sul tuo cammino. Insomma a me pare che tolta la corazzata Urania, ci siano da festeggiare ben poche aperture culturali che dir si voglia.
- se non li pubblichi non crescono.
Quest'affermazione ha certamente un fondo di verità. Senza una scena viva e pulsante difficilmente si creano le premesse perché nuovi scrittori possano nascere e sviluppare le loro doti. Ora mi chiedo, quale scena fantascientifica potrà mai nascere in Italia, se andando in libreria non si trova praticamente nulla di quel che di buono viene pubblicato nel resto del mondo?
Insomma prima di coltivare un vivaio di scrittori sarebbe il caso di darsi da fare a crescere una generazione di lettori. E secondo me più roba buona si rende disponibile più è probabile che Tizio o Caio si mettano a scrivere opere ispirate. Si torna quindi al discorso iniziale: pasturateci a libri ottimi e vedrete che i frutti non mancheranno. Dateci la solita fuffa e altra fuffa leggerete (vedi ben la scena fantasy, per un esempio non troppo campato in aria).
- e il lettore dov'é?
a me pare che molti dei problemi della scrittura di genere in italia siano dovuti a una sorta di autorcentrismo dell'ambiente. La maggior parte dei personaggi attivi nel fandom è formata da scrittori wannabe (oltre che da qualche scrittore vero, prontamente invidiato / esaltato / deriso / acclamato dalla claque del caso). Il 90% delle figure che ruotano intorno alla catena produttiva sono anch'essi autori part-time. Per quella che è la mia esperienza la cosa più importante per molte di queste persone è arrivare alla pubblicazione (l'editore è indifferente, l'edizione pure, la distribuzione un dettaglio, etc etc). Dal loro punto di vista, assolutamente legittimo, essere pubblicati corrisponde ad una sorta di consacrazione. Ora Sono Uno Scrittore.
I motivi di questo stato di cose sono da attribuire ai più diversi motivi: il fatto che l'industria culturale italiana ha sempre disprezzato il genere, costringendo chiunque avesse qualche velleità autoriale ad arrangiarsi; il conseguente dilettantismo nei suoi aspetti migliori (l'entusiasmo) e peggiori (la scarsa professionalità); quella strana cosa che è l'orgoglio del ghetto; il nascere di dinamiche amicali perverse (se hai una persona piazzata al posto giusto si aprono le porte al clan).
Nessuno di questi fattori è il male incarnato, ma tutti contribuiscono ad un circolo vizioso la cui unica vittima è la qualità della narrativa e l'unico a rimetterci è il lettore. Sì, proprio quel lettore che tutti cercano, ma che nessuno sembra mai voler porre al centro del suo lavoro.
- che abbiano ragione gli uffici marketing?
gli uffici marketing dominano i colossi editoriali e odiano la fantascienza e quel che è peggio odiano i lettori di fantascienza. Il loro piano è eliminarci tutti uno a uno eliminando la letteratura che ci sostiene e che potrebbe portarci alla moltiplicazione incontrollata.
Ci odiano, non c'è dubbio. Altrimenti come spiegare l'assenza ormai decennale di una qualsiasi collana libraria dedicata alla fantascienza? (no, voi di Delos non fate eccezione, voi non avete un ufficio marketing!)
Se c'è una cosa che odiano di più della fantascienza è senza ombra di dubbio la fantascienza italiana.
Qualcuno ha mai preso in considerazione l'idea che forse, magari, abbiano ragione?
Come si fa a vendere un libro di fantascienza in Italia? Tutte i tentativi degli ultimi vent'anni han dato esito disastroso, dall'Einaudi Vertigo a Fanucci, dai Cosmo Oro della Nord all'ultimo apprezzabile tentativo di Armenia. Al momento l'unica collana di inediti che sopravvive in libreria è Odissea (un nome un programma!) che grazie alla prudenza e all'accortezza dei suoi curatori sembra ritagliarsi uno spazio sempre più visibile in libreria.
A voi lettori lì fuori va bene così?
A me no, ma a parte dibattere sui motivi per cui le cose sono arrivate a 'sto punto , avete un'idea su come risollevare le sorti del panorama fantascientifico nazionale? Io non ne ho, ma non mi rassegno. Per esempio, sono sicuro che la qualità alla lunga premia, che pubblicare solo per riempire gli scaffali non ha senso, che senza un continuo confronto tra lettori e scrittori ed editori non si va da nessuna parte.
Come sono altrettanto sicuro che senza un'apertura al grande mondo la fuori non ci sia alcuna speranza per il piccolo universo fantascientifico nostrano.
A voi la palla…
…
15 aprile 2010
Leggo, e rilancio.
Probabilmente sto per perdere un'altra occasione per tacere, ma che ci volete fare, quando mi scappa mi scappa…
Ho letto con molto interesse lo speciale sullo stato della fantascienza italiana pubblicato sull'ultimo numero di Delos: come lettore è sempre un piacere leggere quel che pensano della situazione editoriale contingente le persone che i libri li scrivono.
Tolto l'usuale constatazione di come la fantascienza come genere nel suo complesso. e ancor di più nella sua incarnazione nostrana, faccia dannatamente fatica ad arrivare in libreria, la cosa che mi ha colpito dei vari interventi (sono dodici gli scrittori coinvolti) è stato vedere emergere una prospettiva in qualche modo contraddittoria sullo stato della fantascienza italiana: da una lato pare che questo tipo di narrativa non abbia mai avuto un accesso così diffuso alla pubblicazione come invece sta succedendo nell'ultimo paio d'anni, dall'altro si ribadisce come il pubblico dei lettori di fantascienza sia in costante riduzione.
Un altro aspetto dello speciale che mi ha colpito è la dose di melassa sparsa abbondantemente tra le righe dei vari interventi. Va bene la diplomazia, va bene la prudenza, ma quest'approccio alla situazione così morbido, da grande famiglia felice, mi ha provocato un certo fastidio, quasi che parlare di fantascienza, qui e ora, significhi soprattutto fare attenzione a non pestare il piede sbagliato. E qui non mi riferisco tanto agli interventi degli autori, quanto a quelli di contorno che cercando di tracciare un quadro generale sullo stato dell'arte fantascientifica nostrana.
Intendiamoci, io condivido pressoché in toto l'atteggiamento di chi auspica un maggior spirito cooperativo all'interno del genere, di chi chiede di abbattere i muri dei rispettivi orticelli e si appella all'onestà intellettuale di chiunque voglia intervenire per offrire il suo contributo allo sviluppo della scena. Però m'è parso di avvertire come nota di fondo un certo atteggiamento, che dal mio personalissimo punto di vista faccio davvero fatica ad accettare: "tutto va bene, tutto funziona, lasciateli lavorare che le cose andranno sempre meglio, e chi osa dire il contrario rema contro e va bandito".
Certo, io qui sopra esagero di proposito il tono degli interventi di Carmine Treanni, Salvatore Proietti e Giampaolo Rai. Però mi pare innegabile che ci sia un tentativo di assopire o comunque smussare i toni più accesi del dibattito (lasciatemelo chiamare così, anche se…) sullo stato della fantascienza italiana che da sempre appassiona grandi e piccini in giro per la rete.
Di nuovo, l'approccio di cui sopra è comprensibile. Spesso parlando di fantascienza italiana il rumore della polemica è diventato insostenibile e il discorso critico sui testi del tutto accessorio all'esaltazione parossistica dell'ego dei vari recensori, lettori, critici e semplici passanti che vagano come anime in pena per l'inferno della rete in cerca d'attenzione.
Non mi va di ripetere per l'ennesima volta la mia opinione, se vi interessa la potete trovare in calce a questo intervento di X. Qui mi interessa ribadire che a mio parere l'unica risposta al rumore non è tapparsi le orecchie quanto piuttosto fare buona musica, che l'unica risposta al pressapochismo è l'ìnformazione dettagliata, che le chiacchiere superficiali si possono sconfiggere solo con l'approfondimento. Se poi la maggior parte del pubblico preferisce divertirsi tra flame e scambi d'invettive, beh… è un problema che non sono comunque in grado di risolvere. Mi basta tirarmene fuori e sperare che la mia voce non si confonda col rumore di fondo.
Un approccio simile me lo aspetterei anche da chi di fantascienza si occupa seriamente.
Per questo motivo non capisco la necessità di raccontarsi la bella favoletta sullo stato della fantascienza italiana che traspare negli interventi pubblicati su Delos.
Se vogliamo parlare di fantascienza in italia non possiamo davvero fingere che vada davvero tutto così bene.
Per contribuire al dibattito, spero in maniera costruttiva, ecco quelli che secondo me sono un paio dei nodi che lo speciale delosiano evita di affrontare.
- La qualità della fantascienza in Italia.
A me pare che si festeggi il successo della pubblicazione in quanto tale, a prescindere da ogni considerazione, se non come nota a margine, sulla qualità di quanto pubblicato. Io non ho letto tutti i romanzi citati nello speciale, e sarò stato particolarmente sfortunato (o più probabilmente sono troppo esigente), ma la qualità media di quanto letto negli ultimi anni è ben lungi da un livello tale da attirare nuovi lettori al genere.
- Non si è mai pubblicata tanta fantascienza italiana come nell'ultimo periodo.
Siamo sicuri sia un bene? Avete per caso visto moltiplicarsi le pubblicazioni di genere in libreria? A me non sembra. Quindi, se la matematica non è un'opinione, la presenza di un maggior numero di pubblicazioni di autori italiani è andata a discapito della produzione straniera. Da lettore a lettore: siamo sicuri che preferiamo leggere Francesco Verso piuttosto che Iain Banks? o Vittorio Catani invece di Ian McDonald?
Lo so. È un discorso antipatico, e sarei la persona più felice del mondo se in libreria ci fosse spazio per entrambe le proposte. Al momento però mi pare che le cose vadano in questo modo. Dal punto di vista degli autori di genere italiani il momento offre grandi opportunità di vedere i propri sforzi premiati, ma dal mio punto di vista di lettore tocca considerare anche cosa mi sto perdendo.
E poi ci si potrebbe porre anche qualche domandina altrettanto antipatica sui motivi di queste scelte editoriali (nel recente passato la scelta analoga di un editore specializzato di privilegiare autori italiani rispetto ai tradizionali autori anglosassoni è stato il primo segnale della crisi che ha anticipato quella che s'è rivelata poi una situazione irreversibile).
- Ehi! Ma gli altri dove sono?
Non si dovrebbe parlare degli assenti, però ho notato con un certo dispiacere che tra tutti gli interventi di scrittori presentati nello speciale mancano proprio quelli che nell'ultimo periodo ho apprezzato di più. Dove sono Clelia Farris o il gruppo che fa capo ad Alia? Ragazzi, a me piacerebbe davvero conoscere la vostra opinione!
Altre voci che mi sarebbe piaciuto ascoltare sono quelle di un Tullio Avoledo o degli altri autori chiamati da minimum fax a scrivere fantascienza per il progetto Anteprima nazionale, che avrebbero potuto offrire un punto di vista esterno sulla stato della letteratura di genere. Ma ok, non si può avere tutto.
(Sia chiaro che questo NON è una critica a chi ha preparato questo numero monografico di Delos. Qualche anno fa ho curato anch'io un speciale analogo e so quanto è difficile avere risposte rapide da parecchie decine di persone, anche solo a quel paio di domande poste da Delos)
- Il sogno.
Dice bene Salvatore MLK Proietti. Il suo sogno è bellissimo, meraviglioso, decisamente allettante. Ma è un sogno. La realtà, che piaccia o meno, è molto diversa. Io non ho sogni di così squisita fattura e non credo che fare appelli generici serva a qualcosa. Mi limito a osservare che la pluralità di voci, a volte discordanti, spesso stonate, potrebbe ridursi, se non l'ha già fatto, da ricchezza quale dovrebbe essere a mero rumore di fondo.
Credo che solo l'esempio e la qualità delle proposte possa fare la differenza.
Insomma, se amate la fantascienza, datevi una mossa.
E fanculo a chi ci vuole male.
(potrebbe essere utile leggere parallelamente a questo post anche l'intervento di Elvezio Sciallis su Malpertuis. In quel post non si parla di Delos, e nemmeno di fantascienza, si parla di critica, di letteratura e cinema di genere, di internet e dell'aria che tira. Io trovo il suo approccio molto interessante, nonostante il peso della personalità del suo autore rischi a volte di soffocare il valore dei suoi argomenti.)
…
Ho letto con molto interesse lo speciale sullo stato della fantascienza italiana pubblicato sull'ultimo numero di Delos: come lettore è sempre un piacere leggere quel che pensano della situazione editoriale contingente le persone che i libri li scrivono.
Tolto l'usuale constatazione di come la fantascienza come genere nel suo complesso. e ancor di più nella sua incarnazione nostrana, faccia dannatamente fatica ad arrivare in libreria, la cosa che mi ha colpito dei vari interventi (sono dodici gli scrittori coinvolti) è stato vedere emergere una prospettiva in qualche modo contraddittoria sullo stato della fantascienza italiana: da una lato pare che questo tipo di narrativa non abbia mai avuto un accesso così diffuso alla pubblicazione come invece sta succedendo nell'ultimo paio d'anni, dall'altro si ribadisce come il pubblico dei lettori di fantascienza sia in costante riduzione.
Un altro aspetto dello speciale che mi ha colpito è la dose di melassa sparsa abbondantemente tra le righe dei vari interventi. Va bene la diplomazia, va bene la prudenza, ma quest'approccio alla situazione così morbido, da grande famiglia felice, mi ha provocato un certo fastidio, quasi che parlare di fantascienza, qui e ora, significhi soprattutto fare attenzione a non pestare il piede sbagliato. E qui non mi riferisco tanto agli interventi degli autori, quanto a quelli di contorno che cercando di tracciare un quadro generale sullo stato dell'arte fantascientifica nostrana.
Intendiamoci, io condivido pressoché in toto l'atteggiamento di chi auspica un maggior spirito cooperativo all'interno del genere, di chi chiede di abbattere i muri dei rispettivi orticelli e si appella all'onestà intellettuale di chiunque voglia intervenire per offrire il suo contributo allo sviluppo della scena. Però m'è parso di avvertire come nota di fondo un certo atteggiamento, che dal mio personalissimo punto di vista faccio davvero fatica ad accettare: "tutto va bene, tutto funziona, lasciateli lavorare che le cose andranno sempre meglio, e chi osa dire il contrario rema contro e va bandito".
Certo, io qui sopra esagero di proposito il tono degli interventi di Carmine Treanni, Salvatore Proietti e Giampaolo Rai. Però mi pare innegabile che ci sia un tentativo di assopire o comunque smussare i toni più accesi del dibattito (lasciatemelo chiamare così, anche se…) sullo stato della fantascienza italiana che da sempre appassiona grandi e piccini in giro per la rete.
Di nuovo, l'approccio di cui sopra è comprensibile. Spesso parlando di fantascienza italiana il rumore della polemica è diventato insostenibile e il discorso critico sui testi del tutto accessorio all'esaltazione parossistica dell'ego dei vari recensori, lettori, critici e semplici passanti che vagano come anime in pena per l'inferno della rete in cerca d'attenzione.
Non mi va di ripetere per l'ennesima volta la mia opinione, se vi interessa la potete trovare in calce a questo intervento di X. Qui mi interessa ribadire che a mio parere l'unica risposta al rumore non è tapparsi le orecchie quanto piuttosto fare buona musica, che l'unica risposta al pressapochismo è l'ìnformazione dettagliata, che le chiacchiere superficiali si possono sconfiggere solo con l'approfondimento. Se poi la maggior parte del pubblico preferisce divertirsi tra flame e scambi d'invettive, beh… è un problema che non sono comunque in grado di risolvere. Mi basta tirarmene fuori e sperare che la mia voce non si confonda col rumore di fondo.
Un approccio simile me lo aspetterei anche da chi di fantascienza si occupa seriamente.
Per questo motivo non capisco la necessità di raccontarsi la bella favoletta sullo stato della fantascienza italiana che traspare negli interventi pubblicati su Delos.
Se vogliamo parlare di fantascienza in italia non possiamo davvero fingere che vada davvero tutto così bene.
Per contribuire al dibattito, spero in maniera costruttiva, ecco quelli che secondo me sono un paio dei nodi che lo speciale delosiano evita di affrontare.
- La qualità della fantascienza in Italia.
A me pare che si festeggi il successo della pubblicazione in quanto tale, a prescindere da ogni considerazione, se non come nota a margine, sulla qualità di quanto pubblicato. Io non ho letto tutti i romanzi citati nello speciale, e sarò stato particolarmente sfortunato (o più probabilmente sono troppo esigente), ma la qualità media di quanto letto negli ultimi anni è ben lungi da un livello tale da attirare nuovi lettori al genere.
- Non si è mai pubblicata tanta fantascienza italiana come nell'ultimo periodo.
Siamo sicuri sia un bene? Avete per caso visto moltiplicarsi le pubblicazioni di genere in libreria? A me non sembra. Quindi, se la matematica non è un'opinione, la presenza di un maggior numero di pubblicazioni di autori italiani è andata a discapito della produzione straniera. Da lettore a lettore: siamo sicuri che preferiamo leggere Francesco Verso piuttosto che Iain Banks? o Vittorio Catani invece di Ian McDonald?
Lo so. È un discorso antipatico, e sarei la persona più felice del mondo se in libreria ci fosse spazio per entrambe le proposte. Al momento però mi pare che le cose vadano in questo modo. Dal punto di vista degli autori di genere italiani il momento offre grandi opportunità di vedere i propri sforzi premiati, ma dal mio punto di vista di lettore tocca considerare anche cosa mi sto perdendo.
E poi ci si potrebbe porre anche qualche domandina altrettanto antipatica sui motivi di queste scelte editoriali (nel recente passato la scelta analoga di un editore specializzato di privilegiare autori italiani rispetto ai tradizionali autori anglosassoni è stato il primo segnale della crisi che ha anticipato quella che s'è rivelata poi una situazione irreversibile).
- Ehi! Ma gli altri dove sono?
Non si dovrebbe parlare degli assenti, però ho notato con un certo dispiacere che tra tutti gli interventi di scrittori presentati nello speciale mancano proprio quelli che nell'ultimo periodo ho apprezzato di più. Dove sono Clelia Farris o il gruppo che fa capo ad Alia? Ragazzi, a me piacerebbe davvero conoscere la vostra opinione!
Altre voci che mi sarebbe piaciuto ascoltare sono quelle di un Tullio Avoledo o degli altri autori chiamati da minimum fax a scrivere fantascienza per il progetto Anteprima nazionale, che avrebbero potuto offrire un punto di vista esterno sulla stato della letteratura di genere. Ma ok, non si può avere tutto.
(Sia chiaro che questo NON è una critica a chi ha preparato questo numero monografico di Delos. Qualche anno fa ho curato anch'io un speciale analogo e so quanto è difficile avere risposte rapide da parecchie decine di persone, anche solo a quel paio di domande poste da Delos)
- Il sogno.
Dice bene Salvatore MLK Proietti. Il suo sogno è bellissimo, meraviglioso, decisamente allettante. Ma è un sogno. La realtà, che piaccia o meno, è molto diversa. Io non ho sogni di così squisita fattura e non credo che fare appelli generici serva a qualcosa. Mi limito a osservare che la pluralità di voci, a volte discordanti, spesso stonate, potrebbe ridursi, se non l'ha già fatto, da ricchezza quale dovrebbe essere a mero rumore di fondo.
Credo che solo l'esempio e la qualità delle proposte possa fare la differenza.
Insomma, se amate la fantascienza, datevi una mossa.
E fanculo a chi ci vuole male.
(potrebbe essere utile leggere parallelamente a questo post anche l'intervento di Elvezio Sciallis su Malpertuis. In quel post non si parla di Delos, e nemmeno di fantascienza, si parla di critica, di letteratura e cinema di genere, di internet e dell'aria che tira. Io trovo il suo approccio molto interessante, nonostante il peso della personalità del suo autore rischi a volte di soffocare il valore dei suoi argomenti.)
…
08 aprile 2010
Letture marzo 2010
Jon Courtenay Grimwood - Effendi
Secondo volume della trilogia arabesca, Effendi conferma tutte le qualità di Jon Courtenay Grimwood. Se Pashazade era incentrato sulla misteriosa figura di Ashraf Bey (ne parlavo qui), in questo romanzo la vicenda esplora l'oscuro passato dell'uomo più ricco di El Iskandryia, nonché genitore dell'ex promessa sposa di Raf.
La cosa più notevole di Effendi è la capacità di Grimwood di immergere il lettore nel mezzo dell'azione per mezzo di capitoli apparentemente slegati tra loro (con punti di vista sempre diversi, collocazioni temporali non lineari, un sacco di roba che avviene dietro le quinte), creando un mosaico di episodi che, lungi dal disperdere la vicenda, la concentrano nei suoi punti nodali, conferendo al contempo un ritmo esaltante agli avvenimenti. La miscela di storia alternativa e riflessioni etico/politiche (i conflitti africani hanno un grosso peso nella vicenda) insieme all'approccio alle storie personali dei protagonisti crea un'atmosfera drammatica unica e nonostante qualche situazione appaia realisticamente eccessiva il romanzo non sfugge mai al controllo del suo autore.
Dopo Pashazade e nell'attesa di leggere l'ultimo capitolo della trilogia, questo Effendi s'è rivelato un altro ottimo romanzo. Consigliato a tutti coloro che leggono in lingua inglese.
Clelia Farris - Nessun uomo è mio fratello
Dopo aver parlato del romanzo di Clelia Farris in questo post è nata un'accesa discussione sulle qualità del romanzo. Io rimango dell'opinione che Nessun uomo è mio fratello sia qualcosa di mai visto prima nell'ambito della fantascienza italiana. Non mi rimane dunque che rinnovarvi l'invito a procurarvelo, che tra le proposte della letteratura di genere nostrana è difficile trovare un altro romanzo con una simile qualità di scrittura.
Viktor Pelevin - L' elmo del terrore
Che senso ha 'sto libercolo?
L'unica momento degna di nota di questo romanzo filosofico (?), che immagino sia stato scritto per motivi alimentari - che altrimenti c'è da porsi qualche domanda sull'ego dell'autore - è la descrizione dell'intero sistema di elaborazione cultural-psicologico umano nella struttura dell'elmo del terrore che da titolo al volume. Altro non c'ho trovato, se non la fastidiosa sicumera del continuo parlarsi addosso dei vari personaggi che frequentano le sue pagine.
Precipitare in questo vortice che mescola agilmente - o furbescamente, dipende dai punti di vista - internet e minotauri, oltre a mito e storia e metafisica, offre probabilmente qualche spunto di interesse dal punto di vista narrativo, ma io l'ho trovato oltremodo irritante, sia per la presunzione dell'autore, via via sempre più evidente, di voler racchiudere in queste poche pagine il cosiddetto senso della vita, sia per lo scorcio cinico e disincantato (ma così figo…) che offre dell'umanità. Quasi che volersene distinguere, costi quel che costi, sia la priorità non detta di Viktor Pelevin. Un pochino di umiltà in più non avrebbe guastato.
Leonard Susskind - La guerra dei buchi neri
Trovo in qualche modo confortante che ci siano persone sparse ai quattro angoli del pianeta che passano il loro tempo a ricercare, sperimentare, calcolare e speculare sulla struttura intima dell'universo, passando senza timori reverenziali dalle particelle elementari che costituiscono le basi invisibili della realtà (di tutta la realtà!) ai buchi neri, più o meno teorici, ma sempre decisamente affascinanti, alle più incredibili teorie cosmologiche.
Sono riuscito a seguire il professor Susskind fino a circa metà volume. La meccanica quantistica non mi terrorizza più come faceva un tempo e nemmeno il confronto tra la fisica classica e quella relativistica mi lascia più spaesato, per non parlare del fascino che strutture come gli orizzonti degli eventi hanno sempre esercitato sul sottoscritto. Quando però La guerra dei buchi neri passa a trattare di spazi multidimensionali, di teoria delle stringhe o del famigerato paradigma olografico, beh… il mio povero cervelletto ha tirato il freno a mano per proseguire poi col pilota automatico.
Leonard Susskind ha un bel parlare di riconfigurare le proprie strutture mentali, e si sforza il più possibile di rendere digeribili al suo pubblico concetti davvero formidabili. Io però non ce l'ho fatta. Mi sono limitato a fidarmi e a stupirmi della vastità e della complessità raggiunta dalla fisica odierna.
Poi mi sono guardato qualche puntata di Big Bang Theory e grazie a Sheldon mi son riconciliato con l'universo e tutto quanto di complicato qua fuori.
Cordwainer Smith - Norstrilia
Per parafrasare un commento letto su Anobii, non ho capito perché Norstrilia mi è piaciuto. La cosa non ha senso.
Il fatto è che nonostante la visione del mondo che accompagna il lettore nel suo viaggio in compagnia di Rod McBan da Norstrilia alla Terra e ritorno sia molto lontana dalla mia, le avventure del protagonista alla ricerca di un significato da dare alla propria esistenza non sono affatto male. Sarà lo stile particolare di Cordwainer Smith che tratta il futuro come fosse intessuto di leggenda, la sua vervé immaginifica (diamine, pecore malate gigantesche alla base dell'economia dell'intero universo! …e poi G'mell e tutte le altre simpatiche bestiole, sagge, enigmatiche, pratiche o in crisi mistica che indicano la strada al buon Rod, per non parlare di donne di servizio transgender e compagnia bella…), o forse è l'impressione di trovarsi di fronte a un romanzo nato agli inizi degli anni sessanta ma già con la testa nei decenni successivi. Fatto sta che Norstrilia mi è piaciuto, nonostante il sapore d'antiquariato e la sensibilità sottilmente reazionaria nel trattare col genere umano.
…
Secondo volume della trilogia arabesca, Effendi conferma tutte le qualità di Jon Courtenay Grimwood. Se Pashazade era incentrato sulla misteriosa figura di Ashraf Bey (ne parlavo qui), in questo romanzo la vicenda esplora l'oscuro passato dell'uomo più ricco di El Iskandryia, nonché genitore dell'ex promessa sposa di Raf.
La cosa più notevole di Effendi è la capacità di Grimwood di immergere il lettore nel mezzo dell'azione per mezzo di capitoli apparentemente slegati tra loro (con punti di vista sempre diversi, collocazioni temporali non lineari, un sacco di roba che avviene dietro le quinte), creando un mosaico di episodi che, lungi dal disperdere la vicenda, la concentrano nei suoi punti nodali, conferendo al contempo un ritmo esaltante agli avvenimenti. La miscela di storia alternativa e riflessioni etico/politiche (i conflitti africani hanno un grosso peso nella vicenda) insieme all'approccio alle storie personali dei protagonisti crea un'atmosfera drammatica unica e nonostante qualche situazione appaia realisticamente eccessiva il romanzo non sfugge mai al controllo del suo autore.
Dopo Pashazade e nell'attesa di leggere l'ultimo capitolo della trilogia, questo Effendi s'è rivelato un altro ottimo romanzo. Consigliato a tutti coloro che leggono in lingua inglese.
Clelia Farris - Nessun uomo è mio fratello
Dopo aver parlato del romanzo di Clelia Farris in questo post è nata un'accesa discussione sulle qualità del romanzo. Io rimango dell'opinione che Nessun uomo è mio fratello sia qualcosa di mai visto prima nell'ambito della fantascienza italiana. Non mi rimane dunque che rinnovarvi l'invito a procurarvelo, che tra le proposte della letteratura di genere nostrana è difficile trovare un altro romanzo con una simile qualità di scrittura.
Viktor Pelevin - L' elmo del terrore
Che senso ha 'sto libercolo?
L'unica momento degna di nota di questo romanzo filosofico (?), che immagino sia stato scritto per motivi alimentari - che altrimenti c'è da porsi qualche domanda sull'ego dell'autore - è la descrizione dell'intero sistema di elaborazione cultural-psicologico umano nella struttura dell'elmo del terrore che da titolo al volume. Altro non c'ho trovato, se non la fastidiosa sicumera del continuo parlarsi addosso dei vari personaggi che frequentano le sue pagine.
Precipitare in questo vortice che mescola agilmente - o furbescamente, dipende dai punti di vista - internet e minotauri, oltre a mito e storia e metafisica, offre probabilmente qualche spunto di interesse dal punto di vista narrativo, ma io l'ho trovato oltremodo irritante, sia per la presunzione dell'autore, via via sempre più evidente, di voler racchiudere in queste poche pagine il cosiddetto senso della vita, sia per lo scorcio cinico e disincantato (ma così figo…) che offre dell'umanità. Quasi che volersene distinguere, costi quel che costi, sia la priorità non detta di Viktor Pelevin. Un pochino di umiltà in più non avrebbe guastato.
Leonard Susskind - La guerra dei buchi neri
Trovo in qualche modo confortante che ci siano persone sparse ai quattro angoli del pianeta che passano il loro tempo a ricercare, sperimentare, calcolare e speculare sulla struttura intima dell'universo, passando senza timori reverenziali dalle particelle elementari che costituiscono le basi invisibili della realtà (di tutta la realtà!) ai buchi neri, più o meno teorici, ma sempre decisamente affascinanti, alle più incredibili teorie cosmologiche.
Sono riuscito a seguire il professor Susskind fino a circa metà volume. La meccanica quantistica non mi terrorizza più come faceva un tempo e nemmeno il confronto tra la fisica classica e quella relativistica mi lascia più spaesato, per non parlare del fascino che strutture come gli orizzonti degli eventi hanno sempre esercitato sul sottoscritto. Quando però La guerra dei buchi neri passa a trattare di spazi multidimensionali, di teoria delle stringhe o del famigerato paradigma olografico, beh… il mio povero cervelletto ha tirato il freno a mano per proseguire poi col pilota automatico.
Leonard Susskind ha un bel parlare di riconfigurare le proprie strutture mentali, e si sforza il più possibile di rendere digeribili al suo pubblico concetti davvero formidabili. Io però non ce l'ho fatta. Mi sono limitato a fidarmi e a stupirmi della vastità e della complessità raggiunta dalla fisica odierna.
Poi mi sono guardato qualche puntata di Big Bang Theory e grazie a Sheldon mi son riconciliato con l'universo e tutto quanto di complicato qua fuori.
Cordwainer Smith - Norstrilia
Per parafrasare un commento letto su Anobii, non ho capito perché Norstrilia mi è piaciuto. La cosa non ha senso.
Il fatto è che nonostante la visione del mondo che accompagna il lettore nel suo viaggio in compagnia di Rod McBan da Norstrilia alla Terra e ritorno sia molto lontana dalla mia, le avventure del protagonista alla ricerca di un significato da dare alla propria esistenza non sono affatto male. Sarà lo stile particolare di Cordwainer Smith che tratta il futuro come fosse intessuto di leggenda, la sua vervé immaginifica (diamine, pecore malate gigantesche alla base dell'economia dell'intero universo! …e poi G'mell e tutte le altre simpatiche bestiole, sagge, enigmatiche, pratiche o in crisi mistica che indicano la strada al buon Rod, per non parlare di donne di servizio transgender e compagnia bella…), o forse è l'impressione di trovarsi di fronte a un romanzo nato agli inizi degli anni sessanta ma già con la testa nei decenni successivi. Fatto sta che Norstrilia mi è piaciuto, nonostante il sapore d'antiquariato e la sensibilità sottilmente reazionaria nel trattare col genere umano.
…
31 marzo 2010
Sotto il segno della pecora
Quando si dice la sincronia. Venerdì nominavo Haruki Murakami parlando del romanzo di Clelia Farris. Sabato ho trovato a metà prezzo Kafka sulla spiaggia e oggi scopro che da un paio di settimane è di nuovo disponibile in libreria Sotto il segno della pecora.
Nel corso degli anni Sotto il segno della pecora è diventato una sorta di sacro graal per gli amanti nostrani dell'autore giapponese. Uscito nel 1992 per Longanesi, prima che Murakami fosse un nome conosciuto al grande pubblico, non era più stato ristampato da allora. Io lo stavo inutilmente cercando da tempo, praticamente da quando, letto Dance Dance Dance, ho scoperto il legame che univa i due romanzi.
Ora Einaudi l'ha riportato in libreria in una nuova traduzione di Antonietta Pastore con il titolo Nel segno della pecora.
Non fatelo sparire un'altra volta, per favore.
…
Nel corso degli anni Sotto il segno della pecora è diventato una sorta di sacro graal per gli amanti nostrani dell'autore giapponese. Uscito nel 1992 per Longanesi, prima che Murakami fosse un nome conosciuto al grande pubblico, non era più stato ristampato da allora. Io lo stavo inutilmente cercando da tempo, praticamente da quando, letto Dance Dance Dance, ho scoperto il legame che univa i due romanzi.
Ora Einaudi l'ha riportato in libreria in una nuova traduzione di Antonietta Pastore con il titolo Nel segno della pecora.
Non fatelo sparire un'altra volta, per favore.
…
26 marzo 2010
Nessun uomo è mio fratello
Vi avverto, questo post corre il rischio di trasformarsi strada facendo in uno spot, e se succederà lo farà del tutto consapevolmente. Perché non capita tutti i giorni (non mi era MAI capitato) di leggere un romanzo italiano di fantascienza come Nessun uomo è mio fratello di Clelia Farris.
Nessun uomo è mio fratello è una perla preziosa, un piccolo gioiello ancor più straordinario se pensiamo che questo è un romanzo di fantascienza, anzi, un romanzo di fantascienza italiana. Le qualità del romanzo di Clelia Farris lo rendono tanto inconsueto, originale e prezioso che diventa doveroso provare a parlarne per diffonderne la conoscenza il più possibile, con buona pace di chi pretende che in questo blog si lavori sempre e solo contro la produzione nostrana.
Nessun uomo è mio fratello è inconsueto per la naturalezza e la profondità della caratterizzazione dei vari personaggi che calcano le scene del romanzo. Con pochi accenni e una sensibilità rara Clelia Farris rende immediatamente vivi, riconoscibili e tridimensionali anche le comparse più invisibili. Quante volte ci siamo imbattuti in personaggi che sembrano vivere solo in funzione del plot imbastito dall'autore? In questo romanzo è piuttosto il contrario. I vari tipi umani che animano la storia sembrano tutti avere una vita loro da qualche parte, fuori dalla pagina, tanto è naturale il loro ingresso in scena, le loro relazioni - tra loro e con il protagonista - e il modo personale di muoversi negli spazi del romanzo. Se questo è valido per i comprimari ancora più mirabile è la costruzione del carattere del protagonista: Enki, figlio senza madre di un contadino dispotico, che dopo un'infanzia vissuta con qualche problema tra le risaie del villaggio natale approda a una vita randagia e segreta tra i palazzi e i viali della grande città.
Le contraddizioni che caratterizzano il suo percorso di crescita sono rese in maniera tanto credibile da risultare del tutto inevitabili, e rendono la personalità di Enki decisamente complessa, tanto che se l'identificazione con la sua vicenda è immediata, i dubbi e i turbamenti che lo perseguitano diventano per il lettore interrogativi sempre più stimolanti man mano che ci si inoltra nel mondo del romanzo.
L'ambiente in cui si muove il protagonista è l'aspetto forse più originale di Nessun uomo è mio fratello.
Mi è piaciuto il modo in cui Clelia Farris ha mantenuto le connotazioni generali dello scenario molto sfumate (non sappiamo dove o quando siamo, non sappiamo nemmeno se ci troviamo nel nostro universo, anche se personalmente propendo per un paese tipo Vietnam un qualche centinaio di anni nel futuro), e al contempo l'estrema precisione e il dettaglio con cui descrive le condizioni del mondo che circonda da vicino i suoi abitanti. Il vedersi piombare in una realtà aliena (come contesto) ma estremamente familiare (nei particolari) rende il lettore immediatamente partecipe e attento alla vita e agli avvenimenti che animano le giornate dei vari protagonisti del racconto. Il world-building è progressivo e prosegue fino al termine della lettura con un equilibrio davvero raro per un'autrice che in fondo è solo al secondo romanzo. Il lettore accompagna Enki nel suo percorso di apprendimento e scopre con lui la realtà che lo circonda. Gli scarti temporali che caratterizzano la vicenda, se da un alto sorprendono il lettore scagliandolo improvvisamente in una terra incognita, dall'altro lo obbligano ad avvicinarsi sempre più al punto di vista del protagonista, unica certezza - si fa per dire - in un mondo in rapido mutamento.
Nel confronto tra Enki e il suo mondo entra in gioco l'aspetto fantascientifico del romanzo, ed è nella gestione del carattere diverso di questa realtà che Clelia Farris dimostra l'efficacia della sua scrittura. Proprio nel suo essere senza ombra di dubbio un romanzo di solidissima - e personalissima - fantascienza Nessun uomo è mio fratello è forse il libro più prezioso che possiate trovare oggi in libreria. In questo romanzo non ci sono spiegoni, il volume dell'infodump è ridotto ai minimi termini tanto da risultare all'effetto pratico del tutto irrilevante, eppure ogni pagina del romanzo trasuda fantascienza, ogni avvenimento è permeato dalla diversa realtà che sottende ogni azione di tutti i personaggi del romanzo, i turbamenti e l'evoluzione del carattere del protagonista sono scanditi dal suo perenne confrontarsi con l'essenza di questo mondo altro.
Il nucleo pulsante di Nessun uomo è mio fratello è costituito dalla dicotomia Vittime/Carnefici che abbraccia ogni aspetto del mondo di Enki. A leggerlo nella presentazione del romanzo mi sembrava quanto di più trito e banale e scontato si potesse incontrare oggi, XXI secolo, in un romanzo di fantascienza. Il classico esempio di un tema già sviscerato fino alla noia dai grandi autori del passato riciclato dal volenteroso autore italiano di turno in mancanza di un'ispirazione più originale.
E invece…
E invece Clelia Farris è abilissima nel mantenere l'humus fantascientifico della vicenda costantemente fuori fuoco, lasciandolo maturare tra il non spiegato e quei singoli episodi, apparentemente accessori, che lo portano improvvisamente alla ribalta. Quello che rimane è il confronto tra un giovane uomo e una realtà che gli risulta incomprensibile prima, intollerabile poi. L'intero universo narrativo del romanzo è costantemente costretto a fare i conti con la realtà aliena del marchio che distingue coloro che nascono Vittime da coloro che nascono Carnefici. Tutta la società è strutturata secondo codici non scritti che vedono le vittime come remissivi agnelli in attesa di un lupo che ne gestisca energie e capacità. La storia di Enki è quella di una ribellione ad uno status quo inalterabile, codificato nel genoma stesso della popolazione.
Le scelte di Enki, le sue azioni e loro conseguenze dettano i tempi narrativi del romanzo. Ma molto più efficace m'è sembrata l'atmosfera che l'autrice ha saputo ricreare. Un'atmosfera che a me pare debba qualcosa a Miyazaki e a Murakami, rispettivamente per il ritratto leggermente surreale di ambienti e persone al primo, per l'esasperato individualismo asociale del protagonista al secondo, oltre che a un indubbia conoscenza di luoghi e dinamiche sociali che si incontrano trasfigurati nel romanzo ma che sono spazi e relazioni reali, qui e ora.
Leggendo Nessun uomo è mio fratello non ho colto alcun difetto sostanziale, forse qualche situazione rimane un po' troppo didascalica (penso soprattutto al rapporto univoco vittima/carnefice - che forse andava maggiormente approfondito - o ai problemi connessi alla fabbrica di tessuti) ma in generale la scrittura di Clelia Farris m'è parsa sempre perfettamente calibrata, matura e capace di gestire le situazioni più difficili.
Nessun uomo è mio fratello è davvero un ottimo romanzo, ma soprattutto è una graditissima e inaspettata sorpresa. Se seguite questo blog sapete come la penso sulla fantascienza italiana. È quindi davvero un piacere imbattersi in opere capaci da sole di ribaltare la mia opinione su quel che è in grado di offrire il genere a noi lettori qua fuori.
Insomma, cercate questo volume, leggetelo e parlatene. E non fatevi ingannare dall'immagine di copertina.
Dentro il libro è molto, molto, meglio.
…
Nessun uomo è mio fratello è una perla preziosa, un piccolo gioiello ancor più straordinario se pensiamo che questo è un romanzo di fantascienza, anzi, un romanzo di fantascienza italiana. Le qualità del romanzo di Clelia Farris lo rendono tanto inconsueto, originale e prezioso che diventa doveroso provare a parlarne per diffonderne la conoscenza il più possibile, con buona pace di chi pretende che in questo blog si lavori sempre e solo contro la produzione nostrana.
Nessun uomo è mio fratello è inconsueto per la naturalezza e la profondità della caratterizzazione dei vari personaggi che calcano le scene del romanzo. Con pochi accenni e una sensibilità rara Clelia Farris rende immediatamente vivi, riconoscibili e tridimensionali anche le comparse più invisibili. Quante volte ci siamo imbattuti in personaggi che sembrano vivere solo in funzione del plot imbastito dall'autore? In questo romanzo è piuttosto il contrario. I vari tipi umani che animano la storia sembrano tutti avere una vita loro da qualche parte, fuori dalla pagina, tanto è naturale il loro ingresso in scena, le loro relazioni - tra loro e con il protagonista - e il modo personale di muoversi negli spazi del romanzo. Se questo è valido per i comprimari ancora più mirabile è la costruzione del carattere del protagonista: Enki, figlio senza madre di un contadino dispotico, che dopo un'infanzia vissuta con qualche problema tra le risaie del villaggio natale approda a una vita randagia e segreta tra i palazzi e i viali della grande città.
Le contraddizioni che caratterizzano il suo percorso di crescita sono rese in maniera tanto credibile da risultare del tutto inevitabili, e rendono la personalità di Enki decisamente complessa, tanto che se l'identificazione con la sua vicenda è immediata, i dubbi e i turbamenti che lo perseguitano diventano per il lettore interrogativi sempre più stimolanti man mano che ci si inoltra nel mondo del romanzo.
L'ambiente in cui si muove il protagonista è l'aspetto forse più originale di Nessun uomo è mio fratello.
Mi è piaciuto il modo in cui Clelia Farris ha mantenuto le connotazioni generali dello scenario molto sfumate (non sappiamo dove o quando siamo, non sappiamo nemmeno se ci troviamo nel nostro universo, anche se personalmente propendo per un paese tipo Vietnam un qualche centinaio di anni nel futuro), e al contempo l'estrema precisione e il dettaglio con cui descrive le condizioni del mondo che circonda da vicino i suoi abitanti. Il vedersi piombare in una realtà aliena (come contesto) ma estremamente familiare (nei particolari) rende il lettore immediatamente partecipe e attento alla vita e agli avvenimenti che animano le giornate dei vari protagonisti del racconto. Il world-building è progressivo e prosegue fino al termine della lettura con un equilibrio davvero raro per un'autrice che in fondo è solo al secondo romanzo. Il lettore accompagna Enki nel suo percorso di apprendimento e scopre con lui la realtà che lo circonda. Gli scarti temporali che caratterizzano la vicenda, se da un alto sorprendono il lettore scagliandolo improvvisamente in una terra incognita, dall'altro lo obbligano ad avvicinarsi sempre più al punto di vista del protagonista, unica certezza - si fa per dire - in un mondo in rapido mutamento.
Nel confronto tra Enki e il suo mondo entra in gioco l'aspetto fantascientifico del romanzo, ed è nella gestione del carattere diverso di questa realtà che Clelia Farris dimostra l'efficacia della sua scrittura. Proprio nel suo essere senza ombra di dubbio un romanzo di solidissima - e personalissima - fantascienza Nessun uomo è mio fratello è forse il libro più prezioso che possiate trovare oggi in libreria. In questo romanzo non ci sono spiegoni, il volume dell'infodump è ridotto ai minimi termini tanto da risultare all'effetto pratico del tutto irrilevante, eppure ogni pagina del romanzo trasuda fantascienza, ogni avvenimento è permeato dalla diversa realtà che sottende ogni azione di tutti i personaggi del romanzo, i turbamenti e l'evoluzione del carattere del protagonista sono scanditi dal suo perenne confrontarsi con l'essenza di questo mondo altro.
Il nucleo pulsante di Nessun uomo è mio fratello è costituito dalla dicotomia Vittime/Carnefici che abbraccia ogni aspetto del mondo di Enki. A leggerlo nella presentazione del romanzo mi sembrava quanto di più trito e banale e scontato si potesse incontrare oggi, XXI secolo, in un romanzo di fantascienza. Il classico esempio di un tema già sviscerato fino alla noia dai grandi autori del passato riciclato dal volenteroso autore italiano di turno in mancanza di un'ispirazione più originale.
E invece…
E invece Clelia Farris è abilissima nel mantenere l'humus fantascientifico della vicenda costantemente fuori fuoco, lasciandolo maturare tra il non spiegato e quei singoli episodi, apparentemente accessori, che lo portano improvvisamente alla ribalta. Quello che rimane è il confronto tra un giovane uomo e una realtà che gli risulta incomprensibile prima, intollerabile poi. L'intero universo narrativo del romanzo è costantemente costretto a fare i conti con la realtà aliena del marchio che distingue coloro che nascono Vittime da coloro che nascono Carnefici. Tutta la società è strutturata secondo codici non scritti che vedono le vittime come remissivi agnelli in attesa di un lupo che ne gestisca energie e capacità. La storia di Enki è quella di una ribellione ad uno status quo inalterabile, codificato nel genoma stesso della popolazione.
Le scelte di Enki, le sue azioni e loro conseguenze dettano i tempi narrativi del romanzo. Ma molto più efficace m'è sembrata l'atmosfera che l'autrice ha saputo ricreare. Un'atmosfera che a me pare debba qualcosa a Miyazaki e a Murakami, rispettivamente per il ritratto leggermente surreale di ambienti e persone al primo, per l'esasperato individualismo asociale del protagonista al secondo, oltre che a un indubbia conoscenza di luoghi e dinamiche sociali che si incontrano trasfigurati nel romanzo ma che sono spazi e relazioni reali, qui e ora.
Leggendo Nessun uomo è mio fratello non ho colto alcun difetto sostanziale, forse qualche situazione rimane un po' troppo didascalica (penso soprattutto al rapporto univoco vittima/carnefice - che forse andava maggiormente approfondito - o ai problemi connessi alla fabbrica di tessuti) ma in generale la scrittura di Clelia Farris m'è parsa sempre perfettamente calibrata, matura e capace di gestire le situazioni più difficili.
Nessun uomo è mio fratello è davvero un ottimo romanzo, ma soprattutto è una graditissima e inaspettata sorpresa. Se seguite questo blog sapete come la penso sulla fantascienza italiana. È quindi davvero un piacere imbattersi in opere capaci da sole di ribaltare la mia opinione su quel che è in grado di offrire il genere a noi lettori qua fuori.
Insomma, cercate questo volume, leggetelo e parlatene. E non fatevi ingannare dall'immagine di copertina.
Dentro il libro è molto, molto, meglio.
…
16 marzo 2010
Letture febbraio 2010
AA.VV. - Alia. L'arcipelago del fantastico.
Di questo numero di Alia ho parlato abbondantemente in questo post. Qui non mi resta che rinnovare l'invito a procurarvelo. Se siete appassionati di letteratura fantastica e curiosi di conoscere ciò che sono in grado di proporre gli autori italiani entro i suoi ampi spazi, beh… questo Alia è un'ottima introduzione al genere.
Thomas Pynchon - Contro il giorno
Anche il romanzone di Thomas Pynchon s'è meritato un post apposito qualche giorno fa. Ma Contro il giorno è un romanzo capace come pochi di restituire al mondo la complessità delle sue storie ed è talmente ricco di suggestioni e denso di contenuti che nessun post può rendergli giustizia. Sono davvero contento di averlo incontrato.
Philip Pullman - Lo spaventapasseri e il suo servitore
Mio figlio Jacopo ha 9 anni ed è rimasto tanto soddisfatto da questa storia da volere assolutamente che la leggessi anch'io. Lo spaventapasseri e il suo servitore ha la struttura della più classica delle favole e racconta le peripezie dei due personaggi del titolo (una sorta di Don Chisciotte e Sancio Panza a misura di bambino). Ma questo piccolo romanzo di Philip Pullman è anche una favola in cui la parola magia non viene mai utilizzata (in compenso si citano atomi ed elettricità), una storia in cui i cattivi non sono orchi o stregoni ma finanzieri e avvocati. Ne Lo spaventapasseri e il suo servitore non si lesinano trovate brillanti e inserti meravigliosi, ma questi elementi fantastici non impediscono di scorgere le piccole meschinerie che caratterizzano molti degli incontri lungo la strada e soprattutto la cattiveria di tutte le strutture di potere che i due protagonisti incontrano sul loro cammino.
Probabilmente un bimbo di nove anni non è in grado di cogliere tutti questi dettagli, ma se lo spirito di questo tipo di narrazione è sufficientemente forte da rimanergli comunque impresso per me è già una bella soddisfazione.
Elmore Leonard - Tutti i racconti western
Il West come ultima possibilità per l'immaginazione. Il West come simbolo e paradigma di un'umanità scomparsa. Il West come alambicco storico per distillare l'anima di un'epoca. Il West come sangue e sudore e polvere, come silenzio e violenza e improvvisi scoppi di dolcezza.
Il West di Elmore Leonard è il West che tutti conosciamo, quello degli Apache e dei cow-boy, delle giacche blu e dei pistoleri, delle case nella prateria ai margini del bosco e dei saloon, degli sceriffi, delle diligenze. Ma le storie western di Elmore Leonard rappresentano qualcosa di più di un semplice ritorno nostalgico allo spirito della frontiera. Scritti per la maggior parte mezzo secolo fa questi racconti riescono nel mirabile compito di ridefinire le coordinate del mito anche per i lettori di questo nuovo millennio. Spogliati da qualsiasi folklore, incredibilmente ricchi di passione, con uno sfondo che da mero palcoscenico diventa parte integrante della storia, fondamentale anzi a definire ruoli e caratteri della varia umanità che lo attraversa, i racconti di Leonard sono tanto essenziali da risultare immensi ed eterni come il cielo e il deserto dell'Arizona e i suoi protagonisti veri giganti che si stagliano scolpiti come montagne alla luce del tramonto.
Onore al merito anche a Luca Conti che mi ha dato l'impressione di aver svolto un ottimo lavoro di traduzione soprattutto nello svecchiare il linguaggio per adeguarlo ai tempi.
Cavalcarono verso Ovest, il resto è storia.
…
Di questo numero di Alia ho parlato abbondantemente in questo post. Qui non mi resta che rinnovare l'invito a procurarvelo. Se siete appassionati di letteratura fantastica e curiosi di conoscere ciò che sono in grado di proporre gli autori italiani entro i suoi ampi spazi, beh… questo Alia è un'ottima introduzione al genere.
Thomas Pynchon - Contro il giorno
Anche il romanzone di Thomas Pynchon s'è meritato un post apposito qualche giorno fa. Ma Contro il giorno è un romanzo capace come pochi di restituire al mondo la complessità delle sue storie ed è talmente ricco di suggestioni e denso di contenuti che nessun post può rendergli giustizia. Sono davvero contento di averlo incontrato.
Philip Pullman - Lo spaventapasseri e il suo servitore
Mio figlio Jacopo ha 9 anni ed è rimasto tanto soddisfatto da questa storia da volere assolutamente che la leggessi anch'io. Lo spaventapasseri e il suo servitore ha la struttura della più classica delle favole e racconta le peripezie dei due personaggi del titolo (una sorta di Don Chisciotte e Sancio Panza a misura di bambino). Ma questo piccolo romanzo di Philip Pullman è anche una favola in cui la parola magia non viene mai utilizzata (in compenso si citano atomi ed elettricità), una storia in cui i cattivi non sono orchi o stregoni ma finanzieri e avvocati. Ne Lo spaventapasseri e il suo servitore non si lesinano trovate brillanti e inserti meravigliosi, ma questi elementi fantastici non impediscono di scorgere le piccole meschinerie che caratterizzano molti degli incontri lungo la strada e soprattutto la cattiveria di tutte le strutture di potere che i due protagonisti incontrano sul loro cammino.
Probabilmente un bimbo di nove anni non è in grado di cogliere tutti questi dettagli, ma se lo spirito di questo tipo di narrazione è sufficientemente forte da rimanergli comunque impresso per me è già una bella soddisfazione.
Elmore Leonard - Tutti i racconti western
Il West come ultima possibilità per l'immaginazione. Il West come simbolo e paradigma di un'umanità scomparsa. Il West come alambicco storico per distillare l'anima di un'epoca. Il West come sangue e sudore e polvere, come silenzio e violenza e improvvisi scoppi di dolcezza.
Il West di Elmore Leonard è il West che tutti conosciamo, quello degli Apache e dei cow-boy, delle giacche blu e dei pistoleri, delle case nella prateria ai margini del bosco e dei saloon, degli sceriffi, delle diligenze. Ma le storie western di Elmore Leonard rappresentano qualcosa di più di un semplice ritorno nostalgico allo spirito della frontiera. Scritti per la maggior parte mezzo secolo fa questi racconti riescono nel mirabile compito di ridefinire le coordinate del mito anche per i lettori di questo nuovo millennio. Spogliati da qualsiasi folklore, incredibilmente ricchi di passione, con uno sfondo che da mero palcoscenico diventa parte integrante della storia, fondamentale anzi a definire ruoli e caratteri della varia umanità che lo attraversa, i racconti di Leonard sono tanto essenziali da risultare immensi ed eterni come il cielo e il deserto dell'Arizona e i suoi protagonisti veri giganti che si stagliano scolpiti come montagne alla luce del tramonto.
Onore al merito anche a Luca Conti che mi ha dato l'impressione di aver svolto un ottimo lavoro di traduzione soprattutto nello svecchiare il linguaggio per adeguarlo ai tempi.
Cavalcarono verso Ovest, il resto è storia.
…
15 marzo 2010
Houston, avevamo un problema.
Non che ora sia magicamente scomparso, ma almeno è rientrato entro coordinate più comprensibili e, speriamo, risolvibili. Comunque sia sono di nuovo qua, dopo una settimana piuttosto pesante. Ma non voglio farla tanto lunga, piuttosto scusarmi con chi è rimasto in attesa di una risposta ai suoi commenti, o a un'email di ritorno: ogni tanto la vita vera ha la precedenza.
Mi dispiace anche di essermi perso un bel po' di altre chiacchiere e frequentazioni on-line, ma per questo si rimedia a breve. Stay tuned.
…
Mi dispiace anche di essermi perso un bel po' di altre chiacchiere e frequentazioni on-line, ma per questo si rimedia a breve. Stay tuned.
…
03 marzo 2010
In medio stat virtus?
Qualche giorno fa su uno Strano Attrattore è comparso un post che univa polemica a recensione e che comprendeva una dichiarazione programmatica che si basava su un preciso assunto:
"Parlo di libri nella norma … Sono questi libri a fornire lo stato di salute di un genere, essendo per la massa molto più facile condizionare la percezione esterna di quanto non lo sia per un singolo titolo … o per un singolo autore … "
Per quanto riguarda la recensione del romanzo di Oppegaard e la discussione sullo stato dei rapporti tra fandom e letteratura di genere vi rimando al post originale di X.
Qui mi interessa approfondire il discorso su quali sono gli aspetti preponderanti di un genere letterario che ne determinano una data percezione presso il pubblico generalista e quello specializzato. Nello specifico si parlerà di fantascienza, ma credo che le ipotesi che salteranno fuori siano valide anche per i generi limitrofi, in particolare fantasy e horror.
Il motivo che mi ha spinto a scrivere queste note è molto semplice. Trovo che la tesi espressa da Giovanni De Matteo sia davvero poco convincente e non individui correttamente i valori che spingono un lettore a riconoscere le caratteristiche salienti di un genere letterario.
Come facciamo a essere certi che per i lettori sia la massa dei prodotti qualsiasi - purché etichettati come fantascienza - a determinare il riconoscimento di tutto un genere? Da dove deriverebbe questa identificazione?
Immagino che l'unico modo che il lettore ha di farsi un'idea di un genere sia frequentarlo, magari sporadicamente o eccezionalmente - penso al lettore generalista o mainstream che dir si voglia - o al contrario in maniera più assidua, addirittura esclusiva e univoca, come accade ai lettori specializzati più spesso di quanto non ritenessi possibile.
Sono convinto che l'idea che questi due lettori tipici si faranno della fantascienza sia poco sovrapponibile, ma comunque in qualche modo coerente con quello che il genere ha da offrire.
Detto questo, a me pare che sia assai più probabile che, qualsiasi tipo di lettore si voglia considerare, la percezione di cosa sia in un dato momento il genere fantascienza non possa in alcun caso derivare dal prodotto letterario medio quanto piuttosto da due modelli fondamentali: il classico sempreverde o il nuovo paradigma. Al primo possiamo ascrivere chessò, Isaac Asimov piuttosto che Philip Dick e romanzi come Fahrenheit 451 o Fanteria dello spazio, al secondo, dai contorni decisamente più sfumati, autori come James Ballard o Iain Banks e romanzi come Neuromante o Distress o qualsiasi altro titolo sia riuscito a dare uno scossone al genere e/o al suo particolare pubblico di quel determinato periodo.
Il lettore generalista si farà un'idea della fantascienza per averne sentito parlare, per averla vista citata, per aver letto i testi più noti e più facilmente reperibili in libreria. Nessuno di noi lettori specializzati consiglierà mai a un amico mainstream un testo che consideri meno che fondamentale. Può anche succedere, e temo capiti con una frequenza non insolita, che il lettore generalista decida di sapere benissimo cos'è la fantascienza basandosi sull'assunto che è quella roba che vendono in edicola oppure trovandosi a leggere proprio l'Urania medio da cui è partita la discussione. Ma temo che in tal caso sia ben poco probabile che questo lettore torni sui suoi passi e dia una seconda possibilità al nostro genere preferito.
Il lettore specializzato, al contrario, sa già benissimo che esistono un sacco di fantascienze diverse e credo sappia altrettanto bene quali sottogeneri apprezza di più e quali preferirebbe evitare. La sua percezione del genere deriva dalla quantità di letture pregresse e da quelli che per lui sono i riferimenti principali. Avendo letto nella sua storia di lettore decine di romanzi e racconti ben lungi dalla perfezione (il cosiddetto prodotto medio) sarà naturalmente più disponibile a scendere a compromessi sulla qualità letteraria del testo, ma al contempo non perderà mai di vista quelle che sono, a suo giudizio, le vette della produzione. Ambirà di conseguenza a trovare quanto più spesso possibile testi analoghi. Come credo capiti a tutti, tenderà a ricordare soprattutto le opere che più lo hanno entusiasmato o, al contrario, quelle che proprio non gli sono andate giù, relegando all'oblio tutti quei volumi che lo hanno magari divertito, ma che costituendo la gran massa delle sue letture non sono stati in grado di colpirlo come solo i grandi racconti o romanzi sono riusciti a fare.
Da questi esempi mi pare evidente che un modello come quello prospettato da Giovanni nel suo blog sia del tutto alieno alla mia esperienza.
C'è però un'ulteriore considerazione da fare.
Se il discorso appena fatto lo trasliamo dal mondo dei lettori a quello degli scrittori le cose acquistano effettivamente un senso diverso. Se ci immaginiamo un autore che voglia misurarsi con il genere fantascienza allora sì che il discorso sulla qualità media del genere ha una sua credibilità. Uno scrittore sa benissimo che, quali che siano le sue aspettative, l'ipotesi di aver realizzato il prossimo capolavoro fantascientifico globale è con tutta probabilità abbastanza remota. Se è dotato di un minimo di umiltà e concretezza riconoscerà i propri limiti e accetterà di confrontarsi con quello che, con un approccio antitetico rispetto a quello del lettore riportato precedentemente, possiamo continuare a definire prodotto medio. Si rapporterà con quella che è l'offerta letteraria del momento, con la segreta speranza di essere premiato dai lettori stessi, con la consapevolezza che "capolavoro" è una definizione che si coniuga a un testo solo dopo che è stato letto, non al momento della stesura, tantomeno a quello della sua pubblicazione.
…
"Parlo di libri nella norma … Sono questi libri a fornire lo stato di salute di un genere, essendo per la massa molto più facile condizionare la percezione esterna di quanto non lo sia per un singolo titolo … o per un singolo autore … "
Per quanto riguarda la recensione del romanzo di Oppegaard e la discussione sullo stato dei rapporti tra fandom e letteratura di genere vi rimando al post originale di X.
Qui mi interessa approfondire il discorso su quali sono gli aspetti preponderanti di un genere letterario che ne determinano una data percezione presso il pubblico generalista e quello specializzato. Nello specifico si parlerà di fantascienza, ma credo che le ipotesi che salteranno fuori siano valide anche per i generi limitrofi, in particolare fantasy e horror.
Il motivo che mi ha spinto a scrivere queste note è molto semplice. Trovo che la tesi espressa da Giovanni De Matteo sia davvero poco convincente e non individui correttamente i valori che spingono un lettore a riconoscere le caratteristiche salienti di un genere letterario.
Come facciamo a essere certi che per i lettori sia la massa dei prodotti qualsiasi - purché etichettati come fantascienza - a determinare il riconoscimento di tutto un genere? Da dove deriverebbe questa identificazione?
Immagino che l'unico modo che il lettore ha di farsi un'idea di un genere sia frequentarlo, magari sporadicamente o eccezionalmente - penso al lettore generalista o mainstream che dir si voglia - o al contrario in maniera più assidua, addirittura esclusiva e univoca, come accade ai lettori specializzati più spesso di quanto non ritenessi possibile.
Sono convinto che l'idea che questi due lettori tipici si faranno della fantascienza sia poco sovrapponibile, ma comunque in qualche modo coerente con quello che il genere ha da offrire.
Detto questo, a me pare che sia assai più probabile che, qualsiasi tipo di lettore si voglia considerare, la percezione di cosa sia in un dato momento il genere fantascienza non possa in alcun caso derivare dal prodotto letterario medio quanto piuttosto da due modelli fondamentali: il classico sempreverde o il nuovo paradigma. Al primo possiamo ascrivere chessò, Isaac Asimov piuttosto che Philip Dick e romanzi come Fahrenheit 451 o Fanteria dello spazio, al secondo, dai contorni decisamente più sfumati, autori come James Ballard o Iain Banks e romanzi come Neuromante o Distress o qualsiasi altro titolo sia riuscito a dare uno scossone al genere e/o al suo particolare pubblico di quel determinato periodo.
Il lettore generalista si farà un'idea della fantascienza per averne sentito parlare, per averla vista citata, per aver letto i testi più noti e più facilmente reperibili in libreria. Nessuno di noi lettori specializzati consiglierà mai a un amico mainstream un testo che consideri meno che fondamentale. Può anche succedere, e temo capiti con una frequenza non insolita, che il lettore generalista decida di sapere benissimo cos'è la fantascienza basandosi sull'assunto che è quella roba che vendono in edicola oppure trovandosi a leggere proprio l'Urania medio da cui è partita la discussione. Ma temo che in tal caso sia ben poco probabile che questo lettore torni sui suoi passi e dia una seconda possibilità al nostro genere preferito.
Il lettore specializzato, al contrario, sa già benissimo che esistono un sacco di fantascienze diverse e credo sappia altrettanto bene quali sottogeneri apprezza di più e quali preferirebbe evitare. La sua percezione del genere deriva dalla quantità di letture pregresse e da quelli che per lui sono i riferimenti principali. Avendo letto nella sua storia di lettore decine di romanzi e racconti ben lungi dalla perfezione (il cosiddetto prodotto medio) sarà naturalmente più disponibile a scendere a compromessi sulla qualità letteraria del testo, ma al contempo non perderà mai di vista quelle che sono, a suo giudizio, le vette della produzione. Ambirà di conseguenza a trovare quanto più spesso possibile testi analoghi. Come credo capiti a tutti, tenderà a ricordare soprattutto le opere che più lo hanno entusiasmato o, al contrario, quelle che proprio non gli sono andate giù, relegando all'oblio tutti quei volumi che lo hanno magari divertito, ma che costituendo la gran massa delle sue letture non sono stati in grado di colpirlo come solo i grandi racconti o romanzi sono riusciti a fare.
Da questi esempi mi pare evidente che un modello come quello prospettato da Giovanni nel suo blog sia del tutto alieno alla mia esperienza.
C'è però un'ulteriore considerazione da fare.
Se il discorso appena fatto lo trasliamo dal mondo dei lettori a quello degli scrittori le cose acquistano effettivamente un senso diverso. Se ci immaginiamo un autore che voglia misurarsi con il genere fantascienza allora sì che il discorso sulla qualità media del genere ha una sua credibilità. Uno scrittore sa benissimo che, quali che siano le sue aspettative, l'ipotesi di aver realizzato il prossimo capolavoro fantascientifico globale è con tutta probabilità abbastanza remota. Se è dotato di un minimo di umiltà e concretezza riconoscerà i propri limiti e accetterà di confrontarsi con quello che, con un approccio antitetico rispetto a quello del lettore riportato precedentemente, possiamo continuare a definire prodotto medio. Si rapporterà con quella che è l'offerta letteraria del momento, con la segreta speranza di essere premiato dai lettori stessi, con la consapevolezza che "capolavoro" è una definizione che si coniuga a un testo solo dopo che è stato letto, non al momento della stesura, tantomeno a quello della sua pubblicazione.
…
25 febbraio 2010
Contro il giorno
"I fought the Law
and the Law Won"
and the Law Won"
Thomas Pynchon è uno scrittore alquanto complicato. Per questo motivo riassumere in un post le innumerevoli suggestioni che la lettura di Contro il giorno mi ha regalato è forse la cosa più difficile io mi sia mai trovato a fare per questo blog.
C'ho messo un po' di tempo, che forse era meglio trascorressi altrimenti. Ma ci tenevo, che nonostante abbia impiegato più di due mesi per terminarne la lettura, 'sto romanzone mi ha davvero appassionato.
La prima cosa da sottolineare è che Contro il giorno è il primo romanzo di Thomas Pynchon tra le cui pagine io mi sia sentito completamente a mio agio. Nonostante la complessità della scrittura, la profondità indescrivibile (non è una figura retorica!) del dettaglio e l'esuberanza della trama, Contro il giorno è un romanzo accogliente che non cerca in alcun modi di mettere in difficoltà il lettore (mi era successo con L'arcobaleno della gravità) e che non è nemmeno troppo pesante e ossessivo come mi era parso Vineland.
Paradossalmente (e se lo dico è perché sempre di Pynchon stiamo parlando, e di un tomo di 1136 pagine) Contro il giorno è un romanzo leggero, che parte come un romanzo d'avventure ottocentesco, si trasforma in una saga western, per poi diventare il romanzo definitivo del XX secolo, con il suo mix incredibile di fantascienza e paranoia, di famiglia e sentimenti, di individui e società segrete e guerre sotterranee.
Ma Contro il giorno è tutto questo e anche di più: è una guida dettagliata alla rivoluzione (sociale, scientifica, personale, chi più ne ha più ne metta…), è un manuale per la liberazione dell'animo oppresso, un sussidiario minimo per tour operator dell'apocalisse. Soprattutto Contro il giorno è un inno all'anarchia, all'etica politica e alla morale anarchica, alla sua testa dura e incosciente, che nonostante le innumerevoli sconfitte costringe a rialzarsi, leccarsi le ferite e di nuovo vivere e lottare e godere.
Al centro del romanzo, a costituirne il nucleo pulsante, troviamo la famiglia Traverse, che partendo da un destino apparentemente segnato tra le montagne e le miniere del Colorado, si ritroverà sparsa per il mondo a percorrere quello che al lettore appare come l'infinito spettro delle possibilità: incontrandosi, perdendosi, tradendosi e rimanendo fedeli fino all'ultimo alla memoria della loro origine. Ma i quattro fratelli Traverse non sono i soli ad animare il romanzo. Tra le sue pagine si muovono decine di personaggi (se volete un consiglio, segnateveli man mano che li incontrate, potreste trovarlo utile per non perdere il filo) poco inclini alla sopravvivenza personale (quasi tutti), perennemente sull'orlo del baratro (ognuno di loro), tutti impegnati in una battaglia interminabile per liberarsi dal peso dei loro padri cercando nel frattempo di vivere al meglio il tempo che gli resta, lottando una guerra persa in partenza contro il giorno, contro il tempo, contro il potere, contro la morte.
I personaggi di Pynchon sono incapaci di stare fermi, il loro è un movimento entropico inarrestabile, che li porta dal Colorado alla Siberia, da Gottinga a Londra a Venezia a Parigi, dai deserti dell'Asia centrale al Messico infuocato, da Chicago ai Balcani. E ognuno di questi luoghi diventa vivo e vero più di quanto avrei mai immaginato fosse possibile. Insieme agli spazi fisici che fanno da sfondo all'azione è difficile non trovare assolutamente credibili anche le invenzioni più immaginifiche che costellano Contro il giorno: se non dubitiamo dell'evento di Tunguska come possiamo non credere al tunnel che attraversa il pianeta da un polo all'altro? Se del genio di Tesla sono pieni i testi più disparati, è difficile avere qualche dimestichezza con termini come quaternioni o vettoristi, come inestricabili sono realtà e fantasia quando entrano in gioco i VATI, la ricerca di Shambala e compagnia esoterica assortita. Ma allora dove situare il confine tra la Storia (delle lotte operaie americane, delle rivoluzioni messicane, dei dibattiti scientifici ottocenteschi) e l'invenzione romanzesca (il viaggio nel tempo, le meraviglie elettriche, il carico inquietante di quella nave che risale la corrente…)?
Di nuovo tocca tirare in ballo l'anarchia, compositiva questa volta, di cui Pynchon fa sfoggio, tanto che nel corso della lettura è impossibile rimanere legati a un codice, a un genere, a una regola, che non sia quella della creatività, insieme sfrenata e rigorosa, e della compassione che trascina il romanzo.
Il simbolo dell'intreccio tra Storia e romanzo sono senza dubbio i Compari del Caos, incredibile compagine di giovani aeronauti, protagonisti di mille avventure da romanzo d'appendice (tutte consultabili nelle biblioteche più fornite), che da entità fantastica al servizio di qualche misteriosa agenzia governativa si emancipano da irrealtà e potere per viaggiare libera nei cieli di una Terra terribilmente familiare.
Pynchon rende reale, realissimo, il viaggio meraviglioso dei Compari del Caos e trasforma invece nel più pazzesco romanzo d'avventure le vicissitudini della famiglia Traverse a spasso per il mondo. Usa tutte le chiavi del mazzo narrativo per creare un'opera totale in cui l'immaginazione si mescola con la storia, il dramma con la commedia, il tragico con il comico, la scienza con il pop, la politica con la geografia. Uno spazio da cui sono banditi i sogni, in cui personaggi sono troppo occupati a vivere e pensare, a calcolare e ricercare, a viaggiare e sopravvivere per permettersi qualche illusione sul destino che li attende.
Dalla mistica della dinamite a Shambala, dai viaggi nel tempo (ehi, il futuro non offre molte speranze!) alla fuga nell'aetere, dalla matematica estrema all'esoterismo, dalle macchine di Tesla alla rivoluzione, la fine è certa, ma lunga la strada c'è di che divertirsi, cercando verità, giustizia e amore.
In chiusura è doveroso dare il giusto riconoscimento a Massimo Bocchiola, che di Contro il giorno è il traduttore italiano. Non oso immaginare la fatica che deve comportare tradurre un autore come Thomas Pynchon, ma da quel che ho letto direi che ha fatto davvero un ottimo lavoro.
…
17 febbraio 2010
Non c'è più il futuro di una volta.
OK. a quanto pare il film di maggior successo in tutta la storia del mondo è un film di fantascienza.
A questa constatazione ne dovrebbe seguire logicamente che la fantascienza sia qualcosa che permea diffusamente la cultura popolare. Un ulteriore passettino e dovremmo arrivare a concludere che essendo la fantascienza un genere eminentemente letterario, con tutti gli eventuali sviluppi multimediali che seguono a cascata, tale genere dovrebbe ritrovarsi ottimamente rappresentato anche tra gli scaffali. Bene. Fatevi un giro in libreria e poi tornate qua. Bella la logica, eh?
Come? No, non preoccupatevi, non ho intenzione di ripartire con l'ennesima filippica sul negletto destino della fantascienza libraria. Tanto, a che servirebbe?
Mi piacerebbe piuttosto provare a capire come mai se da un lato la fantascienza trionfa incontrastata al botteghino, dall'altra fa una fatica bestia a farsi accettare dal pubblico dei lettori.
Oppure, detto in un altro modo: cos'hanno di così diverso le proposte fantascientifiche cinematografico/televisive da quelle letterarie?
Iniziamo da Avatar. La mia tesi è che, nonostante l'indubbia meraviglia e il solido substrato (fanta)scientifico, Avatar sia un prodotto fondamentalmente innocuo, decisamente consolatorio, profondamente conservatore.
Lo spettatore si diverte - io mi sono divertito un sacco - ma viene coinvolto solo superficialmente, si becca la sua bella razione di meraviglia senza turbamenti, si gode il suo ruolo totalmente passivo. Sgombriamo il capo da qualsiasi equivoco: non c'è niente di male in un film come questo, ed è evidente che stante la perfezione tecnica del prodotto, un film del genere ha tutte le carte in regola per piacere alla stragrande maggioranza del pubblico.
Ma Avatar piace così tanto perché è tecnicamente perfetto o perché è così rassicurante?
Prendiamo un esempio diverso e vediamo se riusciamo ad addomesticarlo abbastanza da fargli dire quello che vogliamo. Life on Mars è una produzione televisiva inglese che grazie all'approccio fantascientifico riesce a sopperire abilmente ai cliché narrativi ormai desueti della solita serie poliziesca, e per questo spicca brillante dalla massa di prodotti analoghi che quotidianamente lotta per trovare un suo pubblico.
A me Life on Mars è piaciuta soprattutto per la ricostruzione d'epoca (per chi non ne avesse mai sentito parlare: un poliziotto inglese si risveglia dopo un incidente nella Manchester del 1973, e cerca di capire cosa gli è successo: se sta sognando, se ha viaggiato nel tempo, se è pazzo) e per l'inquietudine che riesce a trasmettere. Molto meno riuscite - o meglio, già viste un milione di volte - le storie poliziesche che costituiscono lo scheletro di ogni singolo episodio.
Ma Life on Mars colpisce soprattutto per una caratteristica precisa che distingue la serie, ovvero lo scontro programmatico, continuo e insistente tra il punto di vista di Sam Tyler, poliziotto illuminato del 2006, e quello dell'ispettore capo Gene Hunt, personaggio che riassume in sé tutti gli aspetti più beceri del mestiere di sbirro e che rappresenta in quanto tale lo spirito grezzo del 1973. Gli sceneggiatori esaltano questo aspetto della vicenda tanto da rendere lo scontro culturale temporale il vero nucleo della serie.
Quello che emerge è un'atmosfera fortemente nostalgica che nel corso delle varie puntate è portata alle estreme conseguenze, fino ad arrivare all'indiscutibile conclusione che in fondo nel 1973 non si stava poi male, con l'idea evidentemente vincente - dopotutto cosa sceglie Sam Tyler? - che il passato sia più semplice e vivibile, in definitiva migliore, del nostro presente.
Non male per una serie di fantascienza, non trovate?
Avatar e Life on Mars rappresentano i due estremi dell'offerta fantascientifica odierna per il pubblico televisivo e cinematografico, eppure a me non paiono poi così lontani.
Entrambi propugnano più o meno esplicitamente un'idea del passato come periodo decisamente preferibile al presente, per non parlare del futuro; entrambi coccolano lo spettatore fornendogli continue conferme di come una vita più semplice, anche se magari brutale, ops… avventurosa, e selvaggia sia preferibile alla complessità disumanizzante della quotidianità; entrambi suggeriscono che la tecnologia è il male e ci condurrà al disastro.
Che questo tipo di messaggio venga veicolato attraverso una rappresentazione che adotta in maniera esemplare i moduli narrativi fantascientifici è piuttosto paradossale, ma spiega altrettanto bene la distanza che c'è tra la fantascienza visiva e quella letteraria. Con questo non voglio dire che romanzi e racconti di fantascienza siano immuni da certe posizioni, quanto piuttosto sottolineare come le caratteristiche precipue di un genere non sono sovrapponibili ai motivi per cui questo ha o meno successo. Motivi che dipendono molto di più dalla capacità di annusare l'aria che tira (che lo si faccia consciamente o meno) e dal proporre un prodotto perfettamente calibrato sulle esigenze del consumatore che dall'abilità del dato autore di comporre storie originali, stimolanti o sorprendenti.
(che poi l'aria che tira puzzi da schifo, o che le aspettative del pubblico debbano in qualche modo essere sovvertite, beh… questi sono evidentemente problemi miei.)
…
A questa constatazione ne dovrebbe seguire logicamente che la fantascienza sia qualcosa che permea diffusamente la cultura popolare. Un ulteriore passettino e dovremmo arrivare a concludere che essendo la fantascienza un genere eminentemente letterario, con tutti gli eventuali sviluppi multimediali che seguono a cascata, tale genere dovrebbe ritrovarsi ottimamente rappresentato anche tra gli scaffali. Bene. Fatevi un giro in libreria e poi tornate qua. Bella la logica, eh?
Come? No, non preoccupatevi, non ho intenzione di ripartire con l'ennesima filippica sul negletto destino della fantascienza libraria. Tanto, a che servirebbe?
Mi piacerebbe piuttosto provare a capire come mai se da un lato la fantascienza trionfa incontrastata al botteghino, dall'altra fa una fatica bestia a farsi accettare dal pubblico dei lettori.
Oppure, detto in un altro modo: cos'hanno di così diverso le proposte fantascientifiche cinematografico/televisive da quelle letterarie?
Iniziamo da Avatar. La mia tesi è che, nonostante l'indubbia meraviglia e il solido substrato (fanta)scientifico, Avatar sia un prodotto fondamentalmente innocuo, decisamente consolatorio, profondamente conservatore.
Lo spettatore si diverte - io mi sono divertito un sacco - ma viene coinvolto solo superficialmente, si becca la sua bella razione di meraviglia senza turbamenti, si gode il suo ruolo totalmente passivo. Sgombriamo il capo da qualsiasi equivoco: non c'è niente di male in un film come questo, ed è evidente che stante la perfezione tecnica del prodotto, un film del genere ha tutte le carte in regola per piacere alla stragrande maggioranza del pubblico.
Ma Avatar piace così tanto perché è tecnicamente perfetto o perché è così rassicurante?
Prendiamo un esempio diverso e vediamo se riusciamo ad addomesticarlo abbastanza da fargli dire quello che vogliamo. Life on Mars è una produzione televisiva inglese che grazie all'approccio fantascientifico riesce a sopperire abilmente ai cliché narrativi ormai desueti della solita serie poliziesca, e per questo spicca brillante dalla massa di prodotti analoghi che quotidianamente lotta per trovare un suo pubblico.
A me Life on Mars è piaciuta soprattutto per la ricostruzione d'epoca (per chi non ne avesse mai sentito parlare: un poliziotto inglese si risveglia dopo un incidente nella Manchester del 1973, e cerca di capire cosa gli è successo: se sta sognando, se ha viaggiato nel tempo, se è pazzo) e per l'inquietudine che riesce a trasmettere. Molto meno riuscite - o meglio, già viste un milione di volte - le storie poliziesche che costituiscono lo scheletro di ogni singolo episodio.
Ma Life on Mars colpisce soprattutto per una caratteristica precisa che distingue la serie, ovvero lo scontro programmatico, continuo e insistente tra il punto di vista di Sam Tyler, poliziotto illuminato del 2006, e quello dell'ispettore capo Gene Hunt, personaggio che riassume in sé tutti gli aspetti più beceri del mestiere di sbirro e che rappresenta in quanto tale lo spirito grezzo del 1973. Gli sceneggiatori esaltano questo aspetto della vicenda tanto da rendere lo scontro culturale temporale il vero nucleo della serie.
Quello che emerge è un'atmosfera fortemente nostalgica che nel corso delle varie puntate è portata alle estreme conseguenze, fino ad arrivare all'indiscutibile conclusione che in fondo nel 1973 non si stava poi male, con l'idea evidentemente vincente - dopotutto cosa sceglie Sam Tyler? - che il passato sia più semplice e vivibile, in definitiva migliore, del nostro presente.
Non male per una serie di fantascienza, non trovate?
Avatar e Life on Mars rappresentano i due estremi dell'offerta fantascientifica odierna per il pubblico televisivo e cinematografico, eppure a me non paiono poi così lontani.
Entrambi propugnano più o meno esplicitamente un'idea del passato come periodo decisamente preferibile al presente, per non parlare del futuro; entrambi coccolano lo spettatore fornendogli continue conferme di come una vita più semplice, anche se magari brutale, ops… avventurosa, e selvaggia sia preferibile alla complessità disumanizzante della quotidianità; entrambi suggeriscono che la tecnologia è il male e ci condurrà al disastro.
Che questo tipo di messaggio venga veicolato attraverso una rappresentazione che adotta in maniera esemplare i moduli narrativi fantascientifici è piuttosto paradossale, ma spiega altrettanto bene la distanza che c'è tra la fantascienza visiva e quella letteraria. Con questo non voglio dire che romanzi e racconti di fantascienza siano immuni da certe posizioni, quanto piuttosto sottolineare come le caratteristiche precipue di un genere non sono sovrapponibili ai motivi per cui questo ha o meno successo. Motivi che dipendono molto di più dalla capacità di annusare l'aria che tira (che lo si faccia consciamente o meno) e dal proporre un prodotto perfettamente calibrato sulle esigenze del consumatore che dall'abilità del dato autore di comporre storie originali, stimolanti o sorprendenti.
(che poi l'aria che tira puzzi da schifo, o che le aspettative del pubblico debbano in qualche modo essere sovvertite, beh… questi sono evidentemente problemi miei.)
…
15 febbraio 2010
Volando verso la grazia
Stanotte ho finito Contro il giorno. Ci ho messo più di due mesi, ma un libro simile vale ogni singolo minuto speso tra le sue pagine.
…
…
11 febbraio 2010
Habemus fantascienza*
Negli ultimi tempi la mia frequentazione con la fantascienza italiana non è stata delle più fortunate. La sequenza di letture poco soddisfacenti sembrava proprio non avere fine, tanto che ormai avevo quasi rinunciato a provarci che poi sembra che abbia una qualche questione personale con chi prova tuttora a scrivere fantascienza in Italia.
Ma la speranza è l'ultima a morire, e dato che mi son trovato in casa l'ennesima antologia, mi son detto proviamoci un'altra volta, che almeno i racconti sono corti, sono vari, e forse almeno un paio si salveranno.
E invece…
E invece per un attimo nel corso della lettura ho temuto di trovarmi di fronte a un capolavoro. La migliore antologia di fantascienza italiana che abbia mai avuto la fortuna di leggere.
Poi no, in effetti arrivato a fine lettura l'entusiasmo si è un po' ridimensionato, però - accidenti! - quanto mi è piaciuto questo numero di Alia!
La partenza in effetti non è delle migliori, il racconto di Danilo Arona, Il caso Bobby Fuller - Fire Walk with me ricalca un canone già letto e riletto, con un protagonista originale solo per le sue origini, ma che poi si comporta secondo tutti gli scontati cliché del caso. Il racconto non mi ha entusiasmato, ma Arona è abile a rendere credibile il classico scenario della provincia americana anni '60.
Il racconto di Vittorio Catani , Ventiquattr'ore al giorno nella terato-chimica, è il vero apripista di questo Alia, almeno per il contenuto fantascientifico che seguirà nelle pagine successive. Mi spiace solo che l'autore abbia deciso di virare verso il grottesco quella che in fondo è una storia d'amore terminale. Del resto il racconto è davvero breve, e questo scorcio di vita ai tempi della catastrofe ambientale si presta agilmente al trattamento riservatogli.
Al racconto di Catani segue la prima perla del volume, ovvero Leggere al buio di Massimo Citi. Nel racconto di Citi c'è un'ambientazione abbastanza dettagliata da risultare viva, personaggi tridimensionali che nonostante le poche pagine riescono a emergere agli occhi del lettore, istanze socio-politiche non banali e una trama che riesce ad emozionare. In più m'è parso di cogliere una qualche reminescenza del Iain Banks culturale che a me non è affatto dispiaciuta.
A seguire arriva Alessandro Defilippi con un racconto che nonostante risulti in qualche modo scontato nello sviluppo e nella conclusione si lascia comunque leggere con piacere. La qualità migliore di A cena il giorno dei morti sta probabilmente nello stile sopraffino di scrittura del suo autore, che riesce a gestire al meglio la tensione crescente della sua storia fino all'appetitoso finale. E poi diciamolo, vedere le alte sfere ecclesiastiche protagoniste di un simile banchetto è sempre un piacere.
Mario Giorgi mi aveva già impressionato con Pater, il racconto contenuto nell'edizione 2007 di Alia (vedi qui), ma qui si supera. Secondo messaggio è un racconto perfetto. Solitamente i testi scritti con l'italiano di Giorgi, mi lasciano quantomeno perplesso: troppo formale e classico per suscitare un'emozione spontanea, troppo ricercato per risultare vero. Eppure il linguaggio scelto dall'autore mi pare l'unico in grado di veicolare tutto il pathos di questa storia che si muove nei dintorni del viaggio nel tempo.
Tutt'altro registro per il racconto successivo: Alla Rina di Consolata Lanza è spettacolare per la sua capacità di giocare con gli stereotipi, divertendosi un sacco nel frattempo. Forse non tutto funziona alla perfezione, che la credibilità della ragazzina protagonista va e viene nel corso del racconto. Ma alla fine il risultato è decisamente positivo: era da tempo che non leggevo una storia di BEM e fanciulle rapite, e questa è decisamente curiosa.
La meccanica dell'ambaràdan di Fabio Lastrucci si situa a metà strada tra Buzzati e Godzilla, all'incrocio tra il fantastico metafisico nostrano e quell'oscura energia sotterranea che nel mio immaginario ha partorito i mostri made in Japan. Anche questo è un racconto da segnalare per l'originalità dello sviluppo, i tipi umani coinvolti e le sorprendenti rivelazioni che lo animano. Se c'è un difetto è forse nella conclusione del racconto sempre progressivamente rimandata, che a tagliarlo di netto secondo me ne avrebbe guadagnato. Però oh… è solo un'opinione.
Blopper di Davide Mana ha tutto quel che mi piace in un racconto di fantascienza. Un protagonista con qualcosa da dire, uno scenario credibile e articolato e soprattutto - particolare non indifferente trattandosi di fantascienza italiana - una trama complessa. In Blopper si passa nel giro di poche pagine dalla caccia alla balena nell'oceano Atlantico allo spazio profondo, dalla situazione politica sudamericana alle frontiere legislative del postumano, con una storia principale che si incrocia con un nugolo di vicende laterali che invece di disperdere l'attenzione del lettore la concentrano nella costruzione di un mondo decisamente interessante. Unico difetto un finale che chiede forse troppo all'interpretazione del lettore. Io comunque fantascienza di questo livello la vorrei leggere tutti i giorni! (capito, Davide?)
Il racconto di Angelo Marenzana è l'unico che non ho proprio digerito. L'istinto dominatore è pesante ben oltre le cupe atmosfere in cui ci immerge l'autore. La mia impressione è che sia mancata una chiara idee di cosa voler far dire a una storia che alla fine si avvita su se stessa senza un vero punto di interesse.
Elvezio Sciallis è insieme a Davide Mana, Vittorio Catani e Massimo Soumaré uno dei pochi autori che ho avuto il piacere di conoscere tra quelli riuniti in questa antologia (beh… in realtà ho conosciuto anche Massimo Citi e Silvia Treves ma dal premio Omelas ad oggi son passati secoli…). Questa però è la prima volta che inciampo in un suo racconto, che di solito lo apprezzo per le recensioni e gli approfondimenti di Malpertuis. Tutta la vostra base sono appartenere a noi mi ha dato l'idea di un racconto ottimamente partorito ma cresciuto in maniera diseguale. Il problema è un eccesso di nerditudine che mal si coniuga con il carattere dei protagonisti e che rischia di travolgere l'ottima atmosfera tra il demenziale e il drammatico creata dall'autore. Il dialogo e l'evoluzione dei personaggi rimangono magistrali, ma l'ultima mezza pagina, beh… ecco, avrei preferito più terrore e raccapriccio (in alternativa un taglio secco e via).
Storia romantica di code e di canini di Massimo Soumaré è una buona storia che si dipana melanconica tra note esotiche e romantiche in un Giappone al contempo realissimo e pieno di meraviglie. Non so quale sia il motivo preciso per cui non mi ha particolarmente colpito: forse il tono sommesso o l'eccessiva dolcezza. O forse dei mostri così buoni mi sono risultati un po' troppo difficili da accettare.
A chiudere questo Alia una delle più piacevoli sorprese del volume. I mondi di là di Silvia Treves è un racconto che nonostante l'intento programmaticamente politico sfugge dal mero didascalismo grazie all'ottima caratterizzazione di personaggi e ambiente. Il panorama è quello claustrofobico di un asteroide minerario che racchiude la sua piccola comunità di tecnici e operai, il clima quello delle lotte sindacali di fronte a una minaccia finanziaria, la risposta è l'unione creativa della diversità circostante. Riassunto così il racconto non suona forse molto stimolante, ma fortunatamente il punto di vista parziale e limitato scelto dall'autrice evita il polpettone socio-politico offrendo al lettore una storia di rinascita e rivoluzione degna della migliore fantascienza anglosassone.
Arrivati a fine lettura bisogna constatare che nonostante i numerosi passi falsi la fantascienza italiana è viva e combatte insieme a noi. La sua è una lotta di retroguardia fatta di piccole realtà editoriali, di singoli appassionati e numeri microscopici. Ma questa fantascienza c'è, basta cercarla.
Alia lo trovate sul sito dell'editore. I meccanismi per l'acquisto sono un po' macchinosi, per questo motivo io ho preferito comprarla sul Delos Store.
* ho scoperto che in realtà "fantascienza" in latino si tradurrebbe "mythistoriae rerum futurarum" (fonte vicipaedia) però mi sembrava un po' troppo criptico per usarlo nel titolo.
…
Ma la speranza è l'ultima a morire, e dato che mi son trovato in casa l'ennesima antologia, mi son detto proviamoci un'altra volta, che almeno i racconti sono corti, sono vari, e forse almeno un paio si salveranno.
E invece…
E invece per un attimo nel corso della lettura ho temuto di trovarmi di fronte a un capolavoro. La migliore antologia di fantascienza italiana che abbia mai avuto la fortuna di leggere.
Poi no, in effetti arrivato a fine lettura l'entusiasmo si è un po' ridimensionato, però - accidenti! - quanto mi è piaciuto questo numero di Alia!
La partenza in effetti non è delle migliori, il racconto di Danilo Arona, Il caso Bobby Fuller - Fire Walk with me ricalca un canone già letto e riletto, con un protagonista originale solo per le sue origini, ma che poi si comporta secondo tutti gli scontati cliché del caso. Il racconto non mi ha entusiasmato, ma Arona è abile a rendere credibile il classico scenario della provincia americana anni '60.
Il racconto di Vittorio Catani , Ventiquattr'ore al giorno nella terato-chimica, è il vero apripista di questo Alia, almeno per il contenuto fantascientifico che seguirà nelle pagine successive. Mi spiace solo che l'autore abbia deciso di virare verso il grottesco quella che in fondo è una storia d'amore terminale. Del resto il racconto è davvero breve, e questo scorcio di vita ai tempi della catastrofe ambientale si presta agilmente al trattamento riservatogli.
Al racconto di Catani segue la prima perla del volume, ovvero Leggere al buio di Massimo Citi. Nel racconto di Citi c'è un'ambientazione abbastanza dettagliata da risultare viva, personaggi tridimensionali che nonostante le poche pagine riescono a emergere agli occhi del lettore, istanze socio-politiche non banali e una trama che riesce ad emozionare. In più m'è parso di cogliere una qualche reminescenza del Iain Banks culturale che a me non è affatto dispiaciuta.
A seguire arriva Alessandro Defilippi con un racconto che nonostante risulti in qualche modo scontato nello sviluppo e nella conclusione si lascia comunque leggere con piacere. La qualità migliore di A cena il giorno dei morti sta probabilmente nello stile sopraffino di scrittura del suo autore, che riesce a gestire al meglio la tensione crescente della sua storia fino all'appetitoso finale. E poi diciamolo, vedere le alte sfere ecclesiastiche protagoniste di un simile banchetto è sempre un piacere.
Mario Giorgi mi aveva già impressionato con Pater, il racconto contenuto nell'edizione 2007 di Alia (vedi qui), ma qui si supera. Secondo messaggio è un racconto perfetto. Solitamente i testi scritti con l'italiano di Giorgi, mi lasciano quantomeno perplesso: troppo formale e classico per suscitare un'emozione spontanea, troppo ricercato per risultare vero. Eppure il linguaggio scelto dall'autore mi pare l'unico in grado di veicolare tutto il pathos di questa storia che si muove nei dintorni del viaggio nel tempo.
Tutt'altro registro per il racconto successivo: Alla Rina di Consolata Lanza è spettacolare per la sua capacità di giocare con gli stereotipi, divertendosi un sacco nel frattempo. Forse non tutto funziona alla perfezione, che la credibilità della ragazzina protagonista va e viene nel corso del racconto. Ma alla fine il risultato è decisamente positivo: era da tempo che non leggevo una storia di BEM e fanciulle rapite, e questa è decisamente curiosa.
La meccanica dell'ambaràdan di Fabio Lastrucci si situa a metà strada tra Buzzati e Godzilla, all'incrocio tra il fantastico metafisico nostrano e quell'oscura energia sotterranea che nel mio immaginario ha partorito i mostri made in Japan. Anche questo è un racconto da segnalare per l'originalità dello sviluppo, i tipi umani coinvolti e le sorprendenti rivelazioni che lo animano. Se c'è un difetto è forse nella conclusione del racconto sempre progressivamente rimandata, che a tagliarlo di netto secondo me ne avrebbe guadagnato. Però oh… è solo un'opinione.
Blopper di Davide Mana ha tutto quel che mi piace in un racconto di fantascienza. Un protagonista con qualcosa da dire, uno scenario credibile e articolato e soprattutto - particolare non indifferente trattandosi di fantascienza italiana - una trama complessa. In Blopper si passa nel giro di poche pagine dalla caccia alla balena nell'oceano Atlantico allo spazio profondo, dalla situazione politica sudamericana alle frontiere legislative del postumano, con una storia principale che si incrocia con un nugolo di vicende laterali che invece di disperdere l'attenzione del lettore la concentrano nella costruzione di un mondo decisamente interessante. Unico difetto un finale che chiede forse troppo all'interpretazione del lettore. Io comunque fantascienza di questo livello la vorrei leggere tutti i giorni! (capito, Davide?)
Il racconto di Angelo Marenzana è l'unico che non ho proprio digerito. L'istinto dominatore è pesante ben oltre le cupe atmosfere in cui ci immerge l'autore. La mia impressione è che sia mancata una chiara idee di cosa voler far dire a una storia che alla fine si avvita su se stessa senza un vero punto di interesse.
Elvezio Sciallis è insieme a Davide Mana, Vittorio Catani e Massimo Soumaré uno dei pochi autori che ho avuto il piacere di conoscere tra quelli riuniti in questa antologia (beh… in realtà ho conosciuto anche Massimo Citi e Silvia Treves ma dal premio Omelas ad oggi son passati secoli…). Questa però è la prima volta che inciampo in un suo racconto, che di solito lo apprezzo per le recensioni e gli approfondimenti di Malpertuis. Tutta la vostra base sono appartenere a noi mi ha dato l'idea di un racconto ottimamente partorito ma cresciuto in maniera diseguale. Il problema è un eccesso di nerditudine che mal si coniuga con il carattere dei protagonisti e che rischia di travolgere l'ottima atmosfera tra il demenziale e il drammatico creata dall'autore. Il dialogo e l'evoluzione dei personaggi rimangono magistrali, ma l'ultima mezza pagina, beh… ecco, avrei preferito più terrore e raccapriccio (in alternativa un taglio secco e via).
Storia romantica di code e di canini di Massimo Soumaré è una buona storia che si dipana melanconica tra note esotiche e romantiche in un Giappone al contempo realissimo e pieno di meraviglie. Non so quale sia il motivo preciso per cui non mi ha particolarmente colpito: forse il tono sommesso o l'eccessiva dolcezza. O forse dei mostri così buoni mi sono risultati un po' troppo difficili da accettare.
A chiudere questo Alia una delle più piacevoli sorprese del volume. I mondi di là di Silvia Treves è un racconto che nonostante l'intento programmaticamente politico sfugge dal mero didascalismo grazie all'ottima caratterizzazione di personaggi e ambiente. Il panorama è quello claustrofobico di un asteroide minerario che racchiude la sua piccola comunità di tecnici e operai, il clima quello delle lotte sindacali di fronte a una minaccia finanziaria, la risposta è l'unione creativa della diversità circostante. Riassunto così il racconto non suona forse molto stimolante, ma fortunatamente il punto di vista parziale e limitato scelto dall'autrice evita il polpettone socio-politico offrendo al lettore una storia di rinascita e rivoluzione degna della migliore fantascienza anglosassone.
Arrivati a fine lettura bisogna constatare che nonostante i numerosi passi falsi la fantascienza italiana è viva e combatte insieme a noi. La sua è una lotta di retroguardia fatta di piccole realtà editoriali, di singoli appassionati e numeri microscopici. Ma questa fantascienza c'è, basta cercarla.
Alia lo trovate sul sito dell'editore. I meccanismi per l'acquisto sono un po' macchinosi, per questo motivo io ho preferito comprarla sul Delos Store.
* ho scoperto che in realtà "fantascienza" in latino si tradurrebbe "mythistoriae rerum futurarum" (fonte vicipaedia) però mi sembrava un po' troppo criptico per usarlo nel titolo.
…
09 febbraio 2010
Letture gennaio 2010
Vittorio Catani - Il quinto principio
De Il quinto principio ho già parlato in questo post a cui vi rimando per eventuali nuovi commenti, critiche e/o discussioni.
Non azzardo ulteriori approfondimenti, che ogni parola può essere usata contro di me.
(Scherzo, eh! che come dicevo altrove tra fantascientisti ci vogliamo tutti molto bene!)
Anthony Boucher - Storie del tempo e dello spazio
Quando incappo in una di queste antologie di racconti anni '50 mi sembra sempre di ritrovare un vecchio amico. Sarà che la mia esperienza di lettore di fantascienza si è formata su testi scritti in quegli anni, ma per me leggere dei turbamenti più o meno inquietanti, più o meno fantastici della comoda vita conformista a stelleestrisce che si ritrova con una preoccupante frequenza nei racconti fantascientifici di quegli anni è una specie di ritorno a casa.
Nello specifico questi racconti di Anthony Boucher hanno tutti quel sapore di sigaro e scotch e moglie di là a preparare la cena che per me è ormai sinonimo di buona lettura nostalgica. Illuminante, forse più qui e ora che non laggiù e allora, e sempre piacevole.
Jonathan Lethem - Memorie di un artista della delusione
Capita a volte di imbattersi in autori che sembra abbiano scritto le loro cose apposta per te. Beh… io non ho praticamente nulla in comune con Jonathan Lethem eppure leggendo i saggi raccolti in questo volume - o come m'è successo leggendo La fortezza della solitudine - non posso fare a meno di ritrovare nelle sue parole e nei suoi racconti moltissime cose del mio passato.
Tra le tante occasioni di interesse e di riflessione di queste Memorie di un artista della delusione mi piace ricordare l'excursus sull'opera omnia di Philip K. Dick (che è in qualche modo esemplare di come dal ghetto fantascientifico si possa - e si debba - uscire, se non altro per dare un'occhiata al resto del mondo, senza perdere nulla dell'amore che ci lega a certi luoghi) e la voracità onnivora nei confronti di libri dischi cinema che emerge prepotente dal racconto delle vicissitudini familiari del giovane Lethem e che ha caratterizzato l'adolescenza di parecchi di noi qua fuori.
Un'ultima nota sulla bonus track del volume, ovvero il lungo pezzo appassionato, attento e disincantato sul padrino del soul. James Brown non è mai stato tra i miei soul-men preferiti, però accidenti, che razza di uomo!
Joe Haldeman - Cronomacchina accidentale
Ogni volta che mi capita per le mani un libro firmato da Joe Haldeman so già come andrà a finire. Di recente mi è successo con l'antologico Guerra eterna: Ultimo Atto o con I protomorfi: mi ritrovo a sogghignare felice tra scenari che appartengono alla fantascienza più classica ma che presi in mano da Haldeman danno un'impressione di freschezza e novità che non ti aspetteresti mai.
Cronomacchina accidentale non fa eccezione: sebbene la struttura della vicenda sia quanto di più scontato e prevedibile sia dato cercare nella fantascienza contemporanea, il talento di Haldeman riesce comunque a trasformare la lettura in un'esperienza brillante e seducente. Quante storie di viaggi nel tempo abbiamo già letto? Bene, stavolta succederà esattamente quello che vi aspettate (più o meno), con le solite puntate in futuri alternativamente accoglienti e inquietanti, con incontri fortunati, fughe precipitose e salvataggi per il rotto della cuffia e soprattutto con l'obbligatoria presenza - e risoluzione - del paradosso temporale di turno. Nonostante l'abbondanza di cliché - peraltro abilmente gestiti dall'autore - nelle peripezie del fisico Matt Fuller in giro per lo spazio tempo c'è evidentemente qualcosa capace di avvincere e appassionare il lettore. Questo qualcosa è l'indubbio talento di Haldeman nel rendere i sui personaggi assolutamente umani e comprensibili, la leggerezza e il ritmo del racconto, la capacità di infilare tra le pieghe delle sue storie qualche nota felicemente inquietante e provocatoria.
Tra gli autori capaci di rivitalizzare la buona vecchia fantascienza con cui sono cresciuto credo che Joe Haldeman sia il migliore.
…
De Il quinto principio ho già parlato in questo post a cui vi rimando per eventuali nuovi commenti, critiche e/o discussioni.
Non azzardo ulteriori approfondimenti, che ogni parola può essere usata contro di me.
(Scherzo, eh! che come dicevo altrove tra fantascientisti ci vogliamo tutti molto bene!)
Anthony Boucher - Storie del tempo e dello spazio
Quando incappo in una di queste antologie di racconti anni '50 mi sembra sempre di ritrovare un vecchio amico. Sarà che la mia esperienza di lettore di fantascienza si è formata su testi scritti in quegli anni, ma per me leggere dei turbamenti più o meno inquietanti, più o meno fantastici della comoda vita conformista a stelleestrisce che si ritrova con una preoccupante frequenza nei racconti fantascientifici di quegli anni è una specie di ritorno a casa.
Nello specifico questi racconti di Anthony Boucher hanno tutti quel sapore di sigaro e scotch e moglie di là a preparare la cena che per me è ormai sinonimo di buona lettura nostalgica. Illuminante, forse più qui e ora che non laggiù e allora, e sempre piacevole.
Jonathan Lethem - Memorie di un artista della delusione
Capita a volte di imbattersi in autori che sembra abbiano scritto le loro cose apposta per te. Beh… io non ho praticamente nulla in comune con Jonathan Lethem eppure leggendo i saggi raccolti in questo volume - o come m'è successo leggendo La fortezza della solitudine - non posso fare a meno di ritrovare nelle sue parole e nei suoi racconti moltissime cose del mio passato.
Tra le tante occasioni di interesse e di riflessione di queste Memorie di un artista della delusione mi piace ricordare l'excursus sull'opera omnia di Philip K. Dick (che è in qualche modo esemplare di come dal ghetto fantascientifico si possa - e si debba - uscire, se non altro per dare un'occhiata al resto del mondo, senza perdere nulla dell'amore che ci lega a certi luoghi) e la voracità onnivora nei confronti di libri dischi cinema che emerge prepotente dal racconto delle vicissitudini familiari del giovane Lethem e che ha caratterizzato l'adolescenza di parecchi di noi qua fuori.
Un'ultima nota sulla bonus track del volume, ovvero il lungo pezzo appassionato, attento e disincantato sul padrino del soul. James Brown non è mai stato tra i miei soul-men preferiti, però accidenti, che razza di uomo!
Joe Haldeman - Cronomacchina accidentale
Ogni volta che mi capita per le mani un libro firmato da Joe Haldeman so già come andrà a finire. Di recente mi è successo con l'antologico Guerra eterna: Ultimo Atto o con I protomorfi: mi ritrovo a sogghignare felice tra scenari che appartengono alla fantascienza più classica ma che presi in mano da Haldeman danno un'impressione di freschezza e novità che non ti aspetteresti mai.
Cronomacchina accidentale non fa eccezione: sebbene la struttura della vicenda sia quanto di più scontato e prevedibile sia dato cercare nella fantascienza contemporanea, il talento di Haldeman riesce comunque a trasformare la lettura in un'esperienza brillante e seducente. Quante storie di viaggi nel tempo abbiamo già letto? Bene, stavolta succederà esattamente quello che vi aspettate (più o meno), con le solite puntate in futuri alternativamente accoglienti e inquietanti, con incontri fortunati, fughe precipitose e salvataggi per il rotto della cuffia e soprattutto con l'obbligatoria presenza - e risoluzione - del paradosso temporale di turno. Nonostante l'abbondanza di cliché - peraltro abilmente gestiti dall'autore - nelle peripezie del fisico Matt Fuller in giro per lo spazio tempo c'è evidentemente qualcosa capace di avvincere e appassionare il lettore. Questo qualcosa è l'indubbio talento di Haldeman nel rendere i sui personaggi assolutamente umani e comprensibili, la leggerezza e il ritmo del racconto, la capacità di infilare tra le pieghe delle sue storie qualche nota felicemente inquietante e provocatoria.
Tra gli autori capaci di rivitalizzare la buona vecchia fantascienza con cui sono cresciuto credo che Joe Haldeman sia il migliore.
…
04 febbraio 2010
Sawyer vs. Tonani
Questo post nasce dalla costola di una discussione, lunga, accesa e spigolosa, nata dalle mie osservazioni su Il quinto principio e proseguita sulla Mailing List di Fantascienza, avente come nucleo del contendere la liceità o meno della lettura parziale di un'opera per giudicarla, la soggettività e l'oggettività della critica letteraria, il presunto pregiudizio del commentatore nei riguardi della fantascienza italiana.
A margine della discussione c'è stata anche la seguente osservazione:
"Forse ricorderai che quando si parlava dell'ultimo Tonani avevo tirato fuori la genesi della specie di Sawyer. Non è che sia ossessionato da Sawyer, ma davvero mi sembra un caso di scuola: lì ci sono tutti, ma proprio tutti, i difetti che la vulgata attribuisce alla sf italiana. Personaggi presi pari pari dai luoghi comuni, trama tenuta insieme con lo sputo, falle logiche da far rizzare i capelli e via di seguito. Eppure nessuno si è scandalizzato, anzi, non se ne è accorto proprio nessuno."
A cui io rispondevo:
"A me Sawyer era piaciuto. La sua è proprio quel genere di fantascienza "classica" che qua in italia non è mai mai nato. (l'esempio più prossimo è forse Alberto Cola - almeno le prime cose che ho letto: plot potente, personaggi immediatamente riconoscibili, poche menate e via che si va…).
Forse sarebbe interessante annotare quali sono le differenze nella mia percezione tra un romanzo di Sawyer e quelli, chessò, di Dario Tonani o di Vittorio Catani o di Giovanni De Matteo."
Questo post cerca di evidenziare le ragioni per cui il mio personalissimo giudizio sulla trilogia Neanderthaliana di Robert J. Sawyer (La genesi della specie, Fuga dal pianeta degli umani, Origine dell'ibrido ) è in definitiva migliore di quello formulato dopo aver letto L'algoritmo bianco di Dario Tonani.
La prima cosa da dire è che il sottoscritto potrebbe fare anche a meno della fantascienza di Sawyer: i suoi sono romanzi elementari per struttura, stile, speculazione. In nessuno dei libri di Sawyer si raggiungo quelle vette dell'immaginazione o della scrittura che ti rendono memorabile un romanzo. Ma Sawyer non è un dilettante, è un ottimo professionista che rimedia con lo studio, la preparazione e il metodo a quelle che potrebbero apparire come serie mancanze.
In questo senso leggere Sawyer non è mai una perdita di tempo. Nella sua trilogia Neanderthaliana non ci sono evidenti sciocchezze, non ci sono personaggi incoerenti o svolte palesemente improbabili. C'è l'invenzione e la speculazione che ci si attende da una buona storia di fantascienza classica, in cui date certe premesse il resto dovrebbe scorrere liscio come l'olio con magari qualche impennata nel ritmo per quel paio di svolte più o meno sorprendenti nel plot. L'originalità del progetto non è dovuta a chissà quale nuova idea, semmai all'ottimo world-building, così come la lettura non è resa avvincente da improvvisi scarti narrativi, quanto piuttosto dalla presenza di personaggi ben delineati e immediatamente identificabili.
In lista mi è stato fatto presente che non tutto nelle storie di Sawyer funziona a puntino, che ci sarebbero personaggi improbabili e avvenimenti realisticamente poco credibili. Dal mio punto di vista posso dire che se è vero che alcuni personaggi compiono azioni non propriamente consone alla situazione in cui sono calati, questi episodi non mi hanno dato eccessivo fastidio, un po' per la consapevolezza della realtà romanzesca in cui si ritrovano ad agire, un po' perché non hanno fatto saltare la soglia critica alla mia sospensione dell'incredulità.
Stessa cosa potrei dire per la questione delle conseguenze poco credibili ai fatti che avvengono nel romanzo. Ma dovrei anche precisare che per me il cuore della trilogia stava nella creazione della civiltà Neanderthaliana della Terra parallela. Il fatto che il resto della vicenda fosse costretto a piegarsi in qualche modo a quella particolare invenzione narrativa era scritto tra le righe nel patto stipulato tra lettore (questo lettore!) e l'autore del romanzo.
Discorso opposto per Dario Tonani. La scrittura dell'autore italiano è incomparabilmente superiore a quella del canadese Sawyer sia per la ricchezza delle suggestioni che emergono dalle sue pagine, sia per la resa cromatica unica del mondo in cui immerge le sue storie.
Riconoscendo questa superiorità stilistica io mi aspetto la stessa qualità anche nelle componenti prettamente narrative dei suoi romanzi: nella struttura del plot, nella creazione dei personaggi, nelle invenzioni che caratterizzano fantascientificamente le sue storie.
Se per quest'ultimo aspetto L'algoritmo bianco regge tranquillamente il confronto con i romanzi di Sawyer, la struttura del plot e soprattutto i personaggi non sono mai all'altezza dello scenario che Dario Tonani dispiega come elemento fondante la sua fantascienza. Non lo sono per due dettagli fondamentali: mancanza di profondità e coerenza.
I personaggi di Robert J. Sawyer risultano immediatamente riconoscibili. Questo significa che il lettore non fa nessuna fatica a seguirli e a immedesimarsi nei loro panni, di conseguenza nel corso della lettura non si generano mai confusioni di ruoli o sovrapposizione d'intenti. Certo, nessun personaggio rimane indelebilmente impresso nella memoria, Ponter Bondit non è un Elethiomel o un Prabir, ma tutti risultano egualmente vivi e reali agli occhi del lettore. Ne L'algoritmo bianco, al contrario, motivazioni e personalità del protagonista risultano parecchio vaghe se non palesemente incoerenti e quasi tutti i comprimari si perdono irrimediabilmente nello sfondo.
Un'altra differenza sostanziale tra i due autori sta nel peso della componente speculativa all'interno dei rispettivi romanzi. Se Tonani è superbo nella creazione e nella descrizione del suo mondo fantastico, il ruolo riservato all'estrapolazione speculativa della realtà fittizia in cui si svolge l'azione è lasciato più all'interpretazione del lettore, alla sua suggestione, piuttosto che all'intervento esplicito di una componente informativa. Questo non è un difetto, stante appunto la padronanza che ha l'autore delle capacità evocative della sua scrittura. D'altro canto Sawyer rimedia abilmente ai suoi limiti compositivi riuscendo a infilare nel racconto una messe di informazioni sorprendenti, realistiche e particolareggiate che ben difficilmente è riscontrabile in un normale romanzo di fantascienza italiana (a me è rimasta particolarmente impressa la digressione sulla presunta superiorità etica di una società di cacciatori/raccoglitori rispetto a quella che siamo abituati a ritenere più evoluta basata sull'agricoltura/allevamento, ma è solo una delle tante suggestioni (fanta)scientifiche che arricchiscono la trilogia).
La quantità d'informazione serve da un lato a mantenere vivo l'interesse del lettore anche in mancanza di vere svolte narrative, dall'altro lo rende complice e partecipe del percorso di scoperta che compie man mano che procede nel romanzo. L'algoritmo bianco fondandosi su un'unica linea narrativa e mancando di un valido contrappeso informativo avrebbe la possibilità di imporsi al lettore per la profondità che ci attenderebbe dalla scrittura di Tonani. Profondità che però svanisce una volta che lo sguardo del lettore passa dal contesto generale (in sostanza ambiente & idee di base) al particolare (personaggi, relazioni, svolte narrative).
In definitiva mi pare di poter dire che il giudizio espresso sui romanzi presi in esame è opposto rispetto alla mia opinione sulle capacità autoriali dei due scrittori. Se la lettura de L'algoritmo bianco mi ha soddisfatto di meno di quella dei romanzi di Sawyer è perché da un autore come Dario Tonani mi aspetto molto di più di quel che ritrovo nella fantascienza classica del canadese.
Magari mi sbaglio, ma se c'è qualcuno con le potenzialità per scrivere un grande romanzo, un'opera che rimanga impressa indelebilmente nel mio immaginario, beh… questo qualcuno assomiglia di certo più a Dario Tonani che a Robert J. Sawyer.
…
A margine della discussione c'è stata anche la seguente osservazione:
"Forse ricorderai che quando si parlava dell'ultimo Tonani avevo tirato fuori la genesi della specie di Sawyer. Non è che sia ossessionato da Sawyer, ma davvero mi sembra un caso di scuola: lì ci sono tutti, ma proprio tutti, i difetti che la vulgata attribuisce alla sf italiana. Personaggi presi pari pari dai luoghi comuni, trama tenuta insieme con lo sputo, falle logiche da far rizzare i capelli e via di seguito. Eppure nessuno si è scandalizzato, anzi, non se ne è accorto proprio nessuno."
A cui io rispondevo:
"A me Sawyer era piaciuto. La sua è proprio quel genere di fantascienza "classica" che qua in italia non è mai mai nato. (l'esempio più prossimo è forse Alberto Cola - almeno le prime cose che ho letto: plot potente, personaggi immediatamente riconoscibili, poche menate e via che si va…).
Forse sarebbe interessante annotare quali sono le differenze nella mia percezione tra un romanzo di Sawyer e quelli, chessò, di Dario Tonani o di Vittorio Catani o di Giovanni De Matteo."
Questo post cerca di evidenziare le ragioni per cui il mio personalissimo giudizio sulla trilogia Neanderthaliana di Robert J. Sawyer (La genesi della specie, Fuga dal pianeta degli umani, Origine dell'ibrido ) è in definitiva migliore di quello formulato dopo aver letto L'algoritmo bianco di Dario Tonani.
La prima cosa da dire è che il sottoscritto potrebbe fare anche a meno della fantascienza di Sawyer: i suoi sono romanzi elementari per struttura, stile, speculazione. In nessuno dei libri di Sawyer si raggiungo quelle vette dell'immaginazione o della scrittura che ti rendono memorabile un romanzo. Ma Sawyer non è un dilettante, è un ottimo professionista che rimedia con lo studio, la preparazione e il metodo a quelle che potrebbero apparire come serie mancanze.
In questo senso leggere Sawyer non è mai una perdita di tempo. Nella sua trilogia Neanderthaliana non ci sono evidenti sciocchezze, non ci sono personaggi incoerenti o svolte palesemente improbabili. C'è l'invenzione e la speculazione che ci si attende da una buona storia di fantascienza classica, in cui date certe premesse il resto dovrebbe scorrere liscio come l'olio con magari qualche impennata nel ritmo per quel paio di svolte più o meno sorprendenti nel plot. L'originalità del progetto non è dovuta a chissà quale nuova idea, semmai all'ottimo world-building, così come la lettura non è resa avvincente da improvvisi scarti narrativi, quanto piuttosto dalla presenza di personaggi ben delineati e immediatamente identificabili.
In lista mi è stato fatto presente che non tutto nelle storie di Sawyer funziona a puntino, che ci sarebbero personaggi improbabili e avvenimenti realisticamente poco credibili. Dal mio punto di vista posso dire che se è vero che alcuni personaggi compiono azioni non propriamente consone alla situazione in cui sono calati, questi episodi non mi hanno dato eccessivo fastidio, un po' per la consapevolezza della realtà romanzesca in cui si ritrovano ad agire, un po' perché non hanno fatto saltare la soglia critica alla mia sospensione dell'incredulità.
Stessa cosa potrei dire per la questione delle conseguenze poco credibili ai fatti che avvengono nel romanzo. Ma dovrei anche precisare che per me il cuore della trilogia stava nella creazione della civiltà Neanderthaliana della Terra parallela. Il fatto che il resto della vicenda fosse costretto a piegarsi in qualche modo a quella particolare invenzione narrativa era scritto tra le righe nel patto stipulato tra lettore (questo lettore!) e l'autore del romanzo.
Discorso opposto per Dario Tonani. La scrittura dell'autore italiano è incomparabilmente superiore a quella del canadese Sawyer sia per la ricchezza delle suggestioni che emergono dalle sue pagine, sia per la resa cromatica unica del mondo in cui immerge le sue storie.
Riconoscendo questa superiorità stilistica io mi aspetto la stessa qualità anche nelle componenti prettamente narrative dei suoi romanzi: nella struttura del plot, nella creazione dei personaggi, nelle invenzioni che caratterizzano fantascientificamente le sue storie.
Se per quest'ultimo aspetto L'algoritmo bianco regge tranquillamente il confronto con i romanzi di Sawyer, la struttura del plot e soprattutto i personaggi non sono mai all'altezza dello scenario che Dario Tonani dispiega come elemento fondante la sua fantascienza. Non lo sono per due dettagli fondamentali: mancanza di profondità e coerenza.
I personaggi di Robert J. Sawyer risultano immediatamente riconoscibili. Questo significa che il lettore non fa nessuna fatica a seguirli e a immedesimarsi nei loro panni, di conseguenza nel corso della lettura non si generano mai confusioni di ruoli o sovrapposizione d'intenti. Certo, nessun personaggio rimane indelebilmente impresso nella memoria, Ponter Bondit non è un Elethiomel o un Prabir, ma tutti risultano egualmente vivi e reali agli occhi del lettore. Ne L'algoritmo bianco, al contrario, motivazioni e personalità del protagonista risultano parecchio vaghe se non palesemente incoerenti e quasi tutti i comprimari si perdono irrimediabilmente nello sfondo.
Un'altra differenza sostanziale tra i due autori sta nel peso della componente speculativa all'interno dei rispettivi romanzi. Se Tonani è superbo nella creazione e nella descrizione del suo mondo fantastico, il ruolo riservato all'estrapolazione speculativa della realtà fittizia in cui si svolge l'azione è lasciato più all'interpretazione del lettore, alla sua suggestione, piuttosto che all'intervento esplicito di una componente informativa. Questo non è un difetto, stante appunto la padronanza che ha l'autore delle capacità evocative della sua scrittura. D'altro canto Sawyer rimedia abilmente ai suoi limiti compositivi riuscendo a infilare nel racconto una messe di informazioni sorprendenti, realistiche e particolareggiate che ben difficilmente è riscontrabile in un normale romanzo di fantascienza italiana (a me è rimasta particolarmente impressa la digressione sulla presunta superiorità etica di una società di cacciatori/raccoglitori rispetto a quella che siamo abituati a ritenere più evoluta basata sull'agricoltura/allevamento, ma è solo una delle tante suggestioni (fanta)scientifiche che arricchiscono la trilogia).
La quantità d'informazione serve da un lato a mantenere vivo l'interesse del lettore anche in mancanza di vere svolte narrative, dall'altro lo rende complice e partecipe del percorso di scoperta che compie man mano che procede nel romanzo. L'algoritmo bianco fondandosi su un'unica linea narrativa e mancando di un valido contrappeso informativo avrebbe la possibilità di imporsi al lettore per la profondità che ci attenderebbe dalla scrittura di Tonani. Profondità che però svanisce una volta che lo sguardo del lettore passa dal contesto generale (in sostanza ambiente & idee di base) al particolare (personaggi, relazioni, svolte narrative).
In definitiva mi pare di poter dire che il giudizio espresso sui romanzi presi in esame è opposto rispetto alla mia opinione sulle capacità autoriali dei due scrittori. Se la lettura de L'algoritmo bianco mi ha soddisfatto di meno di quella dei romanzi di Sawyer è perché da un autore come Dario Tonani mi aspetto molto di più di quel che ritrovo nella fantascienza classica del canadese.
Magari mi sbaglio, ma se c'è qualcuno con le potenzialità per scrivere un grande romanzo, un'opera che rimanga impressa indelebilmente nel mio immaginario, beh… questo qualcuno assomiglia di certo più a Dario Tonani che a Robert J. Sawyer.
…
Iscriviti a:
Post (Atom)